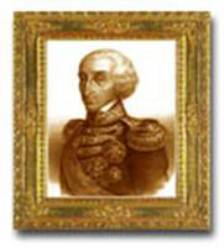|
CASATA DEI CONTI – RE DI BARCELLONA
|
|
|
|
|
1.
|
Giacomo II il Giusto
|
1267
|
1327
|
1297
|
1327
|
2.
|
Alfonso IV
il Benigno
|
1299
|
1336
|
1327
|
1336
|
3.
|
Pietro IV il
Cerimonioso
|
1319
|
1387
|
1336
|
1387
|
4.
|
Giovanni I il Cacciatore
|
1350
|
1396
|
1387
|
1396
|
5.
|
Martino il
Vecchio
|
1356
|
1410
|
1396
|
1410
|
CASATA DEI
TRASTAMARA DI CASTIGLIA
|
|
|
|
|
6.
|
Ferdinando I di Antequera
|
1379
|
1416
|
1412
|
1416
|
7.
|
Alfonso V il Magnanimo
|
1396
|
1458
|
1416
|
1458
|
8.
|
Giovanni II il Senza Fede
|
1398
|
1479
|
1458
|
1479
|
9.
|
Ferdinando II il Cattolico
|
1452
|
1516
|
1479
|
1516
|
CASATA DEGLI
ASBURGO DI SPAGNA
|
|
|
|
|
10.
|
Carlo I di Spagna – V Imperatore
|
1500
|
1558
|
1516
|
1556
|
11.
|
Filippo II Re di Spagna
|
1527
|
1598
|
1556
|
1598
|
12.
|
Filippo III Re di Spagna
|
1578
|
1621
|
1598
|
1621
|
13.
|
Filippo IV Re di Spagna
|
1605
|
1665
|
1621
|
1665
|
14.
|
Carlo II - V Re di Spagna
|
1661
|
1700
|
1665
|
1700
|
CASATA DEI BORBONE
DI SPAGNA
|
|
|
|
|
15.
|
Filippo V di Borbone – VI Re di Spagna
|
1683
|
1746
|
1700
1717
|
1708
1720
|
|
|
|
|
|
|
CASATA DEGLI
ASBURGO D’AUSTRIA
|
|
|
|
|
16.
|
Carlo III d’Asburgo – VII Re di Spagna –
VI Imperatore
|
1685
|
1740
|
1708
|
1717
|
|
|
|
|
|
|
CASATA DEI SAVOIA
|
|
|
|
|
17.
|
Vittorio Amedeo II
|
1666
|
1732
|
1720
|
1730
|
18.
|
Carlo Emanuele III
|
1701
|
1773
|
1730
|
1773
|
19.
|
Vittorio Amedeo III
|
1726
|
1796
|
1773
|
1796
|
20.
|
Carlo Emanuele IV
|
1751
|
1819
|
1796
|
1802
|
21.
|
Vittorio Emanuele I
|
1759
|
1824
|
1802
|
1821
|
22.
|
Carlo Felice
|
1765
|
1831
|
1821
|
1831
|
CASATA DEI SAVOIA –
CARIGNANO
|
|
|
|
|
23.
|
Carlo Alberto
|
1798
|
1849
|
1831
|
1849
|
24.
|
Vittorio Emanuele II
|
1820
|
1878
|
1849
|
1861
|
Dal
1297 al 1720 i Re del regno furono i sovrani della Corona d’Aragona i quali non
erano i sovrani di uno Stato superiore, ma erano essi, di volta in volta, i
sovrani di ogni singolo Stato formante la Corona.
I
RE DI SARDEGNA
GIACOMO II IL GIUSTO (1267 circa
-1327)
RE
D’ARAGONA – RE DI CATALOGNA E I RE DI SICILIA
1°
RE DI SARDEGNA DAL (1297) 1324 - 1327
Dopo l’unione della Catalogna con l’Aragona, nel 1137-50,
l’espansione ad est era diventata, per la Corona, un vero e proprio imperativo
geo-politico. Il grande mare Mediterraneo, con tutte le opportunità che poteva
offrire in quell’epoca, ad un popolo in piena crescita economica e politica,
era uno sbocco naturale e sicuro verso il favoloso vicino oriente, tramite la
cosiddetta ruta de las islas.
L’isola di Sardegna era, allora, una base importante perché
per arrivare ai ricchi mercati d’oriente, in concorrenza con Genova e Venezia,
grazie ad una rotta d’altura attraverso una serie di approdi intermedi nelle
Baleari, in Sardegna , in Sicilia, in Grecia e a Cipro, si sarebbero dimezzati
i tempi di percorrenza delle navi mercantili, cariche di spezie, di sete e di
altre merci preziose, da 7.277,6 miglia a 3.328,8 miglia, con un notevole
risparmio sui costi di trasporto nel lungo viaggio da Barcellona a Beirut, via
Cagliari e ritorno.
La Sardegna, allora, era divisa in una pluralità di piccoli
stati, spesso in guerra fra loro. Inoltre, una buona parte del suo territorio
era costituito da possedimenti oltre marini di Pisa e Genova.
 Giacomo II il Giusto era figlio
legittimo di quel Pietro III il Grande (uomo di grande abilità politica,
permeato di spirito cavalleresco, colto e raffinato) che diede un forte impulso
alla politica di espansione mediterranea della Corona. Egli succedette al
padre, nel 1285, in Sicilia, e al fratello Alfonso III, nel 1291, in Aragona.
Giacomo II il Giusto era figlio
legittimo di quel Pietro III il Grande (uomo di grande abilità politica,
permeato di spirito cavalleresco, colto e raffinato) che diede un forte impulso
alla politica di espansione mediterranea della Corona. Egli succedette al
padre, nel 1285, in Sicilia, e al fratello Alfonso III, nel 1291, in Aragona.
Si sa che
Giacomo II d’Aragona nel 1311 compì una spedizione aragonese-catalana in
Oriente, ma dai testi disponibili non è dato sapere con quale scopo e con quali
risultati. Risulta invece che all’ipotesi di una crociata in Oriente ventilata
da Clemente V al Concilio di Vienna (1311), Giacomo II rispondeva con lucidità
contrapponendole “un programma realistico di espansione militare”. Secondo il
suo progetto solo poggiando sulle “insules christianorum” (Baleari, Sardegna,
Sicilia), indispensabili basi logistiche, si poteva pensare di pervenire
“all’acquisto della Terra Santa”.
All’inizio
del XIV secolo Giacomo II ottiene dai mamelucchi la concessione per un gruppo
di domenicani di dimorare all’interno della basilica del Santo Sepolcro, ma
dopo un anno di questa dura esperienza i religiosi, dediti allo studio e alla
predicazione, rinunciarono all’ambito
privilegio non potendo vivere una vita da carcerati.
Nel 1323,
poi, così come altri sovrani europei interessati alla custodia dei Luoghi
Santi, mandò i francescani aragonesi in Palestina, sempre al servizio del Santo
Sepolcro a Gerusalemme. Infine, potrebbe essere Giacomo II o uno dei “re
d’Aragona che acquistarono la cosiddetta Grotta
del Latte e la Basilica della Natività a Betlemme”.
Il papa dantesco Bonifacio VIII, nell’ambito della lotta per
il dominio del Mediterraneo che vede contrapposti due schieramenti: i guelfi
(filopapali) e i ghibellini (filoimperiali), ha interesse a risolvere, almeno
in parte, la ventennale guerra del vespro
fra Giacomo II d’Aragona e Carlo II d’Angiò. Egli riuscì a far firmare ai due
contendenti l’accordo chiamato di Anagni, del 24 giugno 1295, con il quale il
re aragonese si impegnava sulla carta a ridare alla Chiesa il regno di Sicilia.
In cambio il papa avrebbe istituito un regno nominale di Sardegna e Corsica (Regnum Sardiniae et Corsicae) da dare in
feudo perpetuo a Giacomo II d’Aragona.
A tale proposito è opportuno precisare che le due isole erano
politicamente e istituzionalmente conformate e nei loro confronti il papa dava
in pratica solo una “licentia invadenti”, cioè il consenso guelfo a che le
terre potessero essere occupate con la forza a scapito delle entità statali e
giuridiche esistenti. Secondo la tradizione storiografica la Sardegna era stata
concessa ai pisani nel 1017 come ricompensa per la liberazione dell’isola dai
saraceni.
La base
giuridica dell’infeudazione datava alla fine del secolo XI in cui veniva
proclamata con Gregorio VII una formulazione di diritti che aveva un lontano
fondamento storico nella nota donazione di Costantino, documento apocrifo che
si suppone diretto nel 313 da Costantino il Grande al papa Silvestro, e che
definiva i beni temporali di Roma. Secondo questa storia tutte le isole vicine
al continente erano patrimonio della Chiesa. Bonifacio VIII, quindi, in virtù
di questo principio, erige in regno le due isole e le infeuda, con carattere
perpetuo, al re d’Aragona.
Nel 1296 papa Bonifacio VIII nomina Giacomo II Gonfaloniere
ammiraglio e capitano generale della Santa Chiesa Romana legandolo al partito
guelfo. Mentre la cerimonia d’investitura avvenne a Roma, in San Pietro, il 4
aprile 1297. Quel giorno Giacomo II il Giusto ricevette dalle mani del
pontefice la simbolica coppa d’oro che lo faceva, di nome, Dei gratia rex Sardiniae et Corsicae. Tale investitura in un primo
momento non ebbe alcun effetto perché Giacomo II si trovava impegnato a
risolvere altri problemi che riteneva prioritari.
L’atto
di infeudazione, datato 5 aprile 1297, specificava che il regno apparteneva
alla Chiesa che lo aveva istituito, che esso regno era dato in perpetuo ai re
della Corona d’Aragona in cambio del giuramento di vassallaggio, ecc. Le
condizioni, sotto pena di reversibilità, erano che il regno non potesse essere
mai diviso e che i suoi re fossero sempre gli stessi che regnavano in Aragona.
Nel corso dei secoli queste ultime clausole furono trascurate e decaddero.
Nel 1302, Giacomo II, accortosi che la situazione
internazionale era a lui favorevole, guardò con occhio mutato alle cose di
Sardegna, del cui titolo dal 1301 aveva iniziato a fregiarsi. Certo, la
conquista anche di un solo pezzo di Sardegna, strutturato in forma di Stato con
il pretenzioso nome iniziale di regno di
Sardegna e Corsica gli avrebbe
risolto, come già detto, il problema della rotta d’altura per battere in
concorrenza le repubbliche marinare italiane di Genova, Pisa e Venezia.
Accertatosi che sul versante italiano poteva contare sul
fatto che le repubbliche e le signorie erano troppo prese a dilaniarsi tra loro
per intervenire pro o contro l’impresa, indirizzò le sue attenzioni sul da
farsi sotto il profilo finanziario e militare. Per rapportare i tempi e i modi
della conquista alle sue finanze decisamente meno solide di quelle delle altre
monarchie europee, e considerato che le entrate ordinarie della Corona
risultavano ipotecate, Giacomo II dovette ricorrere ad anticipazioni
straordinarie premendo sulle casse degli ecclesiastici, delle principali città
e delle minoranze etniche. Fu così che il clero fornì un sussidio che giunse a
coprire quasi la metà del costo totale, mentre l’altra metà fu sostenuta dalle
città commerciali. Gli ebrei di Catalogna contribuirono per un terzo dello
sforzo finanziario (documentato) espresso dall’intero principato.
Dopo
quindici anni di abile, diplomatica e paziente preparazione politico-militare,
Giacomo II il 30 maggio 1323 inviò contro le terre pisane dell’isola, allora in
forte decadenza, il principe ventiquattrenne Alfonso, primogenito (per abiura
del fratello maggiore), con una formidabile armata composta da circa novanta
navi da guerra con undicimila uomini fra cavalieri, balestrieri e scudieri.
Alfonso, detto il Benigno per il suo carattere arrendevole,
si imbarcò a Portfangòs, vicino a Tarragona, conducendo con sé, come era
costume dell’epoca, Teresa d’Entença sua moglie e numerosi fidati funzionari e
cavalieri provenienti dalla nobiltà feudale e dalla piccola nobiltà. Trascorsi
alcuni giorni di navigazione, la flotta si presentò lungo le coste di Palma di
Sulcis, in agro di San Giovanni Suergiu, dove, allo sbarco avvenuto il lunedì 13
giugno 1323, l’infante ricevette l’omaggio del Giudice d’Arborea e dei
principali nobili dell’isola.
Furono
dunque effettuate le operazioni di sbarco nell’intento di investire
immediatamente Villa di Chiesa (Iglesias), mentre una parte della flotta proseguiva
per Cagliari dove l’ammiraglio Carroz fece sbarcare un altro contingente che
occupò l’attuale colle di Bonaria, chiamato Bonayre dagli aragonesi (forse
dallo stesso don Alfonso), in posizione strategicamente felice per bloccare il
porto pisano di La Pola e assediare Castel di Castro. La conquista dell’isola
sembrava facile, ma non fu così. Una serie di piccole guerre locali interesserà
tutta la Regione sino alla fine del secolo e oltre. In pratica fino al
millequattrocento l’isola fu travolta dagli eventi di una guerra endemica, “una guerra dei cento anni in scala ridotta
“ ebbe a dire uno storico catalano.
Intanto
il 4 luglio 1323 il Comune di Sassari si era messo spontaneamente nelle mani
dell’infante.
I
difensori di Villa di Chiesa si arresero il 7 febbraio 1324, dopo poco più di
sette mesi di assedio; fu loro concesso l’onore delle armi e furono lasciati
liberi di trasferirsi a Cagliari.
Lasciata Villa di Chiesa, il 13 febbraio successivo alla
resa, l’infante Alfonso si diresse contro Castel di Castro (Cagliari), per
incontrarsi con quella parte del corpo di spedizione che lo aveva preceduto e
che aveva cinto d’assedio la città. Di fronte ad essa, sul colle di Bonaria,
gli aragonesi circondarono di mura l’accampamento: in pratica eressero una
roccaforte dentro la quale nacque una vera colonia catalana. A ricordo della capitale della Catalogna il nascente
villaggio fu chiamato “Barceloneta” (piccola Barcellona). La prima cosa che si
fece fu di aprire un porto per l’approvvigionamento delle vettovaglie per le
truppe e di costruire una chiesa parrocchiale. Esisteva una grotta, una cavità
naturale detta, secondo la tradizione “Grutta de su Rey” dove si acquartierò
don Alfonso prima che sorgesse “Barceloneta”, grotta che è stata purtroppo
distrutta per costruirvi l’imponente scalinata che porta alla Basilica di
Bonaria.
A tale proposito Francesco Alziator, esperto di etnografia e
cultore delle tradizioni popolari sarde e catalane, ebbe a scrivere
sull’argomento, nel suo libro “L’elefante sulla torre” del 1982: < Alfonso d’Aragona a quei tempi, veramente
non era re, ma solo infante. I sardi però videro le cose con la lente di
ingrandimento e chiamarono monte una collina e re un principe e così venne
fuori “Monreale” e “Grutta de su Rei” fu detta la grande cavità ora in parte
murata, davanti alla basilica, dove, secondo la leggenda, nel 1324, si sarebbe
sistemato nei primi tempi dello sbarco. Certo in nessun punto della città come
sul colle di Bonaria si è fatta la storia >.
Il
giorno 29, mercoledì delle ceneri, l’infante dovette correre ad Elmas per
sbarrare la strada ad un esercito pisano sbarcato a Maddalena Spiaggia in agro
di Capoterra. La battaglia in linea,
unica in tutta la guerra pisano-aragonese, avvenne con due scontri frontali
violentissimi in località Lucocisterna, pressappoco all’altezza dello svincolo
per l’odierno aeroporto. Vinsero con difficoltà i catalano-aragonesi, con
Alfonso che si battè da prode, sì che l’impresa fu a lungo magnificata (sarà
ricordata anche dal figlio Pietro IV il Cerimonioso nella sua famosa Cronaca) e sul luogo fu innalzato un
cippo–ricordo. Contemporaneamente vi fu nelle acque del Golfo degli Angeli,
davanti al quartiere di Stampace, la vittoria navale dell’ammiraglio Francesco
Carroz sulla flotta di Pisa, e la poco nota conquista delle piazzeforti della
Gallura.
Dopo
la vittoria l’infante tornò sul colle di “Bonayre” (Bonaria) dove proseguiva la
costruzione della chiesa e di molte case. Così mentre l’assedio continuava, sul
colle si sviluppò una nuova città catalana di circa seimila abitanti nella
quale ben presto confluirono molti spagnoli che provenivano dalla Catalogna,
dall’Aragona, dalle Baleari e persino alcuni ebrei. La chiesa fu dedicata
originariamente alla S.S. Trinità e alla Madonna, successivamente a Nostra
Signora di Bonaria elevata a patrona del regno
di Sardegna e protettrice dei marinai e naviganti, oggi patrona dell’isola
e molto venerata dai sardi. La chiesa, diventata Santuario, è meta di
pellegrinaggio da parte dei numerosi fedeli. Essa è affidata ai Padri Mercedari
presenti in Sardegna già in epoca pisana.
Anche
in tempi remoti questo colle di Bonaria è stato testimone del passaggio di
grandi personaggi fra i quali, dall’8 all’11 luglio 1270, San Luigi re di
Francia, il re di Navarra, i conti di Poitiers, di Fiandra, di Bretagna ed il
fior fiore della nobiltà francese che si dirigevano, crociati, in Terra Santa.
Il nome di Bon-Ayre pare sia dovuto allo stesso don Alfonso quando costruì nel
colle un recinto fortificato per assediare “Castello”. Il suo nome ha fatto
molta strada giacchè attraversò anche l'oceano e sopravvive oggi nella capitale
dell'Argentina. Gli storici argentini, e non solo loro, tendono a far derivare
il nome di Buenos Aires dalla Vergine Sarda.
L’assedio
di Castel di Castro continuò, ma ormai le speranze per i difensori erano
finite. Fu così che, il 19 giugno 1324, un martedì, sul colle di Bonaria, in
una tenda di assedio, si arrivò alla pace fra Pisa e Giacomo II re d’Aragona.
Con la firma del trattato di pace i vincitori cambiarono la condizione
giuridica dell’ex entità sardo-pisana da subordinata in assoluta, al fine di
aggregare questi nuovi territori, con specifica fisionomia istituzionale, alla
Corona d’Aragona rappresentata dalle leggi monarchiche. Quindi fu creato uno
Stato ex novo: il Regno di Sardegna e Corsica (Regnum Sardiniae et Corsicae).
Tutto questo è affermato in una Carta Reale Diplomatica dell’Archivio della
Corona d’Aragona di Barcellona, pubblicata nel 1952 da Antonio Arribas Palau
nel suo volume “La conquista di Cerdeña
por Jaime II de Aragon “.
Il
giorno dopo la firma della pace l’assedio cessò e le chiavi della città furono
consegnate al procuratore reale che fece issare lo stendardo con i colori
d’Aragona sulle torri della città. Da quel momento cessò l’influenza pisana in
Sardegna durata oltre tre secoli.
Quel giorno nacque di diritto e di fatto il
Regno di Sardegna il quale, per strane vie del destino, il 17 marzo 1861, si
trasformò in Regno d’Italia; venne a
configurarsi così la base istituzionale dell’attuale nostra Repubblica.
Il trattato
di pace prevedeva che Pisa cedesse al re d’Aragona tutti i diritti che aveva
sulle città, castelli, ville, terre, porti, miniere e saline in Sardegna e in
Corsica, con tutti i diritti e pertinenze, con mero e misto imperio e qualsiasi
altra giurisdizione e potestà. L’infante, in nome del re, concedeva in feudo a
Pisa Castel di Castro di Cagliari con le due appendici di Stampace e Villanova.
Lasciato il regnum nelle mani di un governatore
generale residente a Bonaria, Alfonso si imbarcò con la moglie e il suo
seguito, a Palma di Sulcis il 25 luglio 1324, e il primo agosto sbarcò a
Barcellona dove fu ricevuto con grandi feste e solennità dal padre e dal
popolo.
Ma la conquista della Sardegna
era tutt’altro che consolidata. A parte che le entrate complessive del nuovo
possedimento della Corona si rivelarono subito inferiori alla metà rispetto
alle 30.000 libbre d’oro che occorrevano per pagare milizie e ufficiali regi di
stanza nell’isola, ingenerando malumori fra i conquistatori; verso la fine
dell’anno 1324 i Doria, i Malaspina ed i sassaresi erano già in rivolta contro
gli aragonesi.
Anche i pisani, che mal
tolleravano la concorrenza della città catalana di Bonaria, nell’ottobre si
ribellarono. Fu quindi nuovamente guerra aperta. La flotta aragonese tornò in
Sardegna e il 24 dicembre l'ammiraglio Carroz colse una vittoria decisiva nel
golfo di Cagliari su una squadra genovese che tentava di soccorrere la città.
Castello fu nuovamente assediato e con la Pola e Stampace, fu poi riconquistato
dagli aragonesi. Il 25 aprile 1326 fu raggiunta una nuova pace fra Aragona e
Pisa; anche Sassari accettò la pace il primo giugno. Questa volta la città di
Cagliari fu ceduta al re e le truppe aragonesi la occuparono il 6 giugno 1326.
Cessò così per sempre la presenza dei pisani nell’isola: l’obiettivo che
Giacomo II si era prefisso era stato raggiunto.
Il 10 giugno i catalano-aragonesi entrarono nella città
ribattezzata Castel de Caller (poi Caller, in italiano Cagliari) la quale fu
totalmente evacuata e ripopolata con elementi esclusivamente iberici
provenienti da Bonaria. I nuovi conquistatori, come avevano già fatto i pisani,
impediscono ai sardi di pernottare entro le mura, essi dovevano lasciare il
Castello prima che si facesse notte, sotto pena di essere buttati giù dalle
mura. Tale divieto fu abolito solo nel 1510 da Ferdinando II il Cattolico.
Una volta conquistati i territori appartenenti a Pisa, il regnum Sardiniae fu costituito ed entrò
a far parte dell’impero che l’Aragona andava formando nel Mediterraneo. La
Sardegna, quindi, continuò a essere uno dei punti di riferimento di un vasto
contesto internazionale in difficile equilibrio. Gli Aragonesi, però, non
controllavano ancora tutta la Sardegna. Il regno era diviso territorialmente in
due parti non contigue, formate la prima dall’unione del cagliaritano e della
Gallura, e la seconda dal Comune di Sassari che, col suo circondario, era come
un’isola in mezzo ai possedimenti signorili dei Doria e dei Malaspina. Solo nell’agosto
del 1420 il regno si identificherà con tutta l’isola.
Rimanevano, per i nuovi venuti, numerosi complessi problemi
da definire. Intanto i rapporti col giudice d’Arborea erano poco chiari, il
giudice infatti era considerato il più potente vassallo della Corona in
Sardegna ma, se questa posizione era scontata negli ambienti di corte, non lo
era certamente nell’Arborea, e in avvenire si vedrà come questo equivoco sarà
fonte di nuovi dolorosi contrasti. Difficili erano anche i rapporti con i Doria
e i Malaspina che, anche dopo la pace del 1326, continuavano a tenere un
atteggiamento ostile che si trasformò in un endemico stato di guerra.
Purtroppo, quando i catalano aragonesi si insediarono nei
territori isolani che erano stati dei pisani, vi imposero modi e sistemi di
governo estranei alla mentalità degli indigeni abituati alla libertà prima
giudicale e poi comunale. Perciò il primo sovrano del regno, Giacomo II il
Giusto, la cui politica di espansione
tendeva a rispettare, per quanto possibile, le istituzioni di ogni
paese, dovette affrontare subito il forte malcontento delle popolazioni paesane
che, preoccupate per la presenza dei nuovi feudatari iberici, avevano paura
d’avere ora a carico tanti re quanti sono i villaggi ai quali versare
tutti quei diritti che solevano donare al Comune di Pisa.
La conquista non significava la necessaria estensione delle
leggi spagnole all’isola, ciò sarebbe stato contrario alla sua autonomia
giuridica. Ma la Sardegna poteva, invece, col rispetto della sua legislazione
indigena, godere dei privilegi che i re spagnoli avrebbero potuto concederle.
La prima capitale del regno fu, per due anni, il villaggio
fortificato di Bonaria, sul colle omonimo; successivamente la sede del potere
regio si trasferì, nel giugno 1326, a Caller, già Castel di Castro. Si ricorda
che Cagliari conservò il titolo di capitale, sebbene i sovrani vi abbiano
risieduto poche volte, fino alla trasformazione del Regno di Sardegna in Regno
d’Italia, avvenuta con legge sarda n. 4671 del 17 marzo 1861. A tale proposito
è forse opportuno segnalare che contro i documenti storici e geografici
preunitari che indicano sempre Cagliari come capitale del regno, gli scrittori
moderni affermano, sbagliando, che dal 1720 al 1861-65, fu capitale Torino in quanto
città nella quale si concentravano le funzioni politiche dello stato.
Ai nuovi cittadini, il re Giacomo II d’Aragona, con Carta
Reale del 25 agosto 1327, chiamata Coeterum, concesse diverse grazie, esenzioni
ed immunità fra cui quella notevolissima che gli abitanti del Castello, dei
sobborghi e dei paesi circostanti, godessero delle stesse libertà, franchigie,
privilegi e consuetudini degli abitanti di Barcellona. Tale privilegio fu poi
esteso anche a Sassari e Alghero.
Fra i benefici di cui sopra, vi era lo ius cudendi, cioè il diritto di battere moneta propria, con proprie
zecche di emissione e quindi la creazione di un sistema monetario dal quale è
scaturita la lira sarda, che adottava
il sistema medioevale della divisione in lire, soldi, denari (1 lira = 20
soldi; 1 soldo = 12 denari). Tale sistema, con alcune varianti, si è protratto
per oltre quattrocento anni, cioè sino all’età sabauda. Qui è il caso di
ricordare che ancora prima di occupare Villa di Chiesa, maturò il progetto di
stabilirvi una zecca. L’infante Alfonso ne informò il capitano dell’esercito
Gueran de’Rocaberti, che si trovava a Cagliari, ordinandogli, in data 9
dicembre 1323, di ricercare fra gli uomini delle sue truppe alcuni monetieri e
operai capaci. Questo privilegio di zecca è stato poi sancito ufficialmente il
giorno 12 febbraio 1324, ossia appena cinque giorni dopo la occupazione di
Villa di Chiesa.
La monetazione sardo-aragonese iniziò sicuramente nell’anno
1324, prima a Villa di Chiesa, poi nel villaggio fortificato di Bonaria. Vi
furono coniate due monete: una moneta grossa d’argento e una moneta minuta di
biglione (lega metallica con basso contenuto d’argento) entrambe chiamate alfonsini in onore, appunto,
dell’infante Alfonso. Nella sola zecca di Bonaria furono coniati, in un solo
anno, più di un milione e mezzo di esemplari di alfonsini minuti.
Fin
dall’inizio il regno ebbe anche un emblema: lo scudo con quattro teste di moro
inquartate in croce rossa in campo bianco e argento, che compare anche in uno
stemmario belga del 1370/86 con i mori senza bende, conservato a Bruxelles e
noto con il nome di Stemmario di Gelre. I quattro mori sono un antico simbolo
aragonese che celebrava la vittoria di Alcoraz, nel 1096, contro i saraceni di
Huesca. Di questo stemma si ha la prova in una bolla di piombo della
cancelleria reale di Pietro il Grande, re d’Aragona, nel 1281, quindi ben 16
anni prima di quel fatidico 1297, anno in cui il papa Bonifacio VIII infeudò
del Regno di Sardegna Giacomo II.
Lo stemma rimase a rappresentare il regno in tutte le
bandiere, stendardi e labari statali, caricato dopo il 1720 dell’aquila sabauda
fino all’assunzione, il 23 marzo 1848, del tricolore verde, bianco e rosso e lo
stemma di casa Savoia, nel Risorgimento.
Ancora oggi lo scudo con i quattro mori in campo bianco è lo
stemma, il simbolo della Regione Autonoma della Sardegna , ed esposto,
unitamente al tricolore e alla bandiera dell’Europa, negli edifici pubblici in
occasione di ricorrenze di carattere nazionale ed europeo.
Recentemente lo stendardo è sventolato, il 2 febbraio 2001 ad
Hautecombe, nell’alta Savoia, in occasione dei funerali dell’ultima regina
d’Italia, Maria Josè.
A conclusione di questo capitolo dedicato al 1° re di
Sardegna si aggiunga che Giacomo II si propose di non limitarsi ad una semplice
annessione dell’isola, bensì di creare un regno che, sebbene a lui unito e da
lui dipendente, fosse in un certo modo autonomo. E a questo proposito tutti i
suoi successori furono fedeli e lo stesso fu imposto come condizione ai re della
dinastia dei Savoia. Così sino a quando la Sardegna si fuse con le altre
province del continente italiano (1847), essa mantenne l’unità e l’autonomia
nazionale che aveva acquistato soltanto durante l’epoca spagnola.
Giacomo II d’Aragona fu anche letterato e mecenate, nonché
abile diplomatico e protesse le arti e le lettere. Morì all’età di
sessantasette anni, nel 1327. Gli successe, come di diritto, Alfonso IV il
Benigno, secondo nato, diventato primogenito nel 1319 per rinuncia del pazzoide
fratello Giacomo, omonimo del padre.
ALFONSO IV IL BENIGNO (1299-1336)
RE
D’ARAGONA – RE DI CATALOGNA – RE DI SICILIA
2°
RE DI SARDEGNA DAL 1327 AL 1336
 Successe a Giacomo II per diritto dopo
la rinuncia, nel 1319, del pazzoide fratello primogenito Giacomo, omonimo del
padre.
Successe a Giacomo II per diritto dopo
la rinuncia, nel 1319, del pazzoide fratello primogenito Giacomo, omonimo del
padre.
All’età
di ventiquattro anni gli fu affidato il comando del corpo di spedizione da
inviare, nel 1323, in Sardegna per la conquista dell’isola, conclusasi l’anno
successivo.
Egli continuò l’opera iniziata allora per la ispanizzazione del
nuovo regno, che non fu né facile né tanto meno indolore. Già durante il regno
di Giacomo II si verificarono, all’indomani della conquista, frequenti
movimenti antiaragonesi dovuti alla soffocante dominazione iberica che instaurò
il feudalesimo su una terra abituata alla libertà prima giudicale e poi
comunale. Nel 1325 si era avuta la sollevazione di Sassari; nel 1328 un’altra
rivolta nel capoluogo logudorese; il 26 settembre 1329 si ebbe la terza e più
disgraziata insurrezione sassarese e la conseguente sanguinosa repressione. Tra
i fatti più notevoli di quel periodo si può ricordare la distruzione di
Aryagono, in Gallura, con l’eccidio di tutta la popolazione del paese, uomini,
donne e bambini per aver soppresso il proprio signore, il catalano Martinez de
lo Poyo, nel 1329; le azioni di guerra nel marzo del 1334 nei pressi della bastia di Sorres e poi sotto le mura di
Alghero e di Sassari fra le truppe di Branca Doria e le milizie catalane e
arborensi.
Per motivi
politici connessi alle vicende della guerra, gli aragonesi tentarono esperienze
di ripopolamento con elementi iberici. Si trattò in pratica di espellere
popolazioni considerate nemiche e di sostituirle con altre provenienti dalla
Spagna, per costruire dei nuclei omogenei di ispanizzazione, a supporto dello
sforzo militare che la corona sosteneva nell’isola.
Fu un’operazione di grande complessità e che ebbe conseguenze
negative in quanto accentuò la frattura fra catalano – aragonesi e sardi,
rompendo l’unità culturale del territorio, in alcuni casi con conseguenze
irreparabili.
A Cagliari l’operazione riguardò solo i quartieri di Castello
e di La Pola, da cui la popolazione pisana e sarda fu espulsa e sostituita con
elementi catalani, aragonesi e majorchini.
L’operazione ebbe le basi nel trattato del giugno 1326 tra
Aragona e Pisa, nel quale venne stabilito che gli abitanti sospettati di
cospirazione contro il re d’Aragona, avessero un certo periodo di tempo a
disposizione per vendere i loro averi e lasciare Cagliari.
In effetti lo stesso infante Alfonso, una volta tornato a
Barcellona, dopo la conquista di Cagliari, decise l’espulsione di tutti gli
abitanti dei due quartieri per ragioni di sicurezza. Il governatore agì con
pieni poteri per tutto il 1327 e i cagliaritani furono espulsi massicciamente;
l’operazione causò disagi infiniti, profonda amarezza e danno notevole perché
solo in pochi casi il prezzo convenuto, stimato da una apposita commissione, fu
pagato.
A Sassari si ripeterono gli stessi disagi che subirono i
cagliaritani, ma il progetto di ripopolamento prevedeva anche la
ristrutturazione urbanistica ed economica della città nella quale si voleva
sviluppare l’industria tessile. Il progetto fallì e, a partire dal 1335, gli
antichi abitanti di Sassari furono riammessi in città, con l’esclusione degli
esponenti dell’antica classe dirigente. I sassaresi, comunque, subirono danni
sociali ed economici irreparabili.
Ad Alghero, invece, anche a causa della crisi demografica, fu
deciso di concedere ai ripopolatori un insieme di privilegi senza precedenti
(concessioni di riserve di grano, finanziamenti, esenzioni fiscali, ecc.).
A partire dal 1329 anche nelle diocesi sarde furono nominati,
con sempre maggiore frequenza, prelati spagnoli che portarono con se altri
religiosi di loro fiducia e iniziarono progressivamente l’opera di
ispanizzazione della chiesa sarda.
Nel 1335, avvenne la cessione del monastero di Bonaria
(Cagliari), a favore dell’ordine spagnolo dei mercedari. Particolare attenzione
fu riservata ai grandi ordini religiosi che avevano in Sardegna numerose ed
estese proprietà; nei loro confronti fu adottata una politica di autentica e
progressiva spoliazione. Il danno provocato da questa operazione fu senza
dubbio notevole, se si tiene conto dell’influenza culturale che questi grandi
ordini religiosi avevano esercitato nei secoli precedenti, e delle grandi opere
di bonifica di cui si erano resi promotori.
Il possesso dell’isola era importante per l’economia catalana
per cui la Corona, a partire dal 1324, si adoperò per integrare l’isola nel suo
sistema economico. Tutte le attività economiche del mercato sardo,
dall’attività mineraria all’esportazione del grano, del sale, al commercio
delle carni, dei pesci e delle derrate alimentari furono nel corso degli anni
rigorosamente controllate e integrate nel sistema economico catalano–aragonese.
Così venne disciplinata l’attività del porto di Cagliari che divenne il
principale centro commerciale del regno e fu posto in condizione di agire in
regime di monopolio.
Per quanto i nuovi venuti fossero interessati all’economia
della Sardegna, questa cominciò a decadere, ma il suo graduale arretramento nel
primo periodo non ebbe grandi conseguenze finchè la produzione del grano e
dell'orzo si mantennero su livelli annui di 100.000 ettolitri e quella del sale
sui livelli annui di 115.000 ettolitri. Questi due settori sembravano
confermare, con i loro livelli di produzione, la validità della conquista. Va
inoltre aggiunto che l’amministrazione reale traeva un notevole profitto dal
controllo della produzione dell’argento che era in gran parte convogliata verso
la attività delle zecche di Iglesias e di Bonaria. Le vicende che riguardano la
storia sarda, però, possono essere comprese meglio se si tengono
contemporaneamente presenti quelle relative al confronto per il controllo delle
grandi rotte commerciali del Mediterraneo, e in particolare quelle relative
alla guerra tra Aragona e Genova destinata a durare per buona parte del XIV
secolo.
La Sardegna fu anche condizionata da alcuni problemi di carattere
sociale ed economico che si manifestarono nel corso del XIV secolo e che
interessarono l’intera Europa. In primo luogo la crisi demografica determinata
sia dalle ricorrenti carestie conseguenti a una serie di cattive annate,
provocate probabilmente da mutamenti climatici che si manifestarono a partire
dal 1330, sia dalla peste che, proveniente dall’Asia, interessò inizialmente i
grandi porti posti lungo le rotte commerciali e che da Alessandria e
Costantinopoli passò in Italia da dove si diffuse in tutta Europa.
Alfonso IV morì nel 1336, all’età di trentasette
anni, lasciando il regno al figlio Pietro IV il Cerimonioso.
RE D’ARAGONA – RE DI CATALOGNA – RE DI
SICILIA
3°
RE DI SARDEGNA – DAL 1336 AL 1387
 Succeduto
al padre Alfonso IV il Benigno, cooperò con la flotta genovese alla presa di
Algesiras nel 1342. Due anni dopo si impadronì delle Baleari e del Rossiglione
Succeduto
al padre Alfonso IV il Benigno, cooperò con la flotta genovese alla presa di
Algesiras nel 1342. Due anni dopo si impadronì delle Baleari e del Rossiglione
Una
volta conquistati i territori appartenuti a Pisa, il “Regnum Sardiniae” entrò a
far parte dell’impero che l’Aragona andava formando nel Mediterraneo. Ma la
conquista della Sardegna era tutt’altro che consolidata; gli aragonesi non
controllavano ancora tutta l’isola.
L’evoluzione della vita politica
nell’isola durante il XIV secolo può essere divisa in due periodi: il primo che
va dalla conquista al 1355, anno della pacificazione generale voluta da Pietro
IV e il secondo che arriva sino al 1409, ed è caratterizzato dalla lunga guerra
tra Arborea e Aragona.
Il possesso dell’isola era importante
per l’economia catalana per cui la Corona, a partire dal 1324, si adoperò per
integrare l’isola nel suo sistema economico.
Il passaggio di buona parte dell’isola
agli aragonesi aveva sradicato la Sardegna dal sistema italiano di scambi e
l’aveva inserita in quello catalano. I nuovi venuti, convinti di poter trarre
in Sardegna forti utili dallo sfruttamento delle sue risorse, imposero un
sistema di conduzione dell’economia fortemente burocratizzato.
La conversione della circolazione
monetaria dalle monete pisane e genovesi a quelle dette alfonsini minuti, coniate nelle zecche di Iglesias e di Bonaria,
istituite subito dopo la conquista, fu attuata rapidamente. Tutta la produzione
dell’argento, stimata in circa 1.900 chili l’anno, fu dal re d’Aragona
rigorosamente controllata e solo in piccola parte usata per la zecca, la
maggior parte esportata. Anche la produzione del sale era controllata
direttamente dal re. Questi due prodotti venivano tratti dalla Sardegna a
esclusiva utilità del re, la cui azione in progressione finì per impoverire
l’economia dell’isola.
Anche il sistema del commercio delle
altre risorse finì per assumere modalità di tipo coloniale. Tutte le attività
economiche del mercato sardo, da quello minerario, all’agricoltura, all’esportazione
del grano, del sale e delle carni, dei pesci, furono nel corso degli anni
rigorosamente controllate e integrate nel sistema economico catalano –
aragonese.
Nelle città sarde, e principalmente a
Cagliari, si stabilirono da padroni i mercanti aragonesi, catalani, maiorchini
e valenzani, immigrati al seguito delle truppe. A Cagliari venne disciplinata
l’attività del porto che divenne il principale centro commerciale del regno e
fu posto in condizione di agire in regime di monopolio.
Dalla
seconda metà del XIII secolo quello sardo era un mondo in profonda
trasformazione: nell’isola andava scomparendo la servitù, cioè quella classe
che aveva sorretto l’economia del periodo giudicale. Questa trasformazione si
era bloccata dopo la conquista, a causa della introduzione del sistema feudale
da parte dei vincitori.
La
ricomparsa della fame, che fu la conseguenza di una carestia che si era
manifestata nel 1340 e che aveva portato all’aumento dei prezzi, provocò in
quegli anni alcuni gravi fenomeni economici e sociali che turbarono
l’equilibrio del mondo mediterraneo e dell’Europa. La peste poi, dopo
l’epidemia del 1348 che fu di particolare gravità, nel corso del XIV secolo
ricomparve nel 1376 e nel 1398. Le conseguenze furono terribili per la
Sardegna: morì circa il 50% della popolazione; molti villaggi scomparvero.
Nel
frattempo si crearono le condizioni per la ripresa delle ostilità tra Genova e
Aragona. Pietro IV comprese che il confronto con Genova era inevitabile e
necessario perché dal suo esito sarebbero dipesi il monopolio commerciale nel
Mediterraneo e la sicurezza dei traffici mercantili lungo le grandi rotte verso
l’oriente, dove gli interessi della corona andavano estendendosi.
La
guerra iniziò nel 1351 e decisiva fu la battaglia di Costantinopoli del 1352,
nella quale la flotta genovese fu sconfitta e quasi completamente distrutta.
Anche
nei confronti dei Doria la situazione divenne critica. Questi si ribellarono e
ripresero a combattere: chiesero aiuto a Genova che inviò ad Alghero un governatore
e delle truppe con l’intento di proteggere la città. Pietro IV capì che
Alghero, in mano ai Doria, rappresentava un pericolo e pertanto decise di
conquistarla. Approfittando delle conseguenze della battaglia di
Costantinopoli, nel 1353 il re inviò di fronte ad Alghero una potente flotta.
La città, stretta dal mare e da terra, dopo un duro assedio capitolò.
I
movimenti antiaragonesi si estesero e si fecero sempre più numerosi e
frequenti. Al diffuso malcontento popolare si aggiunse la rottura della decennale
alleanza fra gli Arborea e il regno d’Aragona che provocò la dichiarazione di
guerra ai catalani–aragonesi–valenzani del regno di Sardegna e, di conseguenza,
alla corona d’Aragona, nel 1353.
In
poco tempo tutte le campagne furono in mano ai Doria e agli Arborea e i loro
vessilli garrivano ormai su quasi tutta l’isola. Rimanevano in mano della
Corona solo Cagliari, Sassari e alcuni castelli.
Data
questa grave situazione, a Pietro IV il Cerimonioso non restò che organizzare
una grande e costosissima spedizione militare e andare in Sardegna per “stroncare definitivamente” – così diceva
lui – la resistenza e i fermenti che agitavano questo suo tormentato regno
d’oltremare.
La
flotta catalano–aragonese, composta da quarantacinque galee e da circa cinquanta
navi minori, partì da Roses la domenica 15 giugno 1354 e giunse nei pressi di
Alghero, dopo una settimana di difficile navigazione, il giorno 22.
Il
24 le forze di terra al comando del re, e le forze di mare agli ordini di
Bernardo de Cabrera iniziarono l’assedio della città, destinato a durare ben
cinque mesi. Il 14 novembre Pietro IV concluse la pace con i Doria e gli
Arborea, il 16 entrò finalmente in Alghero e affrontò il problema del suo
ripopolamento, concedendo nuove franchigie
e riformando le tariffe doganali.
Alghero acquistò una fisionomia catalana
dopo che furono espulsi, nello stesso 1354, gli antichi partigiani di Genova e
fu ripopolata con catalani e aragonesi che vi trasportarono tutti gli elementi
di spirito e di razza, conservati ancora oggi. Città prediletta dai sovrani
spagnoli, godette di ogni genere di onori, di privilegi e di esenzioni.
Pietro
IV si recò quindi a Cagliari con la corte e la moglie Eleonora di Sicilia, per trattare le cose del regno. Il 17
gennaio 1355, dopo avere trasformato il governatorato generale in due
governatorati del Capo di Cagliari e Gallura e del Capo di Logudoro (in quanto
non c’era continuità territoriale fra i due Capi) aveva indetto un Parlamento,
convocando in tutta fretta i rappresentanti della nobiltà, del clero e delle
ville regie della Sardegna aragonese che dovevano formare i tre bracci (o
stamenti) delle corti.
L’assemblea
si riunì in cattedrale o nel palazzo regio il 15 febbraio e durò fino al 10/14
marzo dello stesso anno. Molti dei convocati defezionarono, soprattutto del
braccio ecclesiastico, e da molti istituzionalisti sardi questo parlamento
straordinario è stato considerato irregolare. Ma visto in prospettiva il
parlamento istituito da Pietro IV nel regno di Sardegna e Corsica, fu un organo
di autonomia statutale che durò fino al 29 marzo 1847, fino a quando i sardi vi
rinunciarono spontaneamente per fondersi
col Piemonte.
In
questa occasione, Pietro IV e la sua corte abitarono nel palazzo regio di
Cagliari dal 6 gennaio al 26 agosto 1355, giorno in cui ripartì per Alghero. Il
6 settembre, insieme col resto del corpo di spedizione, il re lasciò finalmente
l’isola, quieta ma tutt’altro che pacificata, per fare ritorno a Barcellona
dove l’aspettava un furioso tumulto popolare anti-oligarchico, alimentato da
una generale crisi economica che le spese militari per la Sardegna avevano
contribuito ad aggravare.
Dopo
una tregua di dieci anni Mariano IV d’Arborea riprendendo nel 1364 il suo
disegno risorgimentale, chiese al papa Urbano V di revocare il regno di
Sardegna a Pietro IV d’Aragona e assegnarlo a lui. In attesa della nomina, che
pareva certa e imminente, il 18 ottobre 1365 il re arborense attaccò il
castello di Sanluri, prese Villa di Chiesa (Iglesias) e assediò Castel di
Castro mettendo a ferro e a fuoco le sue appendici. Alla fine dell’anno il
regno di Sardegna aveva perso tutti i territori e le città tranne la capitale
ed Alghero.
La
situazione per i catalano–aragonesi–valenzani del regno di Sardegna e Corsica
si stava facendo insostenibile. Pietro IV si affrettò ad inviare nell’isola una
grossa spedizione al comando di Pietro Martinez de Luna il quale, sbarcato a
Cagliari nel giugno del 1368, si diresse subito verso Oristano. Violando
nottetempo il sistema difensivo arborense, giunse nei pressi della capitale
giudicale e la cinse d’assedio. Questo non durò più di due settimane perché gli
aragonesi furono a loro volta attaccati di fronte e alle spalle dagli
oristanesi. Gli iberici furono duramente sconfitti: morì sul campo lo stesso comandante
de Luna e solo qualche manipolo riuscì a raggiungere Castel di Castro.
Il 2 aprile 1369, lunedì
di Pasqua, Pietro IV annunciò a Barcellona di volere muovere di persona contro
Mariano IV; ma questa spedizione militare non si realizzò mai. Anche nel 1370
il re dichiarò nuovamente di volersi recare in Sardegna per combattere i nemici
del suo regno, di cui gli restavano solo le città di Alghero e di Cagliari e i
castelli di San Michele, Acquafredda e Quirra.
La
ripresa della guerra con la Castiglia sviò il sovrano di Barcellona dal
proposito di passare nell’isola, tanto più che i capisaldi regi resistevano
validamente agli assalti. Fu preparato l’ennesimo corpo di spedizione di
seimila uomini. Cosa avvenne di questi uomini, spariti nell’autunno del 1371 in
un punto imprecisato del continente, è un mistero.
Nel
1374 Genova tentò di aiutare i sardi giudicali inviando quaranta galere davanti
al porto di Cagliari, in modo da bloccare i rifornimenti alla rocca per via
d’acqua mentre veniva attaccata da terra. Tutti gli sforzi furono inutili.
Nessuna fortezza aragonese si arrese, e Mariano IV morì nel 1376, forse di
peste, senza realizzare il suo sogno di unità nazionale.
Mariano
IV aveva portato al suo maggiore fulgore politico e culturale il giudicato che
divenne sempre più il punto di riferimento nazionale per tutto il popolo sardo.
L’ordinamento territoriale del giudicato nel corso del XIV secolo si era
evoluto sia a livello centrale che periferico, infatti il tradizionale apparato
mutuato dall’ordinamento bizantino era sparito. La corte giudicale aveva
assunto caratteri simili a quelli degli altri stati europei. Essa era una corte
piccola ma brillante e aperta agli influssi culturali più disparati. Infine
l’organizzazione amministrativa del giudicato d’Arborea aveva mantenuto
caratteri di profonda originalità nei confronti dell’ordinamento che gli
aragonesi avevano dato al “regnum”. L’aristocrazia giudicale era stata
integrata da famiglie di funzionari, di notai e di mercanti, provenienti sia
dall’Italia che dalla Catalogna. Mariano IV promosse anche lo sviluppo delle
arti figurative e dell’architettura, che già i suoi predecessori avevano curato
in maniera particolare. Completò, inoltre, la ricostruzione del duomo di
Oristano in forme gotiche, avviata da suo padre nel 1325; promosse la
costruzione delle chiese di San Lazzaro e San Martino, valorizzò la chiesa di
Santa Chiara, già voluta da suo fratello Pietro III e ne costruì altre fuori
Oristano.
Non
bisogna trascurare un altro importante aspetto dell’impegno politico di Mariano
IV, cioè quello riguardante l’economia del suo piccolo stato. Egli promulgò,
dopo il 1347, il “Codice Rurale” per regolamentare l’uso dei pascoli, cui fece
seguito, nel 1353, la “Carta di Burgos” con la quale concesse molti privilegi
ai coloni che avessero fissato la propria residenza nel Goceano e nelle terre
che avevano sofferto a causa della peste. Le riforme che aveva introdotto dopo
l’abolizione della “servitù” incrementarono notevolmente le potenzialità
economiche del giudicato e ne fecero la realtà più florida della Sardegna.
Disponeva di ingenti risorse finanziarie che utilizzò anche a sostegno dello
sviluppo culturale, che raggiunse livelli quale prima l’Arborea non aveva mai
visto.
A
Mariano IV succedette il figlio Ugone III che fu ucciso nel 1383 dagli stessi
sardi in rivolta. Nel marzo dello stesso 1383 Eleonora d’Arborea assunse il
potere in qualità di giudicessa reggente, giacchè suo figlio Federico,
designato a regnare, non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno d’età
(all’epoca aveva forse sei anni), e ciò in armonia con le consuetudini giudicali e senza particolari opposizioni.
Parlare
di Eleonora d’Arborea è piuttosto difficile. Sposata con Brancaleone Doria,
divenuta per ventura giudicessa reggente all’età di quarant’anni (per legge le
donne, nei guidicati, non potevano essere regine regnanti), è improbabile che
abbia partecipato alle azioni belliche contro il nemico, come la quasi coeva
Giovanna d’Arco spesso a lei paragonata dalla storiografia comune.
In
tutto il corso del suo governo non andò più in là delle conquiste del padre e
del fratello. Anzi, per una serie di circostanze fu costretta a cedere,
nell’88, quasi tutti i territori occupati che resero difficoltosa la guerra dei
sardi nazionalisti. Non ebbe una grande visione politica e non si aprì mai
all’esterno. Anche come legislatrice la sua fama è esagerata in quanto non fece
altro che promulgare con la Carta de logu leggi da tempo in uso nell’Arborea,
in parte già codificate dai suoi predecessori, soprattutto da Mariano IV.
Insomma, fu una governante rispettabile ma non eccezionale.
Eleonora
si venne a trovare in una condizione obbiettivamente complessa e scabrosa.
Appena assunto il governo (1383), con decisione perlomeno avventata, aveva
permesso a suo marito Brancaleone Doria di recarsi a Barcellona per esaminare
la situazione e per chiarire la sua posizione personale. Colà il Doria rinnovò
evidentemente il suo giuramento di fedeltà perché il 24 giugno fu nominato
cavaliere e creato conte di Monteleone, già antico possedimento della famiglia.
Infine gli fu concessa la baronia di Marmilla, cioè venne investito di una
terra dell’Arborea.
Pietro
IV d’Aragona era un provocatore e, senza dubbio, un abile politico. Il problema
sardo fu tra i più sentiti. Il regno oltremarino poteva considerarsi
praticamente perduto, ridotto a due sole città della Sardegna: Cagliari e
Alghero. Eppure il sessantaquattrenne sovrano di Barcellona era ancora capace
di giocare bene le sue carte.
Non
sappiamo se i sardi di Oristano e del giudicato vennero a conoscenza che
Brancaleone era stato investito nominalmente di un territorio dell’Arborea. E’
probabile che ad Eleonora non restasse che prendere le distanze dallo sposo
imprudente, e seguire la volontà dei sudditi che chiedevano la guerra in un
momento inopportuno.
Furono
infatti i sardi di Oristano e di quelle contrade che indussero la giudicessa ad
abbandonare eventuali interessi personali e a proseguire la guerra nazionalista
che, si ricordi, doveva concludersi con la fine di una delle due entità
politiche per giustificare la propria ragione d’essere.
Evidentemente
si era formata, fra i più, una coscienza unitaria che impegnava fino al
sacrificio supremo. Non si spiega altrimenti il fatto che, malgrado Brancaleone
si trovasse nelle mani di Pietro il Cerimonioso, ed i catalano–aragonesi
stessero da tempo quieti nelle loro estreme roccaforti sarde, la “Nazione“ riprendesse la lotta ad
oltranza per la redenzione dell’isola intera.
Conseguenza ovvia della decisione di Eleonora
d’Arborea e dei sardi nazionalisti fu l’arresto a Barcellona di Brancaleone
Doria che nel 1384 fu condotto a Cagliari e rinchiuso nel complesso di
fortificazioni di San Pancrazio, dove venne maltrattato in tutte le maniere.
La
prigionia di Brancaleone condizionò la storia dell’Arborea e dell’isola per
molti anni. Dopo un fallito tentativo di fuga del marito nel gennaio 1386, la
giudicessa dovette far pressione sui sudditi perché venisse firmata una pace
con Pietro IV il Cerimonioso.
Nel
settembre dello stesso anno, muniti di credenziali datate 26 giugno 1386,
partirono per Barcellona il vescovo di Santa Giusta e il vice cancelliere
statale. Le trattative, che erano state precedute da una serie di accordi fra
le città di Bonifacio e di Alghero, fra gli aragonesi ed i genovesi, durarono
alcuni mesi, fino a dicembre. Ma, quando la bozza del documento stava per
essere approvata dalle due parti, la sera di Natale il re catalano si ammalò.
Spirò nella notte fra il 4 ed il 5 gennaio 1387.
Gli
successe il figlio Giovanni I.
In
quell’anno morì pure Federico, giudice nominale, evanescente figura della
storia sarda.
GIOVANNI I IL CACCIATORE (1350-1396)
DETTO ANCHE IL MUSICO O EL AMADOR DE TODA GENTILESA
RE D’ARAGONA – RE DI CATALOGNA – RE DI SICILIA
4°
RE DI SARDEGNA DAL 1387 AL 1396
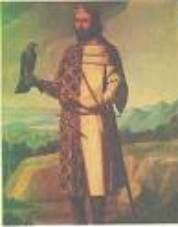 Successe
al padre Pietro IV il Cerimonioso, mentre stava per essere approvata la bozza
del documento di pace fra Arborea e Aragona.
Successe
al padre Pietro IV il Cerimonioso, mentre stava per essere approvata la bozza
del documento di pace fra Arborea e Aragona.
Fu
dunque con Giovanni I il Cacciatore, che Eleonora dovette riprendere le
trattative di pace interrotte per la morte di Pietro IV. Il venerdì 24 gennaio
dell’anno bisestile 1388 fu firmato, a Cagliari, l’accordo che riportò la
Sardegna alla situazione ante 1355. Fu una pace chiaramente estorta.
Brancaleone Doria (consorte di Eleonora) dirà qualche anno più tardi: “fatta malvagiamente con grande tradimento e
violenza”.
Malgrado
tutti i sacrifici, Brancaleone, fatto arrestare a Barcellona da Pietro IV e
condotto prigioniero a Cagliari nel 1384, fu liberato solo il 1° gennaio 1390.
Egli, provato da sei anni di prigionia e invelenito nei confronti degli
aragonesi, una volta libero si impegnò per rilanciare le aspirazioni
nazionalistiche della Sardegna e assunse un atteggiamento deciso nei confronti
dei funzionari reali, che gli attirò le simpatie dei sardi.
La situazione precipitò rapidamente tanto che l’anno dopo, il
primo aprile 1391, l’Arborea era di nuovo in guerra, con un appello a “tutti i sardi” dai quattordici ai
sessant’anni perché si tenessero pronti con “armi e pane per venti giorni”.
Brancaleone Doria e le brigate arborensi in poco tempo
ripresero Sassari, Osilo e tutta la Gallura, Sanluri e, il 3 ottobre, entravano
infine a Iglesias, sempre facilitati dalle popolazioni locali.
Secondo il parere degli storici più accreditati, in
quell’anno 1392, forse il giorno di Pasqua, Eleonora promulgò la Carta de Logu, il grande codice al quale si era lavorato fin dai tempi di
Mariano IV.
La Carta de Logu –
che non reca data – è una raccolta di leggi consuetudinarie di diritto civile e
penale per il giudicato o logu
d’Arborea (sappiamo che anche gli altri giudicati avevano proprie Carte oggi perdute) estesa poi dagli
aragonesi vincitori, nel 1421, a tutta la Sardegna, tranne che alle sei città
regie di Cagliari, Iglesias, Bosa, Alghero, Sassari e Castelsardo con statuti
speciali. Restò in vigore, da noi, fino al codice Feliciano del 1827.
Giovanni I, visto che Cagliari, Alghero e i Castelli di
Quirra ecc., resistevano malgrado i tentativi sardi di prendere le due città
più importanti, rimandò di mese in mese una sua partenza per la Sardegna alla
testa di un corpo di spedizione, ma nell’aprile 1394 rinunciò definitivamente
all’impresa.
Nell’estate del 1395 si recò invece a Maiorca e poi a
Perpignano per sfuggire al flagello causato, come in tutte le città d’Europa,
dalla peste bubbonica.
Anche l’isola subì tale flagello: morì almeno un terzo della
popolazione stimata allora, per Cagliari, di circa 10.500 abitanti.
Giovanni I diede un notevole impulso alla riorganizzazione
dell’amministrazione e alla restaurazione del sistema feudale che era stato
spazzato via. Si adoperò anche per favorire un forte flusso di cittadini che si
trasferissero dalla Spagna in Sardegna, nel tentativo di ispanizzare l’isola.
Egli, durante i suoi trasferimenti, accompagnato dalla moglie
e dalla corte, cacciava il cinghiale, come al solito, e s’occupava di politica.
Il giovedì 19 maggio 1396, in cammino da Torroella de Montgrì a Gerona, il re
morì in un oscurissimo incidente di caccia. Alcuni sostengono che fu un attacco
di cuore.
La corte di Giovanni I rimase famosa per fasto e lusso.
Gli successe il fratello Martino.
MARTINO I IL VECCHIO DETTO L’UMANO
(1356 – 1410)
RE
DI CATALOGNA – DI ARAGONA – DI SICILIA
5°
RE DI SARDEGNA DAL 1396 AL 1410
 A Giovanni I, che morì improvvisamente
il 19 maggio 1396 senza lasciare discendenza maschile, successe il fratello
Martino I duca di Montblanch.
A Giovanni I, che morì improvvisamente
il 19 maggio 1396 senza lasciare discendenza maschile, successe il fratello
Martino I duca di Montblanch.
Uomo di tempra diversa dal suo predecessore, abile politico,
dal 1392 era impegnato in Sicilia a sostenere le ragioni di suo figlio Martino,
suo omonimo. Quando lo raggiunse la notizia della morte di suo fratello
Giovanni con grande energia si predispose a raccoglierne l’eredità. A
Barcellona nominò reggente la moglie Maria de Luna che, con l’aiuto del conte
d’Urgel suo cugino, difese il trono da altri pretendenti e consolidò il potere;
in Sicilia stabilizzò la situazione consentendo a Martino junior di governare.
La Sardegna, ormai da tempo, era quasi totalmente in mano al
giudicato d’Arborea; del regnum
rimanevano ai catalano – aragonesi solo le città di Cagliari ed Alghero e
qualche castello. Insomma, stupisce ancora oggi la incapacità dei monarchi
catalano-aragonesi di comprendere che il regno di Sardegna e Corsica era ormai
finito per la Corona; vinsero all’ultimo perché – come disse qualcuno – non si
erano accorti di avere fallito l’impresa. Comunque Martino I comprese che,
malgrado la situazione militare molto debole, l’isola poteva essere recuperata.
Rex Martinus – come
si firmò nei diplomi ufficiali del 18 giugno – lasciò la Sicilia il 14 dicembre
di quello stesso anno 1396, per dirigersi a Barcellona, con scalo in Sardegna e
visitare i pochi resti del suo disgraziato regno al di là del mare.
Quando giunse nell’isola aveva quarant’anni. Era grasso,
gottoso, pacifico, religioso e compassionevole (per questo fu chiamato
l’Umano). Insomma, era tutto il contrario del frivolo e vanesio fratello.
A Cagliari, dove stette per un mese, e ad Alghero, dove
giunse l’8 febbraio del 1397, Martino il Vecchio si era dato ad incoraggiare le
guarnigioni, e a promettere e persino ad assegnare, ai sudditi fedeli, feudi e
terre non più controllate, comportandosi come se la situazione politica
dell’isola fosse del tutto transitoria e contingente. Egli, quindi, adottò una
politica di attesa.
Fra il 1401 e il 1403 ci fu una feroce ondata epidemica e
conseguente carestia ed era nuovamente comparsa la peste; l’isola fu nuovamente
prostrata per alcuni anni dal terribile morbo, la stessa Eleonora d’Arborea,
probabilmente, nel 1402 ne rimase vittima.
Negli anni successivi le due parti tentarono più volte di
trovare un accordo diplomatico, ma le clausole proposte si dimostrarono di
impossibile fattibilità. Il re d’Aragona si rifiutava di riconoscere
l’esistenza del giudicato d’Arborea come stato, non potendo rinunciare al
possesso della Sardegna e in particolare di Alghero e di Cagliari con le saline
più importanti dell’Europa di allora. Le due città, poi, erano sulla rotta
delle isole che interessava i traffici catalano–aragonesi nel Mediterraneo.
I
rapporti fra i due stati restavano comunque tesi. Un significativo documento di
Martino il Vecchio, indirizzato già nel 1399 alla sua flotta, indicava i nemici
della Corona che potevano essere attaccati indifferentemente per buona guerra : tutti i re saraceni e gli
infedeli del mondo; Brancaleone Doria ed i sardi suoi seguaci o coaderenti; gli
abitanti di Bonifacio e di Calvi in Corsica e, all’occasione, i pisani.
Nell’estate del 1404 l’Arborea aveva
ripreso nuovamente la guerra aperta coi catalano–aragonesi del regno di
Sardegna. Nel 1406 Brancaleone invade il cagliaritano e l’Ogliastra e riesce ad
espugnare il castello di Quirra per poi rivolgersi a nord. Questo voleva dire
che si riproponeva l’antico problema politico della soluzione finale.
Anche gli aragonesi si preparavano a
inviare la spedizione militare che, al comando di Martino il Giovane, avrebbe
dovuto risolvere definitivamente la questione sarda.
Terminati
i preparativi militari, Martino il Giovane, il 6 ottobre 1408, sbarcò a
Cagliari dove venne immediatamente ragguagliato sulle ultime vicissitudini
dell’isola.
Martino conosceva un po’ la Sardegna.
C’era già stato nel gennaio del 1405 quando, diretto a Barcellona, si era
fermato quattro giorni ad Alghero ed aveva preso coscienza delle tristi
condizioni nelle quali versavano le guarnigioni delle ultime roccaforti
catalano – aragonesi del regnum.
Perciò, ora, una volta a Cagliari, aveva preso a rincuorare i militari e i
popolani fedeli alla Corona concedendo, come fece suo padre undici anni prima,
grazie, benefici ed agevolazioni.
Il
3 dicembre 1408, eludendo la vigilanza di quattro galee siciliane di stanza ad
Alghero, Guglielmo III visconte di Narbona, diventato nuovo signore d’Arborea
al posto di Brancaleone Doria, sbarca con un piccolo seguito presso Sassari
trovandosi subito a doversi muovere in condizioni di disagio politico nei
confronti dei vassalli sardi, in un clima di reciproci sospetti.
Il
visconte si affrettò quindi a riattivare i canali diplomatici con Martino il
Giovane il quale, però, alzò il tono della sua politica di persuasione
accompagnandola con azioni militari dimostrative. Nel corso di queste manovre,
a fine anno 1408, veniva catturato l’ormai vecchio e stanco Brancaleone Doria
che silenziosamente in appartata prigionia si sarebbe spento agli inizi
dell’anno seguente. Non doveva quindi assistere all’elezione dell’ultimo
giudice d’Arborea, l’intruso aristocratico di Linguadoca, Guglielmo III di
Narbona, che avvenne il 13 gennaio 1409.
Fino al 1409 si registrò un’intensa
attività diplomatica tesa, inutilmente, a raggiungere un accordo di pace fra le
parti. Nel frattempo era stato provveduto ad avviare una economia di guerra con
la coniazione di tremila parvolini di
stagno e piombo (la mancanza di denaro aveva spesso costretto a pagare i
soldati in grano). Finalmente a metà maggio giungevano i sospirati rinforzi su
una flotta imponente valutata in 28 galee e 70 cocche (bastimenti rotondi da
trasporto). Li precedeva un cospicuo apporto di vettovaglie dalla Sicilia per
trasportare le quali occorsero 22 naus
grosse.
Il 12 giugno 1409 ebbe
inizio la battaglia, mentre lo scontro decisivo avvenne a Sanluri, all’alba del
30 giugno, di domenica. Quanto durò e come si svolse la lotta non è molto
chiaro; certo è che il combattimento fu aspro e accanito perché entrambi i
contendenti erano coscienti che lì si decideva della loro vita e del destino
del loro popolo. Il rapporto di forze era favorevole al visconte, che disponeva
di 20.000 uomini (3.000 dei quali formavano la cavalleria leggera, più
confacente alle prestazioni del cavallo sardo), il doppio circa del nemico il
quale, tuttavia, contava su una cavalleria di pari consistenza ma che, come la
fanteria, era dotata di armatura pesante. A questo si aggiunga che Martino
disponeva di alcune bombarde, malagevoli ma micidiali, nuove soprattutto per il
teatro bellico sardo.
Fu una disfatta per i sardi i quali,
secondo le fonti aragonesi – che certamente esagerarono – ma anche secondo il
racconto di Zurita nei suoi annali, lasciarono sul campo cinquemila soldati,
mentre altri quattromila furono fatti prigionieri. Coloro che non furono
catturati dagli aragonesi si ritirarono in fuga nel castello di Monreale, a
poche miglia di distanza dal luogo della battaglia; gli altri si rinchiusero nel
borgo fortificato di Sanluri che venne subito dopo attaccato ed espugnato e
dove le truppe regie si diedero al saccheggio e ad un inverecondo massacro
della popolazione civile. Vi morirono gran parte degli abitanti, passati a fil
di spada senza distinzione di sesso o d’età, nonché duecento balestrieri
genovesi e cento fanti francesi e lombardi: un migliaio di persone in tutto.
Mentre il Narbona, con il fior fiore della sua cavalleria, riuscì a fuggire
indenne e raggiungere la Francia.
Era l’inizio della fine dell’Arborea e
la fossa delle istanze nazionalistiche sarde. Ma fu anche la fine di Martino il
Giovane. Egli contrasse la malaria (la letale perniciosa) che nel giro di dieci
giorni, malgrado le cure di quattro medici, gli causò la morte, avvenuta il 25
luglio 1409. Martino fu sepolto con tutti gli onori nella cattedrale del
Castello di Cagliari, dove ancora oggi riposano le sue spoglie insieme a quelle
dei nobili catalani caduti in Sardegna per la causa d’Aragona.
Martino il Vecchio, prima ancora di lasciarsi
andare al suo grande dolore, si era preoccupato di non vanificare la morte del
figlio rinunziando ai vantaggi fino ad allora conseguiti in Sardegna.
Verso
la metà di agosto giunse a Cagliari, con salvacondotto reale, una compagnia
valenzana, i cui soldati erano considerati fra i più esperti combattenti, per
inviarla subito, col resto dell’esercito regio, all’attacco di Oristano dove,
il 17 agosto, furono contrattaccati e respinti dai sardi oristanesi. Ci furono
morti e feriti da entrambe le parti. Questo fatto d’arme, poco sconosciuto, è
chiamato nelle fonti la seconda battaglia.
Nei mesi successivi sbarcarono, a scaglioni, altre truppe di
rincalzo e aiuti che consentirono ai catalano–aragonesi di ottenere,
finalmente, l’annientamento del nemico e l’abbattimento della sua statualità e
nazionalità.
Il documento di capitolazione fu firmato
il 29 marzo 1410 dal giudice della città, Leonardo Cubello, e dal luogotenente
generale del re Martino il Vecchio, Pietro Torrelles. Esso prevedeva che “il regno d’Arborea venisse abolito di fatto
e trasformato, con la forza, in una entità subordinata: il Marchesato di
Oristano”.
Si concluse così la dispendiosa e
sanguinosa guerra che aveva impoverito e devastato tutta la Sardegna per quasi
cinquant’anni.
Martino I il Vecchio si occupò, durante
il suo regno, di lettere e di poesia, fu anche storico e umanista. Egli aveva
sostenuto con la sua politica i ceti popolari, alienandosi la nobiltà feudale e
la grande borghesia urbana.
Il re morì all’età di cinquantaquattro
anni, il 31 maggio 1410, colpito da un improvviso male, senza discendenti e
senza avere indicato il suo successore. Con lui si estinse la dinastia
aragonese discendente dagli antichi conti–re di Barcellona.
Seguì un periodo di interregno, sino al
1412, in cui il regno fu affidato ad un consiglio di dodici saggi. Gli
succedette Ferdinando I di Antequera.
Lo storico Francesco Cesare Casula, nel
concludere il capitolo dedicato a quel periodo, commenta: < se oggi la Catalogna e la Sardegna non sono
niente più che due semplici regioni appartenenti a due nazioni, da molti ancora
sentite come estranee per origini, lingua e cultura, è perché i due paesi, nel
medioevo, si combatterono e si uccisero reciprocamente >.
FERDINANDO I TRASTAMARA DI ANTEQUERA (1379-1416)
RE
D’ARAGONA – RE DI CATALOGNA – RE DI SICILIA
6°
RE DI SARDEGNA DAL 1412 AL 1416
 Per far fronte alla crisi dinastica e di
potere apertasi con la morte di Martino il Vecchio, avvenuta il 31 maggio 1410,
il governatore generale Gherardo Alemany nominò un consiglio di dodici saggi
che prese in mano la situazione del regno e fu incaricato di mantenere l’ordine
e di salvaguardare l’impero mediterraneo tanto faticosamente conquistato.
Successivamente il parlamento, riunitosi a Barcellona, designò una delegazione
col compito di risolvere la crisi dinastica.
Per far fronte alla crisi dinastica e di
potere apertasi con la morte di Martino il Vecchio, avvenuta il 31 maggio 1410,
il governatore generale Gherardo Alemany nominò un consiglio di dodici saggi
che prese in mano la situazione del regno e fu incaricato di mantenere l’ordine
e di salvaguardare l’impero mediterraneo tanto faticosamente conquistato.
Successivamente il parlamento, riunitosi a Barcellona, designò una delegazione
col compito di risolvere la crisi dinastica.
Dopo due anni di interregno, il 28 giugno 1412, i
rappresentanti dei regni della Corona, riunitisi a Caspe in provincia di
Saragozza, scelsero, fra i molti pretendenti, il nuovo re nella persona di
Ferdinando Trastàmara, detto di Antequera dal nome di una cittadina a nord di
Malaga, da lui strappata ai mori nel 1410. Fu così che sul trono d’Aragona la
dinastia castigliana si sostituì a quella catalana discendente dagli antichi
conti–re di Barcellona.
Ferdinando I, era figlio di Giovanni I di Castiglia e di
Eleonora d’Aragona figlia di Pietro IV. Egli era un buon combattente, un sagace
uomo politico e un abile diplomatico.
La nuova dinastia era di cultura castigliana e i suoi membri
erano gli assertori della trasformazione dello stato in senso assolutistico.
Questo processo, nei decenni successivi, causò la trasformazione della cultura
e della organizzazione del regno.
La diversità di cultura e di interessi costrinsero la nuova
dinastia ad affrontare una grave crisi politico – istituzionale che esplose in
Catalogna. La regione, fu la culla del regno d'Aragona essendo stata,
economicamente, il motore che aveva sorretto il formarsi dell’impero
mediterraneo. Quando Valenza sostituì Barcellona come capitale finanziaria
della Corona, l’economia catalana fu travolta da una grave crisi. Con
l’unificazione del regno d’Aragona con quello di Castiglia fu abbandonata la
lingua catalana a favore della castigliana che finì per diventare la lingua ufficiale
del regno di Spagna.
La fetta di Sardegna in mano al visconte Guglielmo III di
Narbona-Bas di quel che rimaneva del giudicato d’Arborea, si protendeva da
Sassari a Macomer come una spada tagliente nel vivo dei territori controllati
dalla Corona e la minaccia combinata Narbona-Genova era quindi una realtà
concreta.
Nel
1410, subito dopo la morte di Martino il Vecchio e in pieno periodo di
interregno, il visconte di Narbona, rientrò dalla Francia, dove si era
rifugiato dopo la sconfitta di Sanluri, per riorganizzare i territori giudicali
superstiti. Egli si installò a Sassari, nuova capitale giudicale, con
l’intenzione di trarre profitto dal relativo vuoto di potere. Fra i più
importanti provvedimenti adottati dal visconte in questo periodo ci fu quello
di attuare, per la prima volta nella storia giudicale, lo ius cudendi con la
coniazione di due sue proprie monete: la patacchina
e il minuto, entrambe di metallo
povero e di dimensioni molto piccole.
Fra le
azioni militari di rilievo intraprese in quell’epoca si ricorda che nella notte
fra il 5 e il 6 maggio 1411 alcune schiere di sardi–sassaresi e di francesi
agli ordini dello stesso visconte e di un figlio naturale del Conte Rosso,
Amedeo VII di Savoia, contando su una forza d’urto di 300 cavalieri e 150
balestrieri, tentarono un assalto alla villa fortificata di Alghero che per
poco non riuscì. Essi scalarono le mura e penetrarono all’interno dell’abitato
ma nonostante la sorpresa l’attacco si risolse con una sanguinosa disfatta. Il
figlio del Conte Rosso (di cui non si conosce il nome) fu fatto prigioniero e
decapitato in piazza. Da allora, ogni anno e per lungo tempo, fino al 1678, gli
algheresi festeggiarono l’anniversario dell’avvenimento bruciando, nella notte
fra il 5 ed il 6 maggio, un fantoccio con sembianze di soldato francese al
canto di:
O visconte di Narbona
Be haveu mala rahò
De vos escalar la terra
De molt alt rey d’Aragò
ecc. ecc.
Non appena superata la crisi istituzionale Ferdinando I
intavolò trattative e strinse alleanze con tutte le potenze d’Europa. Egli si
occupò immediatamente della Sardegna giacchè, ormai, sussistevano le condizioni
per una pacificazione generale, questa volta durevole, sostenuta anche dalla
Francia.
Nel giugno 1414 fu raggiunto un primo accordo in base al quale
il visconte Guglielmo III di Narbona–Bas avrebbe rinunciato ai propri diritti
sul giudicato d’Arborea e le terre regie in suo possesso, dietro pagamento di
153.000 fiorini (poi ridotti a 100.000) da corrispondere una parte in contanti
entro il gennaio 1415 e la parte restante nei tre anni successivi. La
soluzione, però, fu ritardata dalla mancanza della disponibilità finanziaria
necessaria. Seguirono una serie di manovre dilatorie che comunque misero il
visconte in una situazione senza altra via d’uscita. Infatti tirarsi indietro
non era più possibile. Di fronte al rischio di perdere il controllo, in parte o
in tutto, dei territori in mano sua apparve, per il visconte, più redditizio
stare ai giochi dilatori del sovrano.
Nel settembre 1414 poco dopo la notifica alla città degli
accordi col re d’Aragona, ci furono disordini entro le mura di Sassari. Va
probabilmente ascritta a quei giorni la nascita, fra i notabili, di un partito
filo-aragonese.
Con
il profilarsi del ritorno alla giurisdizione o comunque all’obbedienza regia di
altri centri urbani con attività portuali, Cagliari ma soprattutto Alghero
premevano perché venisse ribadito il loro ruolo esclusivo di caricatori del
grano in opposizione a Porto Torres, sbocco marittimo di Sassari, eletto dal visconte
di Narbona a piazza commerciale esclusiva dei suoi territori. Ancora Alghero
chiedeva nel luglio 1415 che fosse data facoltà agli ebrei di trasferirsi per
contribuire al suo ripopolamento dato che costoro piuttosto che abiurare o
sottostare a pesanti misure segregazioniste, tendevano a emigrare in Francia.
La locale comunità ebraica aveva molto contribuito alla floridezza economica
della cittadina ed ebbe un ruolo di rilievo nella lavorazione e nel commercio
del corallo, che i marsigliesi si recavano a raccogliere nel mare di Alghero.
Il 2 aprile
1416, a mezzogiorno, Ferdinando I morì di malattia, appena trentaseienne,
ritardando ulteriormente la soluzione del problema sardo. Gli successe suo
figlio Alfonso V il Magnanimo.
ALFONSO V IL MAGNANIMO (1396-1458)
RE
D’ARAGONA - RE DI SICILIA – 1° RE DI NAPOLI
7°
RE DI SARDEGNA DAL 1416 AL 1458
 Alfonso V aveva ventidue anni quando
successe al padre Ferdinando I di Antequera sul trono d’Aragona e fu destinato
a portare la Corona alla sua massima estensione territoriale. Giovane, dalla
personalità complessa era di piacevole aspetto, di buona cultura, di profonda
religiosità e di grande energia.
Alfonso V aveva ventidue anni quando
successe al padre Ferdinando I di Antequera sul trono d’Aragona e fu destinato
a portare la Corona alla sua massima estensione territoriale. Giovane, dalla
personalità complessa era di piacevole aspetto, di buona cultura, di profonda
religiosità e di grande energia.
Come suo padre, Alfonso I il Magnanimo, aveva radicato in sé
il concetto dell’assolutismo monarchico importato dalla Castiglia. Nei pochi
anni che stette in patria – appena dieci in quarantadue anni di regno (dal 1416
al 1419 e dal 1424 al 1431) – Alfonso si scontrò con le Corti del Paese, col
Consiglio di Barcellona, ecc., che manifestavano contro l’arbitraria nomina di
non catalani negli uffici pubblici di Catalogna, Sicilia e Sardegna. Eppure,
malgrado la forte opposizione interna, Alfonso V proseguì nel suo atteggiamento
dispotico, non cambiò la sua politica filo-castigliana che portò al declino
della Catalogna come forza trainante della confederazione iberica. Tutto ciò
mentre la corona era all’apice della sua potenza imperiale nel mediterraneo e
stava per raggiungere, con la conquista del napoletano, il suo massimo sviluppo
geografico.
Per conservare il possesso dell’impero mediterraneo
ereditato, era necessario chiudere all’influenza genovese la Corsica,
riaffermare il dominio aragonese in Sicilia e, possibilmente, estenderlo
all’intera Italia meridionale.
Per conseguire questi obiettivi Alfonso V predispose
un’importante apparato militare. Radunò una flotta di settantacinque navi e un
consistente insieme di fanti e cavalieri e, nel maggio del 1420, si imbarcò e
giunse ad Alghero il 14 giugno.
Al suo arrivo in Sardegna provvide, come prima azione, a
ratificare gli accordi di Saragozza del 25 maggio 1414 fra suo padre e
Guglielmo III di Narbona, sul contenzioso dell’ex giudicato d’Arborea. Con
l’isola totalmente – o quasi – sotto controllo, il regnum Sardiniae et Corsicae
raggiunse la sua massima e definitiva espressione storica. Atto emblematico fu
l’immediata contromarcatura (20 agosto 1420) delle uniche monete arborensi
coniate a Sassari (patacchine e minuti) le quali smisero di circolare,
per ordine del re, nel 1422.
Ritenendo pacificata la Sardegna, Alfonso si rivolse alla
Corsica. La spedizione non andò secondo le speranze regie; infatti l’isola non
divenne mai aragonese.
Nel gennaio 1421 l’impresa in Corsica poteva considerarsi
ormai fallita. Alfonso V decise quindi di recarsi a Cagliari per “mettere in ordine in brevissimo tempo il
regno di Sardegna”. L’isola, allora, era realmente in pessimo stato.
Contava circa 240.000 abitanti, duecentomila in meno rispetto alle stime di un
secolo prima, al principio della penetrazione catalano-aragonese. Si calcola
che 650 insediamenti dei 1.100 di cui si ha ricordo, fossero stati abbandonati
per cause naturali (alluvioni, pestilenze, ecc.).
A Cagliari fu indetta la grande assemblea di stato, che si
svolse nel palazzo regio del Castello dal 26 gennaio al 6 febbraio 1421. Gli
argomenti trattati furono di carattere generale e particolare. In cambio di
tutte le richieste presentate, fra le quali la estensione a tutta la Sardegna,
eccetto che alle città con statuto proprio, del codice di leggi promulgato da
Eleonora d’Arborea nel 1392 per il suo giudicato, e cioè la Carta de Logu, i tre stamenti
accordarono al sovrano un donativo di 50.000 fiorini d’oro d’Aragona, pagabili
in cinque anni. Da segnalare, inoltre, che dopo tale assemblea, molti sardi
finirono per essere investiti di uffici reali, anche di livello elevato.
L’azione amministrativa della nuova dinastia tese a unificare
la struttura burocratica del regno. Conseguenza di ciò fu l’introduzione da
parte di Alfonso V, già dal 1417, del vicerè; questo funzionario fu posto al di
sopra dei due governatori di Cagliari e Gallura, e di Sassari e Logudoro,
creati nel 1355 da Pietro IV. Insomma, era l’alter ego del sovrano in Sardegna
e aveva gli stessi poteri del re in materia politica, giudiziaria e militare.
Celebrato il parlamento, il sovrano si trattenne in Sardegna
ancora qualche tempo per riordinare l’amministrazione e per restaurare il
sistema feudale su nuove basi. Nonostante la guerra si fosse conclusa l’isola
non si risollevò mai più dai gravi danni subiti nel periodo precedente.
Col passare del tempo i poteri dell’aristocrazia feudale
crebbero nel corso dei decenni, anche per l’assenza di Alfonso V impegnato
nelle guerre nel napoletano. Il nuovo sistema prese a opprimere sempre più le
campagne spopolate, le produzioni agricole erano molto diminuite, i terreni
coltivati presero nuovamente a essere frequentemente devastati dal bestiame.
L’economia della Sardegna continuò a languire con la sola
eccezione di Cagliari che rimase una tappa obbligata della rotta per le isole e
riprese una certa vitalità, divenendo un considerevole centro di commercio
della Corona, mentre gli altri porti dell’isola divennero tappe facoltative
lungo le rotte commerciali aragonesi.
Alfonso V si staccò progressivamente dal mondo spagnolo e,
dopo avere delegato il governo a suo fratello Giovanni, si immerse totalmente
nella realtà italiana. Chiamato a Napoli dalla regina Giovanna II, che
adottandolo come figlio, lo oppose al pretendente Luigi III d’Angiò,
riconquistò gran parte di quel regno: ma sconfessato per la sua invadenza, fu
costretto a ritornare in Aragona nel 1423. Ritentò più volte la conquista del
regno di Napoli, prima nel 1432, poi alla morte di Giovanna II (1435) ed infine
con uno stratagemma riuscì a occupare la città il 12 giugno 1442.
Alfonso
vinse infatti l’assedio imitando quanto aveva escogitato secoli prima il
bizantino Bellisario: penetrò in città attraverso un acquedotto ormai in
disuso, sbucando nei pressi di Porta Santa Sofia. Qui una donna, che pare si
chiamasse Ceccarella, vide alzarsi il coperchio del pozzo di casa sua e uscire
un gruppo di armati che le tappò subito la bocca e rese poi vano ogni ulteriore
tentativo di resistenza di Renato d’Angiò. Di questa azione risolutiva sono
state rinvenute tracce tra i documenti della tesoreria aragonese che attestano
il pagamento di una certa cifra a due napoletani che suggerirono come entrare
in città, e l’assegnazione di una pensione annua di 36 ducati concessa vita
natural durante a Donna Ceccarella da Alfonso V.
L’anno seguente fu riconosciuto anche dal papa sovrano
legittimo del regno di Napoli e fu finalmente in grado di unire i tre regni:
quello di Napoli, di Sicilia e di Sardegna, ponendo fine ad una situazione che
si protraeva da secoli. A partire dallo stesso 1442 Alfonso V ricostruì il
vecchio Castel Nuovo o Maschio Angioino praticamente raso al suolo, in gran
parte anche per sua responsabilità, realizzando quanto di più aragonese si
possa concepire. Accarezzò vasti piani mediterranei sostenendo lo Sanderberg in
Albania contro i turchi, e stringendo relazioni con gli stati delle coste
africane e con l’Abissinia. Valorizzò il Tavoliere pugliese; si circondò di
spagnoli che occuparono cariche maggiori e minori impadronendosi del commercio.
Introdusse a Napoli istituzioni e costumi di Spagna (e, nella corte, la
lingua); fu perciò assai malvisto come straniero.
Intanto nel 1441 trovò il tempo di trasformare tutto il
“diritto” di Alghero sostituendolo con quello vigente a Barcellona. In realtà,
tanto Alghero quanto il Castello di Cagliari furono vere colonie catalane
inserite nel territorio sardo.
Alfonso V il Magnanimo fu uomo di cultura rinascimentale.
Campione dell’umanesimo al punto che nei saccheggi dava l’ordine perentorio di
salvare tutti i libri. Una volta consolidato il proprio potere, tenne corte
magnifica a Napoli che divenne un centro artistico e culturale di prim’ordine.
Celebri divennero le serate letterarie della sua corte e la biblioteca reale
che crebbe grazie ai continui acquisti. Fondò l’accademia napoletana e, nel
1455, avviò la costruzione dell’arco di trionfo nel quale Alfonso V ha voluto
lasciare memoria disponendo che fosse raccontato il suo ingresso trionfale
nella città, su un carro tutto d’oro trainato da quattro cavalli bianchi, con
tanto di seguito di gentiluomini, cavalieri, guerrieri e figure allegoriche.
Folle di napoletani plaudenti e osannanti lanciano fiori e salutano il nuovo
re. Un falso storico fra i più clamorosi. Il suo interesse per la politica
italiana lo portò a disinteressarsi degli affari di Aragona e a occuparsi in
misura crescente dei problemi napoletani.
In Spagna promosse una rinascita culturale, si sforzò di
fondere catalani e castigliani e, continuando la tradizione catalana di
espansione nel Mediterraneo e in Italia, gettò le basi della politica seguita
poi da Ferdinando il Cattolico.
Nel 1458 morirono, senza lasciare eredi legittimi, sia
Alfonso V il Magnanimo che l’amata moglie Maria di Castiglia, abile
luogotenente regio durante le lunghe assenze del marito.
Per testamento Alfonso V aveva lasciato il regno di Napoli
(conquistato a prezzo di tanto sangue e denaro catalano-aragonese il 12 giugno
1442), al figlio illegittimo Ferdinando I duca di Calabria (1431-1494) –
legittimato nel 1443 - , e la corona d’Aragona – isole comprese – al fratello
Giovanni.
GIOVANNI II IL SENZA FEDE (1398-1479)
RE D’ARAGONA – RE
DI SICILIA – RE DI NAPOLI
8°
RE DI SARDEGNA DAL 1458 AL 1479
 Giovanni
II il Senza Fede successe al fratello Alfonso V il Magnanimo nel 1458. Il suo
regno fu disastroso per la confederazione iberica a causa del dispotismo senza
scrupoli del monarca il quale combattè contro figli, parenti e sudditi facendo
precipitare il paese in una delle più brutte guerre civili della storia.
Giovanni
II il Senza Fede successe al fratello Alfonso V il Magnanimo nel 1458. Il suo
regno fu disastroso per la confederazione iberica a causa del dispotismo senza
scrupoli del monarca il quale combattè contro figli, parenti e sudditi facendo
precipitare il paese in una delle più brutte guerre civili della storia.
Sposato
a Bianca di Navarra dal 1425 – dalla quale ebbe il figlio Carlo, principe di
Viana – aveva preso ad amministrare il piccolo stato che riuscì a tenere anche
dopo la morte della moglie, incurante dell’avversione dell’aristocrazia
navarrina.
Nel
1447 si era risposato con Giovanna Enriquez dalla quale ebbe, nel 1452,
Ferdinando, destinato a unire, con Isabella la Cattolica, le due corone
d’Aragona e di Castiglia dando origine, nel 1479, alla Corona di Spagna.
La
sua contorta personalità lo spinse ad assumere una condotta poco leale nei
confronti del fratello Alfonso V, approfittando della sua lontananza,
canalizzando il malcontento dei catalani in una serie di ribellioni aperte e
quando, a sua volta, nel 1436, fu nominato reggente del regno d’Aragona, si
trovò in una difficile situazione.
Una
volta divenuto re avviò con decisione la trasformazione del governo dei suoi
stati in senso assolutistico. All’inatteso mutamento gli aristocratici
navarrini e catalani si ribellarono apertamente. I ribelli individuarono come
suo antagonista il primogenito Carlo principe di Viana inasprendo una triste
vicenda familiare.
Le
ragioni della guerra civile erano note: fin dal 1425, alla morte del suocero,
Giovanni II aveva impedito al figlio Carlo di diventare re di Navarra e, una
volta salito al trono, nel 1458, non gli aveva voluto riconoscere i diritti di
primogenitura. Nel 1460 dispose l’arresto arbitrario di Carlo di Viana ma i
catalani – che odiavano Giovanni e amavano Carlo – si erano allora sollevati e
avevano fatto liberare il principe dopo circa sei mesi di prigionia. Purtroppo,
Carlo di Viana morì nel settembre del 1461, lasciando il paese profondamente
diviso. La guerra civile proseguì cruenta ancora per dieci anni. I rivoltosi si
arroccarono in Barcellona, ma alla fine vinse il bizzarro ed acciaccato
Giovanni II che, il 17 ottobre 1472, entrò trionfante nella capitale
riproponendo la sua autorità fino alla morte.
Giovanni
II disgustò i catalani anche per avere alienato alla Francia il Rossiglione, e
ne provocò la ribellione.
Nello
stesso anno in cui Giovanni dispose l’arresto del figlio Carlo, cioè nel 1460,
a Fraga il re aveva dichiarato unito per sempre alla Corona il regno di
Sardegna e di Corsica.
Negli
ultimi anni di regno di questo sovrano avvenne in Sardegna la rivolta di Leonardo
de Alagon che già da tempo s’andava maturando. Leonardo de Alagon discendeva da
un’antica famiglia aragonese che nel 1119 aveva preso il nome dalla omonima
cittadina strappata ai mori dal capostipite Lope Garcés. Fra i suoi avi contava
una figlia naturale di Pietro II il Grande e molti altri illustri progenitori
imparentati con regnanti e nobili catalani. Egli era nato forse a Oristano nel
1436 ed era stato un fedele consigliere di Giovanni II.
Nel
1470 era morto senza prole il marchese di Oristano Salvatore Cubello che lasciò
il feudo e i beni al nipote Leonardo e al figlio di lui Salvatore, e agli altri
nipoti. Evidentemente la potenza dei Cubello–Alagon faceva paura giacchè, senza
contare i rami collaterali residenti nell’isola e nella penisola spagnola, la
famiglia controllava, coi soli fratelli di Leonardo, più di un terzo della
Sardegna.
A
questa successione si era opposto il vicerè Nicolò Carroz d’Arborea, il quale
sosteneva la tesi del “mos italiae” cioè l’obbligo di restituire le terre feudali
alla corona in mancanza di discendenza diretta maschile della famiglia
marchionale. Il che provocò una sollevazione armata seguita da uno scontro, nel
1470, con le schiere catalano-aragonesi. Vinsero i sardi, uccidendo un gran
numero di soldati e catturando parecchi cavalieri.
Il
re Giovanni II intervenne scrivendo due lettere, al vicerè e ai feudatari, con
le quali dava in qualche modo ragione a Leonardo de Alagon e, nell’ottobre del
1474, fu firmata una convenzione in base alla quale furono riconosciuti i
diritti di Leonardo de Alagon sul marchesato di Oristano.
Nonostante
la concordia del 1474, il vicerè Nicolò Carroz insistette nel suo atteggiamento
ostile nei confronti del marchese di Oristano spingendolo alla rivolta e
facendolo passare dalla parte dei nemici della Corona. Inutilmente Leonardo de
Alagon tenne a precisare che combatteva “contro il vicerè, non contro il re”.
A
molti egli appariva non come un feudatario deciso a difendere le proprie
prerogative nei confronti della prepotenza di un vicerè, ma piuttosto come un
personaggio deciso a rivendicare i diritti dinastici sul cessato giudicato
d’Arborea.
Il
conflitto armato ricominciò nel 1475 e coinvolse diverse migliaia di uomini
d’arme. Si concluse il 19 maggio 1478 nell’altipiano di Macomer con la totale
disfatta dei sardi ribelli. Leonardo de Alagon fu fatto prigioniero e rinchiuso
in un castello presso Valenza dove morì un anno imprecisato dopo il 1494.
Il
marchesato di Oristano e la contea del Goceano furono confiscati dalla corona
la quale provvide alla sua amministrazione fino alla venuta dei piemontesi
nell’isola, nel 1720. Ed è così che i duchi di Savoia assunsero, insieme al
titolo di re di Sardegna, anche quello di marchesi di Oristano e conti del
Goceano.
Un
anno dopo, il 19 gennaio 1479, morì il vecchio e bisbetico Giovanni II il Senza
Fede. Gli successe il figlio Ferdinando II, già sposato da dieci anni con
Isabella di Castiglia. Con essi si realizzerà e si completerà il progetto di
riforme voluto da Giovanni II, che porterà all’unificazione dell’intera Spagna.
FERDINANDO II IL CATTOLICO (1452-1516)
RE D’ARAGONA – RE DI VALENZA – RE DI SICILIA –
RE DI NAPOLI
9°
RE DI SARDEGNA DAL 1479 AL 1516

Ferdinando II detto il
Cattolico, indotto da suo padre Giovanni II il Senza Fede, aveva sposato nel
1469 Isabella di Castiglia. Quando nel 1474 salì al trono di Castiglia,
Isabella ereditava un regno dove l’anarchia feudale era giunta al massimo. Il
conseguente confronto armato con i pretendenti fu inevitabile e Ferdinando ebbe
la meglio riuscendo così a rendere stabile il governo di sua moglie in
Castiglia. Insieme fermarono l’anarchia feudale, fecero giustiziare i
responsabili e riportarono l’ordine nel piccolo regno.
Nel
1479 morì suo padre, Giovanni II re d’Aragona, e Ferdinando II ereditò i regni
d’Aragona, di Valenza, di Sardegna, di Sicilia e di Napoli creando i
presupposti per la realizzazione di una effettiva unità dell’intera Spagna.
Nella
seconda metà del quattrocento Barcellona si trovò al centro di una grave,
prolungata crisi di potere che investì città e campagne della Catalogna
vecchia. Si apriva un decennio (1462-1472) di turbamento politico durante il
quale gli oligarchi si trovarono contro quelli della montagna, che svolsero un
ruolo non indifferente nel successo militare della Corona. Solo in forza del
ruolo decisivo svolto da Ferdinando il Cattolico con la sentenza arbitrale di
Guadalupe, che regolamentava le relazioni giuridico-sociali, certificandone la
funzione di garante assoluto della pace e dell’ordine, fu consentita la
restaurazione del principio dell’autorità sovrana.
Ferdinando
II e Isabella diedero vita ad un governo diarchico attuando un programma
autoritario e accentratore. Adottarono una forte limitazione dei poteri dei
grandi feudatari; abolirono qualsiasi potere politico delle “corti”; fu
limitata la dipendenza della chiesa spagnola dalla curia di Roma, avocando al
re la nomina dei titolari dei benefici ecclesiastici e trasformando
l’inquisizione in tribunale di stato per il “controllo della vita spirituale
dei sudditi ”.
Nel
1492 la conquista di Granada, ultimo caposaldo arabo, e la conquista
dell’America aprì le porte per la costituzione di un impero mondiale. Inoltre
la politica che i due sovrani adottarono nei confronti della Francia consentì
la riconquista del Rossiglione, nonché la cessione del Napoletano alla Spagna.
Il
regno di Ferdinando II e di Isabella coincise con un momento di grande
fioritura culturale, da loro fortemente favorito.
Durante
il lungo regno di Ferdinando II la storia della Sardegna cominciò ad assumere i
caratteri della perifericità e dell’isolamento. Anche per essa la seconda metà
del quattrocento fu un’epoca di grave crisi interna, le cui radici affondano
nell’assenteismo regio. Quindi l’isola fu investita dalle nuove riforme
adottate e rese simili a quelle degli stati della terraferma: furono ridotti i
poteri dei grandi feudatari e limitati i loro privilegi. L’attività e il potere
politico, amministrativo e giudiziario del vicerè furono radicalmente
riformati. Le vicende che avevano portato al confronto armato fra Carroz e
Alagon (1470-1478) avevano destato non
poche inquietudini e fatto temere in una ripresa nell’isola della resistenza a
carattere nazionale. L’inquisizione, intesa come organismo di controllo
dell’ortodossia, fu introdotta in Sardegna nel 1492, lo stesso anno della
cacciata degli ebrei. Funzionò a Cagliari, nel convento di San Domenico, fino
al 1561, e fu accettata con molta sofferenza dai cagliaritani.
Nel
marzo del 1492 giunse al vicerè l’editto col quale veniva stabilita la cacciata
degli ebrei dalla Sardegna, che fu un altro elemento del processo di
omologazione dell’isola al resto della Spagna.
Le
sinagoghe e le case degli ebrei furono sigillate e fu fatto un inventario dei
loro beni. Le sinagoghe furono successivamente convertite in chiese cattoliche
intitolate alla Santa Croce. La vendita in tempi brevi delle case e dei
fabbricati fece crescere sul mercato l’offerta: oro, argento, case, terreni e
altri immobili furono così venduti a prezzi molto inferiori al loro valore
reale.
Sembra
che l’operazione sia stata completata entro il 31 luglio dello stesso 1492.
Cessarono così di esistere nelle città più importanti dell’isola, ma
soprattutto a Cagliari e ad Alghero, fiorenti comunità che si erano sviluppate
a partire dal XIV secolo.
Gli
ebrei praticavano attività molto redditizie nel campo finanziario, molti di
loro erano anche apprezzati professionisti; le loro disponibilità finanziarie
furono molto utili agli aragonesi durante la guerra contro gli Arborea, infatti
contribuirono largamente a finanziare le campagne militari in più di una
occasione. Nonostante queste indubbie benemerenze i rapporti fra la comunità
ebraica e il resto della popolazione – alimentati da ignoranza e pregiudizi –
non furono mai tranquilli. Ciononostante essi riuscirono a vivere e a difendere
i loro privilegi e, in certi casi, ad estenderli. Non solo, quando nel 1391 in
Spagna furono perpetrati spaventosi eccidi di ebrei, le comunità sarde avevano
continuato a vivere tranquillamente, anche perché la protezione interessata dei
sovrani non venne meno in questa occasione.
Molti
ebrei, soprattutto professionisti e abili amministratori, trovarono protezione
presso alcuni feudatari e riuscirono a rimanere nell’isola integrandosi
successivamente. Nel complesso, comunque, lasciarono la Sardegna alcune
migliaia di persone dirette in Francia e moltissimi verso l’oriente. Coloro che
rimasero nell’isola cercarono di integrarsi e, in alcuni casi, si inserirono
nell’aristocrazia sarda di alto livello. Le altre famiglie di più modesta
condizione continuarono a vivere tranquillamente, senza che nei loro confronti
fossero state adottate discriminazioni di alcun genere.
Il
processo di assimilazione dell’isola agli altri regni della Corona fu
completato durante il lungo regno di Ferdinando II. Ma il fatto più importante
raggiunto agli inizi del XVI secolo fu la scomparsa della incomunicabilità fra
sardi e catalano-aragonesi; faticosamente, ma senza tentennamenti, essi avevano
imparato a convivere. Nel 1510 Ferdinando II abolì formalmente il divieto per i
sardi di soggiornare nel Castello di Cagliari durante la notte, divieto che
risaliva al 1326 e introdotto subito dopo la cacciata dei pisani. Il
provvedimento può essere considerato come la fine di una fase di evoluzione
dell’assetto culturale e sociale nell’isola; insomma il processo di fusione fra
sardi e spagnoli si era compiuto attraverso la convivenza pacifica.
Nonostante
la lunghissima guerra che aveva impoverito e quasi spopolato l’isola, i sardi avevano
conservato la loro coesione etica, la loro lingua, la memoria delle loro
antiche istituzioni legislative (la Carta
de Logu era stata estesa a tutta la Sardegna). Dal canto loro, gli abitanti
di origine spagnola avevano allentato i legami con la terra d’origine e
sentivano l’isola come la loro propria patria.
Per
quanto riguarda il livello culturale è opportuno ricordare una discreta
circolazione di manoscritti tra le persone colte delle città. L’attività
letteraria nella società urbana sardo-catalana appare ben animata e conseguente
ad una discreta circolazione dei primi incunaboli dovuti all’avvio
dell’attività di stampa. Nell’ottobre 1493, quando non era ancora stata
introdotta la stampa in molte città importanti d'Europa, Salvatore da Bologna
stampò a Cagliari il primo incunabolo per conto di Nicola Dagreda, stampatore
aragonese (si tratta dello Speculum
Ecclesiae del quale si conserva un solo esemplare a Palma di Maiorca). Sono
inoltre da ricordare alcune manifestazioni popolari di valore letterario come i
goigs (detti in sardo gosos o goccius). Questa forma di canzone,
portata in Sardegna già nel XIV secolo dalla Catalogna, ebbe un notevole
successo. Altra manifestazione della cultura popolare furono le “cobles de la conquista de francesos ”,
una poesia popolare profana di Alghero che ogni anno si cantava per ricordare
la sconfitta del visconte di Narbona sotto le mura della città, nel 1412; il
canto diventò parte della cultura popolare tanto da essere visto come
espressione della rivalità con Sassari.
Altra manifestazione di
particolare rilievo è la pittura che si sviluppò e venne sostenuta non solo
dalla committenza dei ricchi mercanti e dei feudatari. Accanto ai maestri
catalani cominciarono a operare anche pittori sardi. Si formarono così le scuole
di pittura sardo-catalane come quella di Stampace a Cagliari, dove operava la
famiglia Cavaro la quale espresse, nel corso di alcune generazioni, artisti di
notevole personalità; Juan Barcelo, pittore catalano residente ad Alghero; il
Maestro di Castelsardo e altri.
L’architettura
sardo-catalana si espresse al massimo nelle cattedrali, ma anche nelle chiese
dell’interno. I modelli catalani furono attuati in Sardegna in forme talvolta
originali, come il magnifico complesso di San Domenico di Cagliari, nelle
chiese iglesienti e in molte altre in tutta l’isola. Rimangono testimonianze di
statue lignee provenienti dalla Catalogna ma molte fatte anche in Sardegna, di
magnifici crocifissi e di preziose argenterie che dimostrano la vivacità
dell’arte sacra catalano-sarda.
Sotto
Ferdinando II il Cattolico vide la luce la nuova moneta chiamata “cagliarese”
emessa dalla zecca di Cagliari diventata, nel frattempo, la più importante
dell’isola confermandosi “zecca reale” o “zecca del Regno di Sardegna”. Questa
moneta avrà fortuna: tutte le monete minute che si batteranno d’ora in poi a
Cagliari e a Torino avranno questo nome, che troveremo ancora in una moneta di
Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1813.
Nel
1504 la morte della regina Isabella provocò una intricata situazione
successoria. I due sovrani avevano avuto una sola figlia, Giovanna, che si era
sposata con l’arciduca Filippo d’Asburgo, figlio dell’imperatore Massimiliano
I. Giovanna era l’erede legittima della Castiglia e dei possessi americani, di
cui cedette il governo a suo marito Filippo. Quando nel 1506 quest’ultimo morì,
Ferdinando II approfittando delle condizioni di salute di sua figlia, impazzita
per la morte del marito, e della minore età di suo nipote Carlo, riuscì a unificare definitivamente la Castiglia e
l’Aragona continuando a regnare, come re di Spagna, sino al 1516.
Nell’ultima
fase del suo regno Ferdinando II il Cattolico, conquistò la Navarra e vide
crescere la potenza del regno di Spagna. Morì nel gennaio 1516 lasciando come
erede suo nipote Carlo I d’Asburgo.
CARLO I D’ASBURGO - V IMPERATORE (1500-1558)
I
RE DI SPAGNA – RE DI SICILIA – RE DI NAPOLI
10°
RE DI SARDEGNA DAL 1516 AL 1556
 Figlio dell’arcidura d’Austria Filippo
d’Asburgo detto il Bello, e di Giovanna di Spagna detta la Pazza, fu l’erede
sia delle tradizioni sia delle aspirazioni delle due casate – di Castiglia e
d’Aragona - cui si univano quelle dei signori di Borgogna, dai quali Carlo
discendeva.
Figlio dell’arcidura d’Austria Filippo
d’Asburgo detto il Bello, e di Giovanna di Spagna detta la Pazza, fu l’erede
sia delle tradizioni sia delle aspirazioni delle due casate – di Castiglia e
d’Aragona - cui si univano quelle dei signori di Borgogna, dai quali Carlo
discendeva.
Carlo d’Asburgo a soli sedici anni ereditò per parte di suo
padre, l’arciduca Filippo d’Asburgo, il regno di Castiglia, di Leon e tutte le
colonie americane; da sua nonna, Maria di Borgogna, le Fiandre, l’Artois, la
Franca Contea; da suo nonno materno, Ferdinando II d’Aragona il Cattolico, la
Catalogna, il Rossiglione, i regni di Napoli, di Navarra, di Sardegna e di
Sicilia.
Quando poi, nel 1519, suo nonno paterno, l’imperatore
Massimiliano I d’Asburgo morì, Carlo ereditò i paesi austriaci, la Boemia,
l’Ungheria e la dignità imperiale del Sacro Romano Impero, ereditaria nella sua
casa.
Fu
così che nacque il più vasto impero dell’epoca, tanto che il sovrano poteva
vantarsi di avere un regno sopra il quale
il sole non tramontava mai. Per
fare fronte ai problemi del suo sconfinato potere, Carlo V fu proiettato in una
dimensione nella quale dovette misurarsi con tutti i travagli politici e
religiosi del suo tempo. La dispersione geografica, culturale e istituzionale
della grande quantità di stati che da lui dipendevano, pose al nuovo sovrano e
alla sua corte problemi di governo di non facile soluzione.
Per l’elezione imperiale Carlo dovette però entrare in
competizione con Francesco I di Francia, e solo l’oro sparso a profusione sui
principali elettori gli consentì di ottenere il sopravvento nello stesso 1519.
L’anno successivo, il 23 ottobre 1520, ad Aquisgrana, ebbe luogo la sua
incoronazione.
La formazione e i consigli dei collaboratori diedero una
impronta assolutamente originale alla sua politica. Imbevuto di conoscenze
profonde sulla funzione dell’impero, che gli derivava dalla lettura del “De
Monarchia” di Dante, in sintonia con il suo gran cancelliere Mercurino di
Gattinara, diede corpo all’immagine medioevale del primato dell’impero e alla
funzione provvidenziale di guida della cristianità. Erasmo da Rotterdam fu suo
consigliere personale e per lui scrisse “L’istitutio principis christiani”.
I suoi stati assunsero una consistenza veramente imponente
che inasprì la vecchia rivalità fra la Spagna e la Francia, rivalità che
continuerà nei secoli futuri fra i Borboni e gli Asburgo. La politica
egemonistica ed espansionistica dei due stati condusse ad una lunga e
sanguinosa guerra che sconvolse l’Europa e il Mediterraneo e coinvolse anche
altre potenze europee. Essa durò circa quarant’anni – dal 1521 al 1559 – e si
svolse soprattutto in Italia (la stessa Roma subì un terribile saccheggio) che
fu completamente asservita al nuovo imperatore. Carlo stesso venne in Italia
per compiere l’antico rito medievale dell’incoronazione: a Bologna il 22 ed il 24 febbraio 1530 Clemente VII gli pose
sul capo rispettivamente la corona ferrea (o corona del regno d’Italia) e
quella imperiale.
Le ragioni che fecero scoppiare le guerre fra Carlo V e il re
di Francia, Francesco I, sono molte e di differente natura: dinastiche,
religiose, culturali; sostanzialmente però i due si disputarono il primato in
Europa.
Per Carlo V le continue e ingenti spese militari furono rese
possibili in buona parte dalle rendite in oro e argento che gli provenivano
dalle colonie e che, se anche non regolari, erano sempre cospicue.
La posizione del regno di Sardegna nei confronti di Carlo V,
formalmente non era mutata. Gli affari più importanti continuarono ad essere
esaminati dal Supremo Consiglio d’Aragona (che assunse un’importanza notevole)
e ad avere nel vicerè il legame diretto con la Corona. Sostanzialmente, però,
le cose per il piccolo regno erano cambiate in modo radicale: gli interessi non
erano più circoscritti al mediterraneo ma divennero universali il cui centro
era nell'Europa continentale e nell’Atlantico.
Per lui, improvvisamente, la Sardegna era diventata un paese
lontano, quasi estraneo e sconosciuto, almeno per il momento. Carlo V, a parte
le sue fugaci apparizioni a Cagliari e ad Alghero in occasione delle spedizioni
a Tunisi e ad Algeri, finì per essere un sovrano quasi inaccessibile. Va infine
detto che la lontananza impediva al sovrano di comprendere la situazione
interna della Sardegna, ma non gli impediva di considerare l’isola come
importante elemento della politica mediterranea, come caposaldo militare, per
esempio, nella guerra contro i turchi.
Nel febbraio 1525 alla battaglia che si svolse a Pavia contro
Francesco I che, allestito un grande esercito, tentò di riconquistare Milano,
presero parte anche alcuni nobili sardi inquadrati nelle truppe spagnole. La
battaglia si concluse con la sconfitta dei francesi e la prigionia del re di
Francia che fu condotto a Madrid, dove fu costretto a firmare un trattato di
pace, trattato che sanciva la supremazia di Carlo V in Europa.
Le fortune della Spagna sembravano inarrestabili: nel 1526 le
truppe spagnole cacciarono gli Sforza da Milano e attaccarono il Papa; nel
maggio 1527 saccheggiarono Roma e catturarono il pontefice.
Nello stesso anno 1527 una flotta francese, al comando di
Andrea Doria (che in seguito si avvicinerà a Carlo V), assalì il nord
dell’isola indifeso. Sbarcarono lungo le coste settentrionali circa quattromila
uomini che devastarono il territorio presso Sorso e, il 30 dicembre 1527, le
truppe francesi riuscirono a occupare la città di Sassari sino al 26 gennaio
dell'anno successivo. L’episodio servì a far capire l’importanza strategica che
l’isola poteva avere.
Ancora il Logudoro nella immediata primavera fu infestato da
un morbo pestilenziale proveniente dall’Italia che solo agli inizi del 1529
prese a estinguersi, dopo avere toccato nell’autunno precedente il suo vertice
entro le mura della già provata Sassari, dove avrebbe provocato più di 10.000
morti. La cifra è attendibile solo pensando ad un afflusso di gente dalle
campagne sotto l’incalzare dell’epidemia in congiunzione con una probabile
carestia dato che la città, pur essendo allora la più popolata dell’isola,
contava al meglio sui 15.000 abitanti.
Nello stesso periodo la Spagna dovette affrontare un
confronto con l’impero ottomano per il controllo del Mediterraneo. Il sultano
Solimano il Magnifico aveva iniziato l’offensiva verso l’occidente
terrorizzando l’Europa. I turchi conquistarono nel 1521 Belgrado e l’isola di
Rodi nel 1522. Investirono i Balcani, l’Ungheria e l’Austria con regolari
incursioni e, nel 1529, giunsero ad assediare Vienna.
Nel Mediterraneo la guerra non consentiva soste. La flotta
turca dilagava; nel 1529 l’esercito di Solimano conquistò Algeri e Penon, e nel
1534 Tunisi, da dove fu possibile organizzare spedizioni che interessarono le
coste dell’Italia meridionale.
Carlo V si trovò così impegnato in una grande guerra
parallela e insieme collegata a quella che combatteva contro il re di Francia.
La Sardegna fu teatro di frequenti incursioni dei corsari
africani e turchi. Nel 1520 i turchi erano sbarcati in Gallura e avevano
distrutto Caresi. Inoltre avevano tentato più volte sbarchi in tutta l’isola: a
Oristano, Sant’Antioco, Pula, Carbonara,
ma erano stati sempre respinti. Nel 1524 e nel 1525 avevano tentato di
sbarcare nel Sulcis; nel 1527 navi turche collegate a quelle francesi avevano
investito senza successo Castelsardo e Oristano. In effetti, tutte queste
imprese avevano posto la Sardegna in una situazione simile a quella che i sardi
dovettero affrontare alcuni secoli prima, quando l’isola, abbandonata dai
bizantini, fu costretta con le sue forze a difendersi dalle incursioni degli
arabi.
Per far fronte alla situazione Carlo V, con l’appoggio del
papa, predispose una spedizione contro Tunisi che assunse il carattere di una
vera e propria crociata. La grande flotta si radunò nel golfo di Cagliari da
dove, il 13 giugno 1535, partì alla volta di Tunisi. A tale proposito due
lapidi commemorative campeggiano ancora oggi sulla facciata dell’antico palazzo
comunale di Castello, e nell’atrio della chiesa di San Michele. La spedizione,
cui presero parte molti gentiluomini sardi, si concluse felicemente con la
cacciata del terribile corsaro Barbarossa e la conquista della città africana,
il 25 luglio.
Nello stesso 1535 si riaccese la guerra fra la Spagna e la
Francia che portò nel marzo a una alleanza fra Solimano e Francesco I
determinando la trasformazione dei caratteri del confronto e dei rapporti di
forze nel Mediterraneo.
Il quadro internazionale andava quindi modificandosi. Al
sovrano non sfuggì l’importanza strategica che la posizione dell’isola aveva.
Cagliari e Alghero assunsero allora carattere di munite piazzeforti, che ne
segnò lo sviluppo fino al 1861, quando ufficialmente cessarono di esserlo.
Carlo V avviò una serie di interventi tesi a migliorare le difese e fece
costruire una serie di torri lungo le coste con funzioni di avvistamento e di
difesa. Fu chiamato lo specialista in fortificazioni Rocco Capellino al quale
fu affidato l’incarico di rinforzare le vecchie strutture e di costruirne di
nuove idonee a resistere ai proiettili scagliati dalle bocche da fuoco. A
Cagliari importanti e complesse furono le opere realizzate che interessarono
soprattutto le mura di Castello mantenendosi così sino ai nostri giorni. Ad
Alghero si rese necessaria una drastica trasformazione delle difese murarie che
portò alla riorganizzazione nel numero, nella dislocazione e nella consistenza
delle torri che da 26 furono ridotte a 6: circolari, maestose, fortissime. Nei
vent’anni di permanenza nell’isola il Capellino curò anche le opere murarie di
Oristano e Sassari.
Negli stessi anni si formarono milizie locali che avevano il
compito di concorrere alla difesa del territorio. Nel frattempo, con l’invasione della Provenza da parte delle
truppe spagnole, la guerra con la Francia si concluse nel 1538.
Nel Mediterraneo la situazione continuò ad essere difficile.
Solimano controllava quasi tutta la costa nordafricana e si era stabilito ad
Algeri da dove la flotta, al comando di Hassan Aga, un rinnegato sardo,
dominava il mare. Carlo V unitamente al papa e a Venezia, nel 1538 promosse una
Lega Santa contro la minaccia turca. Sul piano militare, però, sembrava che i
turchi fossero inarrestabili: i veneziani furono sconfitti sul mare, Solimano
riprese l’offensiva in Ungheria, il paese cadde quasi completamente in mano
turca e Ferdinando d’Asburgo, nel 1541, fu costretto a pagare un tributo al
sultano. Fu a questo punto che Carlo V decise, nello stesso anno, di inviare
una spedizione contro Algeri da dove le flotte turche di Solimano dominavano
sempre più il Mare Mediterraneo e tutto il Nord Africa.
Il
corpo di spedizione partì da La Spezia nel settembre del 1541 e fece scalo
nella rada di Porto Conte. Il sovrano decise un breve soggiorno ad Alghero, del
quale ci rimane una colorita e minuziosa descrizione. Egli si fermò due giorni,
il 7 e l’8 ottobre, visitando ed apprezzando la città e le sue strutture
difensive e partecipando ad una grandiosa battuta di caccia al cinghiale. Anche
se di cattivo umore a causa di un’afflizione respiratoria, il monarca si
concesse un momento di divertimento osservando da una finestra della “cambra
imperial” del palazzo dei de Ferréra in cui alloggiava, lo spettacolo di una
improvvisata corrida che i soldati della sua “armada” avevano inscenato nella
“placa de la ciutat”. E’ in quella occasione che Carlo V concesse, secondo
quanto si afferma, peraltro con ironia, l’Ordine di Cavalleria a tutti gli
algheresi con queste parole che la tradizione conserva: “Estodes (?) todos caballeros “.
La
flotta raggiunse l’Africa il 19 ottobre 1541. La spedizione andò male, gli
spagnoli furono sconfitti dagli algerini comandati da Hassan Aga e da allora le
flotte algerine e turche attaccarono ripetutamente le coste della Sardegna e
dell’Italia meridionale che rimasero costantemente esposte alle incursioni dei
corsari barbareschi.
Il decennio 1530-1540 fu particolarmente duro per l’isola,
esso si chiuse con una violenta carestia questa volta su scala isolana e di
tale intensità da doversi lamentare tanta necessità di pane e di carne di cui
non si aveva memoria. La gente moriva di fame in casa e per strada con scarso
sollievo per i meno abbienti nel ridursi a mangiare cani e topi.
Mentre le città difettando di grano potevano approvvigionarsi
all’estero, ben altra cosa era la situazione delle campagne. Qui si colloca un
orrendo episodio che ebbe protagonista una popolana del vescovado di Ales.
Questa poveretta dopo avere vagato per i villaggi con i due figlioletti alla
ricerca di una impossibile elemosina, nel gennaio 1541 (al culmine parabolico
della crisi) si ridusse a compiere l’atroce gesto di uccidere il più piccolo di
essi e di mangiarne le carni.
Pur senza toccare quel vertice, nei primi anni 40 continuarono
ad alternarsi annate di buon raccolto di cereali ad altre meno abbondanti. Alle
carestie si accompagnarono insorgenze epidemiche circoscritte agli strati
sociali più esposti per la loro inevitabile tendenza a sostenersi con erbe e
frutti selvatici.
Gli effetti cumulati di una così funesta serie di cattive
annate furono tali da fare emergere nel parlamento Cardona (1545) il quadro di
un generale stato di estrema povertà. In quella sede le città del Logudoro,
dove crisi epidemiche e di sussistenza si combinarono con gli eventi bellici e
i loro strascichi (dai saccheggi agli alloggiamenti, pur essi gravosi, di
truppe regie) furono concordi nel lamentare consistenti falcidie demografiche:
nel Logudoro, ad Alghero e soprattutto a Sassari. Anche Oristano lamenta un
decremento del 40%. La dimensione demografica di Sassari, tra la fine del XV e
prima metà del XVI secolo, se non poteva competere con Saragozza, tantomeno con
Barcellona e Valencia, era tuttavia tale da reggere il confronto con le altre
principali città dei regni continentali della Corona. Solo Cagliari fu l’unica
fra le città regie a denunciare un incremento continuo di popolazione, tanto da
consentirle il sorpasso demografico nei confronti di Sassari già dalla metà dei
seicento.
Contro la recrudescenza dei furti di bestiame dovuti in parte
al riflesso sociale del malessere economico e demografico di quegli anni fu
adottata, dallo stamento militare del parlamento Cardona, la sospensione delle
composizioni pecuniarie a favore di esemplari pene corporali sino alla
mutilazione. Per il primo furto subentrava la mutilazione col tagli
dell’orecchio, mentre a chi trasferiva bestiame senza certificazione veniva
tagliato il pugno o inchiodata la mano. Va da sé che gli ufficiali baronali,
essendo essi i più potenti padroni di bestiame, usavano un occhio di riguardo
verso i propri pastori, che così potevano continuare ruberie e malversazioni.
Cagliari in quanto capitale del regno diventa luogo deputato
delle tensioni quindi sulla scena cagliaritana, quando premono le difficoltà
congiunturali, burocrazia e ceti tendono a schierarsi attorno ai principali
nodi del potere, in un groviglio inestricabile di ragioni politiche e interessi
di parte. Nel decennio a cavallo del 1540 due istituzioni si offrono al caso:
l’una la viceregia, che, in virtù della preminenza giuridica conferitagli dai
poteri luogotenenziali, applica l’autorità del re, a lui solo rispondendone;
l’altra, il Santo Ufficio, il quale dipendendo direttamente dalla Suprema, che
ne è delegato, a sua volta ne riconosce la supremazia in Sardegna.
Il nuovo inquisitore, che avrebbe retto la carica per tutta
l’epoca di Carlo V, accentuò la politica nepotistica come fattore di stabilità
circondandosi di consanguinei, reclutando persone facili a delinquere ed
eccedendo, secondo il vicerè, il numero ordinario. L’estendersi del nepotismo,
peraltro imperante a tutti i livelli della burocrazia sia laica che ecclesiastica, era, a detta del vicerè,
uno dei difetti maggiori del santo tribunale. Il cumulo di competenze poi
contribuì non poco a fare dell’inquisizione un punto di contrapposizione di
potere e di interesse tra inquisizione e prelati.
Primo motore
dei dissapori che interessò un vasto settore della nobiltà cagliaritana –
capifila Aymerich e Zapata – fu l’insofferenza al rigore espresso dal vicerè
Cardona tramite il suo personale burocratico, che si identificava nell’avvocato
Giovanni Antonio Arquer, nell’inquisire sulle usurpazioni delle rendite regie
effettuate da Alfonso Carrillo, “ricevitore riservato”, al quale vengono
addebitate distrazioni di fondi per la bella cifra di 60.000 ducati. La fazione
anti-Cardona mise in moto una delicata e complessa manovra. Zapata scrivendo ad
Aymerich accennava alla possibilità che ove venisse accertato quanto si
sussurrava, le più alte personalità del regno sarebbero state compromesse, fra
esse la viceregina Maria Resquesens moglie del vicerè don Antonio Cardona.
All’inizio del 1540, mentre si imbastisce il processo nel
quale si cerca di invischiare l’Arquer e la viceregina, crescono le occasioni
di attrito dell’inquisizione con le insistenze più autorevoli del clero, della
dirigenza urbana e della burocrazia regia. Che l’inquisizione si facesse
strumento d’una così ardita operazione non può sorprendere se si pone mente al
suo organigramma. Per venire a capo di una situazione che rischiava
l’ingovernabilità il Cardona dovette chiedere alla Corona e alla Suprema la
nomina di un commissario straordinario. Furono così bloccate le manovre
dell’inquisizione e posto il veto a che si procedesse contro il vicerè e la
consorte e contro l’Arquer.
Il vescovo Pietro Vaguer designato quale commissario per il
Santo Ufficio percepisce che la matrice più profonda dello scandalo sta nelle
fazioni che dilaniano l’ambiente cagliaritano. Egli constatò che il maledetto
imbroglio di detto scandalo era fornito da “gente
vile e ubriacona” e da “testimoni
inattendibili”, tutte donne, che si erano prestate cooperando
nell’imbastire il fantasioso castello. Altre donne per non essersi prestate
alle pesanti restrizioni degli inquisitori furono fatte morire di fame in
carcere. Il Vaguer descrive l’affare della viceregina come la “maggiore cattiveria, falsità e tradimento
che si possa mai pensare ”: una quarantina di confessioni e testimonianze
messe insieme, un centinaio di persone denunciate a vario titolo. Fatti di tale
gravità erano stati possibili perché alla radice c’erano gravi responsabilità
dei funzionari del tribunale per i quali si ventilò l’opportunità che la
Suprema li ponesse agli arresti fuori dall’indiscreta portata dell’opinione
pubblica. Ma non fu così.
Pressato dal sovrano, il 7 dicembre 1545 il Vaguer concluse
ufficialmente l’affare della viceregina che si chiudeva con una pubblica
cerimonia in cui dal pulpito della cattedrale si rendeva esplicita la
motivazione politica del dispositivo finale. L’Arquer veniva scagionato dalla
Suprema che lo riconosceva vittima di false accuse. Vittime, con ostentata
teatralità, furono i popolani, quasi tutte donne, punite per essersi prestate
al gioco dell’inquisizione, mentre due uomini salirono sul rogo. Un anno dopo,
in sordina, si concludeva il processo ai suoi funzionari maggiori: i più
implicati tra i pubblici penitenti venivano trasferiti alla chetichella in
terraferma; i vertici del tribunale, l’inquisitore ed il suo assessore,
cautelativamente non sospesi ma congelati nell’incarico, se la cavarono con una
formale reprimenda della Suprema che invitava ad una maggiore cautela, e in
forza di essa nel 1547 lo riassumevano in pieno.
L’inquisizione sarda uscì dalla torbida vicenda per nulla
scalfita nell’autonomo senso delle sue prerogative. Nell’ottobre del 1546 si
presentava sulla scena Luis de Cotes il quale nell’informare la Suprema
dell’incarico conferitogli, tracciava un quadro fosco dello stato religioso
dell’isola, tale che “con meno lavoro si
educavano quelli delle Indie ”, dato che “difficile è disimparare
quanto insegnare ”.
Di quella realtà responsabili prime erano a suo dire le
stesse istituzioni poiché vescovi e inquisitore trascuravano di visitare il
proprio gregge, e commissari del Santo Ufficio erano semmai essi ad avere
bisogno di “rinnovarsi migliorando ”
e i sacerdoti, analfabeti, vivevano accasati. Non lo meravigliava quindi quanto
pochi fossero i fedeli che usavano del precetto pasquale e che sapevano il
credo e le orazioni. Tantomeno lo meravigliava la diffusa disposizione a
giurare il falso e a seguire riti eterodossi. I suoi sacri ardori furono però
prontamente smorzati dal vescovo il quale si affrettò a inibirgli l’esercizio
della carica.
Per potenziare l’organizzazione militare alla quale era
affidata la difesa del regno, che aveva il suo nerbo nella cavalleria, nel
parlamento si suggerì di migliorare l’allevamento dei cavalli e di limitarne
l’esportazione. Nel successivo 1563 si diede corpo al problema istituendo una
tanca regia per l’allevamento di cavalli di razza spagnola.
Il pericolo
di invasione, col trascorrere del secolo si presentava, pressochè intatto, sul
versante barbaresco, né gli affannosi spostamenti della flotta regia erano
sufficienti a determinare una soglia di sicurezza. Come sottolineato da Cardona
nei primi del 1540 occorrevano nuovi, moderni e fidati sistemi di difesa,
soldati e denaro. Il passaggio di campo dei genovesi non servì in effetti a far
compiere il salto di qualità sperato al problema del controllo del
mediterraneo. Lo schieramento franco-turco faceva perno sulla strategia
barbaresca, connotata da una grande abilità nel passare dalla guerriglia
corsara alle grosse concentrazioni di mezzi. Non c’era d’altro canto alcuna
possibilità di contrastare tale fenomeno con altrettanta efficace guerriglia
corsara, nonostante le facilitazioni e l’invito del principe Filippo, che nel
1552 offriva ai sudditi sardi il libero possesso delle prede.
Dopo estenuanti e continue guerre, stanco e deluso di non
avere potuto realizzare un impero universale, Carlo V, alla fine del 1556
abdica a favore del figlio Filippo II e del fratello Ferdinando I. Al figlio
lascia la Spagna, i domini italiani e tutte le colonie, mentre al fratello
lascia i domini ereditari degli Asburgo e la successione imperiale.
Carlo V morì nel 1558 presso il Monastero di S. Yuste
nell’Estremadura.
FILIPPO II D’ASBURGO (1527-1598)
II
RE DI SPAGNA – RE DI SICILIA – RE DI NAPOLI
11°
RE DI SARDEGNA DAL 1556 AL 1598
 Filippo II successe al padre Carlo V
imperatore e fu il capostipite del ramo della famiglia degli Asburgo di Spagna.
Quando suo padre abdicò, nel 1556, a Filippo andarono la Spagna, la Borgogna, i
paesi mediterranei e quelli americani.
Filippo II successe al padre Carlo V
imperatore e fu il capostipite del ramo della famiglia degli Asburgo di Spagna.
Quando suo padre abdicò, nel 1556, a Filippo andarono la Spagna, la Borgogna, i
paesi mediterranei e quelli americani.
Filippo II, a differenza di suo padre, visse quasi sempre in
Spagna e fu il più spagnolo degli Asburgo. Animato da una fede profonda, era
assolutamente incapace di comprendere i non credenti per cui diveniva spesso
fanatico e vendicativo. Si impegnò in primo luogo nella difesa della fede
cattolica con ogni mezzo a disposizione. Gran parte dei suoi sforzi furono
rivolti a impedire che il protestantesimo si diffondesse in Spagna, fu quindi
fedele esecutore dei dettami del Concilio di Trento e, servendosi
dell’inquisizione, cercò di controllare e di scoraggiare ogni manifestazione
che non fosse conforme.
Si adoperò in uno sforzo gigantesco per omologare e
organizzare la burocrazia e gli strumenti del proprio potere assoluto. Nel 1560
egli stabilì definitivamente la capitale a Madrid dove, nel 1563, iniziò la
costruzione dell'Escorial, pensato
come residenza e insieme centro burocratico amministrativo della sua monarchia
assoluta, isolando i suoi domini dalle più vivaci correnti della cultura del
tempo. Ancora oggi una visita all’Escorial,
dà la sensazione di come egli concepisse lo stato e consente di capire i limiti
dai quali fu determinato il suo fallimento.
La sua politica estera fu caratterizzata dalla ripresa dei
sogni asburgici di egemonia. Anche sul piano internazionale fece della difesa
del cattolicesimo il motivo dominante della sua politica a livello mondiale,
così si imbarcò in una serie di guerre impegnando una forte organizzazione
militare, che lo costrinse a sottoporre il paese a spese enormi,
compromettendone l’economia che era già stata duramente provata durante il
regno di suo padre.
Quando assunse il potere egli si trovò impegnato nella guerra
contro la Francia, iniziata nel 1542, e nella guerra contro i turchi i quali
avevano completato la conquista del nord Africa, nel 1556.
Era appena salito sul trono quando il re di Francia Enrico
II, alleatosi con il papa Paolo IV, tentò di riprendere Napoli. Le truppe
francesi invasero l’Italia, ma gli spagnoli attaccarono direttamente il
territorio francese. Forti di una superiore organizzazione militare, al comando
del duca d’Alba, sconfissero i francesi i quali furono costretti a firmare,
nell’aprile del 1559, il trattato di pace che sanzionava il definitivo
riconoscimento dell’egemonia spagnola in Italia. A rafforzare la pace Filippo
II, vedovo, nello stesso 1559 sposò in seconde nozze Elisabetta di Valois,
figlia di Enrico II re di Francia.
Nell’autunno del 1562 prese a circolare la voce della
cessione della Sardegna al pretendente al trono di Navarra. Per quanto paresse
incredibile, i negoziati ci furono. La cosa si riseppe e la Corona ebbe il suo
da fare per rassicurare i rappresentanti dell’isola.
Nel 1567 iniziò la lunga e sanguinosa guerra con i Paesi
Bassi, costituiti da diciassette province borgognone staccate dal Sacro Romano
Impero, e formate da un complesso di popolazioni di cultura e tradizioni
diverse, che godevano da tempo di importanti privilegi. Nelle province
settentrionali inoltre si era diffuso il calvinismo, mentre quelle del sud
erano rimaste cattoliche; tale divisione rendeva ancora più complesso
l’equilibrio in questi territori. Va aggiunto che gli interessi economici delle
potenti organizzazioni mercantili di queste province erano potenzialmente in
conflitto con quelli della Spagna. Questa situazione era sgradita a Filippo II
che instaurò nei Paesi Bassi una politica dura, mirata a soffocare le libertà
religiose e ad esercitare sul paese una indebita pressione politica e militare.
La reazione fu immediata, la situazione precipitò, le classi popolari in Olanda
e nelle altre province insorsero e il re fu costretto a inviare il duca d’Alba,
con un esercito di 20.000 uomini. Iniziò così una lunga guerra di logoramento
che, con fasi alterne, continuò per quasi un secolo inghiottendo immense
risorse umane e materiali, per concludersi solo nel 1648.
Anche nel Mediterraneo la guerra contro i turchi continuava:
nel 1566 era morto Solimano il Magnifico al quale era succeduto Selim II
l’Ubriacone. In un clima da crociata, con l’aiuto di altri principi italiani,
l’alleanza con Venezia, e dopo che il 20 maggio 1571 il papa Pio V aveva
organizzato una lega santa, il re
Filippo II radunò a Messina una flotta comandata da suo fratello Giovanni
d’Austria. Dopo ulteriori preparativi la grande flotta si mosse, ed entrata in
Adriatico sconfisse i turchi nella battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571): fu
una vittoria senza grandi conseguenze. Negli anni successivi Tunisi fu
riconquistata dagli alleati mentre subito dopo i veneziani uscirono
dall’alleanza abbandonando Cipro. La Spagna fu lasciata sola, Tunisi fu
riconquistata dai turchi nel 1574 e la flotta turca riprese a minacciare
l’Europa dall’Adriatico. Finchè, nel 1581, fu stipulata la pace che sancì lo statu quo nel Mediterraneo.
L’esistenza
tormentata di Filippo II fu segnata, nel 1568, dalla misteriosa morte del
figlio Don Carlos. Questo figlio di primo letto avuto da Maria di Portogallo,
fu strano di mente, smodato nei costumi fino ad odiare suo padre che era un
tenace intransigente tutore dell’ordine. Dopo vari eccessi alla corte e al consiglio reale tramò una fuga in
Italia (1564). Il padre, allora, nel 1568, lo fece rinchiudere in una torre ove
nel luglio dello stesso anno, all’età di ventitrè anni, morì. Intorno a questa
morte sorsero sospetti e nacquero leggende che fecero di questo principe
pazzoide una vittima, e del padre un crudele tiranno. Tali avvenimenti, ancora
oggi avvolti in un denso mistero, hanno fornito spunti e ispirato poeti (fra i
quali F. Schiller e V. Alfieri) per opere in molte lingue.
Nel 1569, a causa della durezza del suo governo nei confronti
dei moriscos (musulmani convertiti
che vivevano soprattutto nel sud della Spagna) sospettati di praticare
clandestinamente l’antica fede questi si ribellarono. Si aprì così un nuovo
focolaio che costrinse il re a intervenire con grande severità riuscendo ad
averne ragione due anni dopo. La convivenza con questa importante comunità fu
però definitivamente turbata e molti moriscos
abbandonarono la Spagna. Fu questo il momento in cui la politica di Filippo II
sembrò dominata soprattutto da preoccupazioni di ordine religioso. Infatti in
Spagna oltre ai moriscos furono
perseguitati anche i marranos, cioè i
discendenti degli ebrei convertiti, e fu favorita la ripresa dell’inquisizione.
Nel frattempo Filippo II si era cacciato in un altro
pericoloso pasticcio, lasciandosi invischiare nelle guerre religiose che da
anni insanguinavano la Francia. Così, nel 1576 si alleò ai cattolici francesi
contro gli ugonotti. Mentre Filippo apriva questo nuovo fronte, nel 1577
Elisabetta d’Inghilterra si alleò con i ribelli olandesi sostenendoli
apertamente. Il sovrano, allora, inviò il duca di Parma il quale, con abile
politica, riuscì a sottomettere le province meridionali staccandole
definitivamente dai Paesi Bassi settentrionali che, nel 1579, proclamarono
l’unione di Utrecht e continuarono la guerra contro la Spagna.
Come se tutto ciò non bastasse il re si trovò impegnato
ancora una volta su un fronte diverso. Poiché il re Sebastiano I del Portogallo
era morto tragicamente nel 1578 in Marocco, senza eredi diretti, si aprì in
questo regno una crisi dinastica che coinvolse Filippo II che aveva, per via di
sua madre, la possibilità di avanzare pretese sul trono del Portogallo, in questo
sostenuto dal clero e da una parte della nobiltà. L’esercito spagnolo invase il
regno e, sconfitti gli avversari pretendenti, nel 1580 consentì a Filippo di
proclamarsi re del Portogallo. Fu questo un evento di non poco conto, in quanto
la possibilità di fusione dell’impero coloniale portoghese a quello spagnolo
creò una situazione difficile sul piano internazionale. La Spagna infatti non
solo dominava così l’intero continente americano, ma anche tutte le rotte verso
l’oriente attraverso l’Africa.
L’Olanda, i cui interessi mercantili cominciavano a
svilupparsi nonostante la guerra difensiva in corso, e l’Inghilterra,
interessata ai commerci internazionali, furono i nuovi avversari di Filippo II
in uno scenario mutato. L’offensiva inglese nei mari sembrava incontenibile: in
America il corsaro sir Francis Drake assalì e saccheggiò San Domingo e
Cartagena e gli spagnoli furono cacciati dalla Virginia nel 1586, mentre gli
olandesi assalivano il Brasile.
La guerra era ormai tra Inghilterra e Spagna. Filippo II
pensò di costruire una grande flotta – la
invincibile armada – capace di
trasportare un corpo di spedizione in Inghilterra, ma anche la regina
Elisabetta fece altrettanto affidando la sua flotta al comando di Drake che,
nel 1588, sconfisse nella Manica l’armada, i cui resti furono poi dispersi
da una tempesta. Questi eventi segnarono la fine del predominio spagnolo sui
mari e l’inizio delle conquiste coloniali inglesi e olandesi ai danni della
Spagna.
Durante il regno di Filippo II la Sardegna visse in un clima
di pace, ma anche di relativo isolamento, acquistando definitivamente i
caratteri di un piccolo regno periferico e decadente. La difesa del
Mediterraneo era considerata da Filippo II una priorità, pagata cara sul piano
finanziario e militare. La Sardegna godette di qualche riguardo nel quadro di
questa priorità per la sua posizione strategica che ne faceva una base di
appoggio molto importante. Per la sicurezza del regno occorreva tuttavia una
più forte iniziativa localizzata. Lasciato in sospeso il problema della difesa
mobile, la Corona preferì orientarsi verso il potenziamento del sistema statico
confermando il pur faticosamente avviato riattamento delle fortificazioni
urbane con una rete di torri litoranee che avrebbe avvolto l’intera isola. In
base alle ispezioni effettuate le torri avrebbero dovuto essere 132 ma nel 1594
di torri risultava essersene costituite 66, la esatta metà. Gli intoppi
finanziari rendevano infatti contraddittori gli sforzi volti a migliorare le
difese e l’armamento.
Nel 1564 si cercavano a Genova i proiettili per le bombarde
di Castellaragonese e di Oristano, non per le più importanti piazze di Cagliari
e Alghero dove le bombarde difettavano. Per tamponare queste falle derivanti
dalla scarsa professionalità delle truppe feudali, si fece largo ricorso al
macchinoso sistema di fare affluire nell’isola per periodi limitati alcune
compagnie di fanteria straniere. Il sistema aveva molti inconvenienti. Intanto
c’erano i danni che gli alloggiamenti procuravano alle popolazioni, tanto più
se combinati con concentrazioni di truppe locali. Negli anni ’70 la Sardegna
poteva mobilitare sui 10.000 fanti e 3.000 cavalieri, pari questi ultimi alla
consistenza della soldatesca straniera annualmente dislocata tra le piazze
marittime dell’isola.
C’erano poi problemi finanziari e d’ordine pubblico. Un tale
sforzo pecuniario va poi commisurato ai crescenti effettivi delle compagnie
impiegate. Tra il 1565 e il 1574 fu inviata a Cagliari la fanteria di
Sigismondo Gonzaga, che dal numero iniziale di 1.300 passò nel 1570 a 1.500
unità, per toccare le 2.000 unità nel 1574. I problemi dell’ordine pubblico non
si fermavano qui. Il Santo Ufficio ebbe molto a ridire di una così forte
presenza, per quanto temporanea, di contingenti italiani in quanto provenienti da terre libere dove non
sapevano cosa era l’inquisizione, pullulante di luterani, di eretici in genere
e blasfemi, di individui che esercitavano il nefando peccato della sodomia.
Ma quando nel 1574 si provò a sostituire la fanteria italiana con quella
spagnola, nel porto di Cagliari nacque una colossale rissa. L’anno dopo la
stessa inquisizione, nel sottolineare l’importanza strategica dell’isola,
aggiustava la sua valutazione della situazione interna a seconda che fosse
necessario decantare la propria funzione o limitarsi a preservare la propria
autonomia.
Il valore dei sardi era conosciuto, la loro fedeltà alla
Corona non era più messa in discussione, e infatti con carta reale del 1560
Filippo II ordinava che nelle armate spagnole i sardi fossero considerati come
spagnoli. Egli, pertanto, quando, nel 1575, il suo sforzo militare era giunto
al massimo, decise di utilizzare anche le risorse umane della Sardegna. Egli
decise di inviare tre capitani che, affiancati da un certo numero di istruttori
provvedessero ad addestrare le milizie nazionali sarde che avrebbero affiancato
le truppe spagnole nella difesa dell’isola. Data la situazione generale il
sovrano credeva imminente un assalto turco alla Sardegna, quindi furono fatte
distribuire armi e archibugi anche ai civili e tutti i ceti dell’isola
concorsero ad apprestare le difese. Ad Iglesias una prima distribuzione di 200
archibugi venne fatta nel 1576. Altre distribuzioni in archibugi e lance si
ebbero nel 1580, ogni cinque anni circa. Fu in questa occasione che l’uso delle
armi da fuoco si diffuse tra i sardi e la tradizionale balestra fu
definitivamente abbandonata.
Queste truppe nazionali sarde furono poste direttamente alle
dipendenze del vicerè ed erano comandate da ufficiali locali; esse si
segnalarono soprattutto nella difesa delle coste dai corsari in più di una
occasione. Di particolare rilievo furono la difesa delle marine di Alghero e
lungo le coste meridionali. In queste azioni molti valorosi persero la vita,
sostenuti più che con un armamento adeguato, con grande animo e ottime virtù
militari.
Ma in Sardegna furono arruolati anche fanti regolari
inquadrati nei tercios che presero
parte alle guerre europee. Di questa partecipazione, sentita e condivisa dagli
isolani, è rimasta una tradizione ricordata da molti dei maggiori storici sardi
e lungamente manifestata nella fede popolare anche se non sostenuta da
documenti d’archivio. Secondo questa tradizione i quattrocento archibugieri che
presero parte alla battaglia di Lepanto nelle galere di don Giovanni d’Austria
– comandante della flotta – sarebbero stati sardi; il principe, dopo la
vittoria, avrebbe dato loro lo stendardo della nave che essi, una volta tornati
in patria, donarono alla chiesa di San Domenico. Secondo la tradizione la
bandiera veniva portata in processione, a ottobre, tutti gli anni. Anche se
questa tradizione appare storicamente improbabile, è certo che essa rappresenta
la sintesi dello spirito con il quale i sardi si sentirono coinvolti nella
situazione militare del tempo. Ciò fu, in ogni caso, motivo d’orgoglio per gli
isolani e perfino Gabriele D’Annunzio li ricordò nella Canzone dei Trofei“:
“O Cagliari
i quattrocento archibugieri sardi
che don Giovanni d’Austria alla battaglia
sotto il vessillo della sua Reale
s’ebbe per incrollabile muraglia
“
Lo stendardo – a strisce rosse e gialle – restaurato, si
trova attualmente nella cripta della chiesa di San Domenico a Cagliari.
Le lotte di potere in seno alla società sarda riguardavano
interessi particolari e clientelari e il confronto tra la nobiltà feudale e la
burocrazia aveva avuto anche momenti di drammatica tensione.
Qui si inseriscono le disavventure di Sigismondo Arquer,
avvocato e teologo, figlio di quel Giovanni Antonio Arquer che durante il regno
di Carlo V fu vittima anch’esso, con la viceregina, di una complessa e falsa
manovra accusatoria imbastita dagli Aymerich.
Cagliari, a metà del XVI secolo, dopo l’arresto di Salvatore
Aymerich accusato quale mandante di un atroce delitto perpetrato dentro il
convento dei domenicani della città, era caduta in balia degli Aymerich e della
loro feroce cavalleria, “principales” e pastori delle Barbagie e di Gallura, colà normalmente adibiti a
tamponare le scorrerie barbaresche. Nel 1554 fu nominato un nuovo avvocato
fiscale, il giovane e battagliero Sigismondo Arquer, invano ricusato dal
partito feudale, il quale confermò l’arresto del vecchio Aymerich e i suoi
collegati ribattendo punto per punto le manovre dei loro legali, dei canonici
della cattedrale e dell’inquisitore.
Il fiscale però dovette fare i conti con le estese capacità
manovriere degli Aymerich, che imbastita un’accusa di subornazione di testimoni
(1556) ottennero di mandare in carcere l’Arquer e sostituirlo con un
addomesticato altro avvocato fiscale. Giovanni Antonio Arquer riusciva a far
convocare il figlio a corte, dove venne discolpato, riabilitato e reintegrato
nel suo incarico di magistrato.
Ebbe allora inizio l’ennesima trama foriera di tragici
sviluppi ordita dal clan degli Aymerich, che fece circolare negli ambienti
oligarchici di Cagliari, Sassari e Alghero uno scritto giovanile di Sigismondo
Arquer, il “Sardiniae brevis historia et descriptio” per muoverli ad accusarlo
di eresia. Si trattava di un libro pubblicato a Basilea nel 1550, durante il
suo soggiorno in Svizzera prima di approdare a Bruxelles alla corte imperiale.
Il libro era un primo tentativo di riflessione sulla Sardegna e sul suo passato
che matura nell’ambiente della cultura sardo-spagnola e traccia una
testimonianza non positiva della società del suo tempo. Tale opera, avendo
circolato anche in ambienti protestanti, poteva apparire eterodossa, da qui
l’accusa e il primo processo per eresia contro Sigismondo Arquer. L’inquisitore
arcivescovo Castillejo nell’ottobre del 1560 affermò in un primo momento che le
accuse erano un velenoso parto dei suoi nemici. Pochi mesi dopo, nel luglio
1561, il suo atteggiamento risultò radicalmente mutato, tanto da suggerire alla
Suprema un supplemento di indagine. Cosa che avvenne nel novembre 1562, ma la
posizione dell’Arquer venne aggravata dal fatto che egli ai primi del 1564 era
riuscito a fuggire ma venne ripreso. A niente servì l’intervento di suo padre
quando nel settembre 1565 presentò un memoriale alla Suprema rilevando che il
figlio era già stato scagionato dal tribunale sardo.
Occorre tenere presente la particolare congiuntura emotiva
del tempo, sfociata in una ondata di isterismo religioso a corroborare la quale
si aggiunse un passo compiuto dal languente imperatore Carlo V dal ritiro di
Yuste, che nel 1558 invitava con tutta l'insistenza e la veemenza possibili a
che si ponesse “grandissima cura perché
gli eretici fossero oppressi e castigati con tutta la dimostrazione e il
rigore, senza eccezione di persona alcuna ”. Seguì un’altra ondata di
persecuzioni contro i protestanti di ascendenza erasmiana, colpevoli di avere
avuto contatti con ambienti qualificati come luterani. Tra essi c’era appunto
l’Arquer. Nove anni durò la detenzione di Sigismondo Arquer durante i quali non
solo riconosceva per proprie le proposizioni da lui espresse in alcuni suoi
scritti, ma ne respingeva insistentemente il carattere eterodosso. Gli
inquisitori decisero di sottoporlo a tortura al fine di strappargli la “verità”
quindi, nel giugno del 1571, fu fatto ardere in pubblico, a Toledo. Prima che
prendesse fuoco la pira, involontario perfezionamento del martirio, venne
trafitto con una lancia.
Nel 1571 la Sardegna usciva da due annate di cattivi raccolti
e una decimazione degli armenti, provocata quest’ultima da un inverno di grandi
tempeste di acqua e di neve. Tuttavia l’isola poteva contare su un patrimonio
di bestiame di 1.100.000 capi circa. Le limitazioni imposte ai funzionari non
essendo di per se sufficienti a sbiadire la fama di “grandi ladroni” che
contraddistingueva le zone a prevalente economia armentizia, si impose per la
riorganizzazione e il rilancio del settore, il ricorso ad una serie di nuove
leggi che prevedessero più rigorose disposizioni in materia di furti di
bestiame, molto caldeggiate dalle città mercantili. Già con la prammatica
Madrigal del 1561 i funzionari sia regi che baronali furono vincolati alla
consegna immediata dell’indiziato di furto. Ma poiché col denaro si poteva
tacitare la giustizia, per questo genere di reato venne sospesa la pratica
della composizione amministrativa calcando ulteriormente la mano sulle pene corporali, che
comportavano l’impiccagione per i recidivi e per i furti superiori ad un certo
numero di capi. Più tardi, nel 1591, venne anche imposto alle autorità locali
di trasmettere al centro i nominativi dei contumaci, per bandirli da tutto il
regno. Banditismo dunque “figlio di miseria e di sovrappopolamento” ma anche
polarizzato laddove le condizioni ambientali (geografiche e di mobilità), le
relazioni personali, la maggiore concentrazione e circolazione sul posto di
ricchezza, materialmente evidente, combinano un più forte aggregato di
occasioni. Tutto ciò a conferma e conseguenza di una ripresa della capacità
attrattiva delle campagne, di quelle a forte caratterizzazione armentizia in
specie.
La replica ispanica alla pressione calvinista e islamica
condizionò la svolta di Filippo II nel modellare la costituzione spagnola,
specialmente per la Castiglia, e lo indusse alla impermeabilizzazione
ideologica del paese delineata sin dai primi passi del suo regno con la
velleitaria prammatica del 1559 che vietava ai suoi sudditi di frequentare
università straniere, con ben circoscritte eccezioni.
Da quando ebbe inizio la penetrazione politica catalana fino
all’inizio del XVI secolo non fu introdotto in Sardegna l’insegnamento
pubblico. Si ricordi che fino al 1478 l’isola non può considerarsi
definitivamente sottomessa, ciò che può spiegare l’indubitabile ritardo. Nella
seconda metà del secolo XVI l’ambiente culturale sardo inizia a smuoversi e a
dare i primi segni di vita. E’ giusto riconoscere l’ignoranza che fino ad
allora regnava in tutti i settori della vita sociale sarda, senza escludere lo
stesso clero. A confronto vedasi quanto scrisse Sigismondo Arquer. L’arcivescovo
di Cagliari, Parragues de Castillejo, scrive nel 1560: “l’ignoranza in generale è tanto grande che non vi è chierico in questa
diocesi che capisca niente di quello che legge, né sappia che cosa è essere
chierico ”.
Dalla metà del secolo XVI e la coincidenza del risveglio
della cultura in Sardegna, si sente la necessità della creazione di università
nell’isola. Già nel 1545 gli stamenti avevano fatto una petizione con questo
oggetto che restò senza effetto. Ma il seme, il primo passo efficace, lo si
deve a un sassarese, segretario di Carlo V e di Filippo II, Alessandro Fontana
che, nel suo testamento, lasciò i suoi beni ai gesuiti, con l’obbligo di
fondare un collegio. Questo accadde nel 1558.
Nel 1559 arrivarono in Sardegna i primi gesuiti. Fu il P.
Lainez, successore di S. Ignazio di Loyola, fondatore e Generale dell’Ordine,
ad inviare in Sardegna quale primo rappresentante della Compagnia, San
Francesco de Borja che, come persona di fiducia di Carlo V, era già stato a
Cagliari nel 1535 al seguito dell’imperatore. Il primo collegio fu aperto a
Sassari e nel 1562 iniziarono le lezioni. Due anni dopo, nel collegio di S.
Croce a Cagliari, i gesuiti iniziarono le lezioni di grammatica, di teologia,
di filosofia e di lettere umane.
Altro ordine dello spagnolo G. Calasanzio, quello delle
Scuole Pie – gli Scolopi – che istituirono a Roma la prima scuola popolare
gratuita d’Europa, nel 1597, dedicata alla formazione dei giovani, ebbe delle
sedi in Sardegna prima che nella Spagna.
I gesuiti si erano orientati a specializzarsi nelle attività
pedagogiche e nel breve periodo di un trentennio impiantarono collegi nelle
principali città sarde. Essi attirarono un non indifferente stuolo di studenti,
tali che tra fine cinquecento e inizi del seicento giunse a toccare
complessivamente le 1.500 unità (500 studenti nel 1597 a Sassari, 800 studenti
nel 1600 a Cagliari).
Con l’assumere energicamente nelle proprie mani lo strumento
pedagogico i gesuiti affrontarono in via pratica quello della lingua da usare.
Per i villaggi si ricorse al sardo senza tentennamenti. Più controverso si
presentava il problema in ambito urbano. La parlata ordinaria dell’isola era
quella sarda. A Cagliari e Alghero si usava correntemente il catalano, con
infiltrazioni del sardo. Sassari era una sorta di torre di babele dove si
parlava chi il catalano, chi il castigliano, chi l’italiano, chi il corso e
qualche volta il sardo. La classe dirigente si sforzava, con risultati
mediocri, di familiarizzare col castigliano, la maggioranza ricorreva al sardo
o al corso.
Più drastico fu il taglio del nodo linguistico con la
decisione nel 1567 del Generale della Compagnia di adottare il castigliano
nelle città sia per l’insegnamento che per la predicazione, in netto anticipo
persino rispetto ai tempi della burocrazia. Mentre per l’interno si uniformava
l’adeguamento alla “Carta de Logu” (in sardo), nel parlamento la traduzione
avveniva in catalano. Quella del castigliano fu una scelta imposta dalla locale
classe dirigente che si collocava nel quadro della politica di chiusura delle
frontiere culturali avviata dalla prammatica del 1559. Essa era di difficile
applicazione per la Sardegna. Fattesi le ossa presso i collegi gesuiti, quei
pochi che ne avevano la possibilità finanziaria si riversavano di preferenza
verso le sedi universitarie dell’Italia tirrenica più a portata di mano.
Filippo II, chiamato anche “Re Prudente”, contrariamente a
quanto espresso negativamente da alcuni storici, facilitò lo scambio culturale
italo-sardo, ne è prova la pubblicazione, nel 1596, delle “Rime diverse” di
Pietro Delitala, il primo libro stampato in Sardegna in italiano. La prammatica
del 1559, seguita dall’editto del vicerè del 1572, che proibiva ai sardi di
andare a studiare in Italia non pare abbia avuto grande effetto giacchè si ha
notizia, dopo questa data, di studenti sardi a Pisa, Bologna, Roma e Napoli. A
Pisa negli anni 1560-65 si addottorarono una quindicina di sardi, di Cagliari
la maggior parte. Si aggiunga che il divieto aveva interessato, già dal 1559, anche
i nativi della Spagna vietando loro di studiare o insegnare nelle università
straniere, eccettuato il collegio spagnolo di Bologna e le università di Roma,
Napoli e Coimbra. Non si trattava di un atto di antitalianità nel timore che
l’isola si allontanasse dalla Spagna. Era un mezzo con fini protezionistici
come conseguenza della politica di Filippo II, tendente a salvaguardare nei
suoi regni l’unità della fede cattolica, giacchè in quel tempo le università
inglesi, tedesche, francesi ed anche alcune italiane erano contaminate dal
protestantesimo. E non si dimentichi che le università spagnole erano, allora,
salvo rare eccezioni, come Parigi o Bologna, superiori alle restanti d’Europa.
In Sardegna esistevano tipografi dalla fine del secolo XV,
cioè nello stesso secolo dell’invenzione della stampa, ma solo nel 1566, e
grazie a Nicolò Canelles, l’isola dispose di una tipografia stabile. Nicolò
Canelles fu il primo editore sardo ed è suo il famoso Catechismo di E. Anger, stampato a Cagliari nel 1566. Risale a quel
tempo anche il libro più antico posseduto dall’Università di Cagliari, la Carta de Logu.
Con la fine del regno di Filippo II iniziava la decadenza
della potenza spagnola che il sovrano aveva ereditato, ma che non aveva saputo
governare con l’abilità politica del nonno Ferdinando il Cattolico, e del padre
Carlo V. Egli morì all’Escorial nel 1598
lasciando il regno al figlio Filippo III.
FILIPPO
III D’ASBURGO (1578-1621)
III
RE DI SPAGNA – RE DI SICILIA – RE DI NAPOLI
12°
RE DI SARDEGNA DAL 1598 AL 1621
 Filippo III successe, nel 1598, al padre
Filippo II mentre il paese era in guerra con l’Inghilterra e i Paesi Bassi.
Affidando ad altri le redini del governo il suo regno segna l’inizio dell’epoca
dei “favoriti” e della decadenza della Spagna.
Filippo III successe, nel 1598, al padre
Filippo II mentre il paese era in guerra con l’Inghilterra e i Paesi Bassi.
Affidando ad altri le redini del governo il suo regno segna l’inizio dell’epoca
dei “favoriti” e della decadenza della Spagna.
Filippo III ereditava una situazione finanziaria disastrosa a
causa dei debiti nei confronti dei banchieri che avevano anticipato i mezzi
necessari a sostenere la politica militare di suo padre Filippo II. Il nuovo
sovrano avviò una politica di disimpegno militare su tutto lo scacchiere
europeo e così, nel 1604, venne fatta la pace con l’Inghilterra dove alla
implacabile Elisabetta era succeduto Giacomo I Stuart e, nel 1609, fu stipulata
una tregua di dodici anni con l’Olanda che sanciva la definitiva perdita delle
province settentrionali.
Nel 1618, con l’inizio della guerra dei trent’anni si avviò
il disastroso confronto della Spagna con i protestanti. Intanto
l’amministrazione dello stato fu afflitta dagli scandali e dalla corruzione in
un ambiente in cui la nobiltà cortigiana diventò arbitra delle sorti del
decadente paese.
Assai sanguinosa fu anche la guerra contro i mori che Filippo
III scacciò dalla Spagna attirandosi la riprovazione generale per il suo
fanatismo religioso e per la sua crudeltà. Tale espulsione fu anche causa di
grave danno all’economia nazionale.
Al tempo di Filippo III la Sardegna divenne ancor più
estranea e il suo isolamento dalle grandi questioni internazionali fu totale.
Paradossalmente, però, questo isolamento giovò al piccolo regno che conobbe un
breve periodo di pace e che portò ad un certo risveglio culturale stimolato
anche dal nuovo arcivescovo di Cagliari, Francesco d’Esquivel (1605) che si
impegnò per ottenere l’apertura dell’Università di Cagliari. In effetti l’Università
fu decretata dal Parlamento e autorizzata con bolla di papa Paolo V già nel
febbraio del 1606. Poi, con diploma regio del 9 febbraio 1617, fu
definitivamente avviata e istituita per prima a Cagliari, nel 1626, seguita,
otto anni dopo, da quella di Sassari. Comunque entrambe le istituzioni non
ebbero fortuna perché alla fine del secolo le cattedre erano già in gran parte
deserte o sospese.
La
congiuntura di inizio secolo si ripercosse favorevolmente su tutte le
principali risorse del regno e anche la Sardegna ne fu coinvolta. Tra il 1605 e
il 1606, ad esempio, il parlamento attuò una politica promozionale disponendo
che si mettessero a dimora 24 piante di gelso per ogni podere entro il termine
di tre anni, favorendo così l’allevamento del baco da seta e quindi la
creazione di fabbriche di tessuti. Fu anche introdotta la coltura della canna
da zucchero con ottime prospettive; il parlamento inoltre chiese di imporre ai
vassalli l’innesto di un certo numero di olivastri annui pro capite onde
sviluppare la coltura dell’olivo. Ma passarono vent’anni perché si procedesse
ad atti realistici come l’invio da Valenza e Maiorca di provetti innestatori e
curatori di bachi da seta. E poi c’era la non trascurabile inveterata abitudine
dei contadini i quali a loro volta erano condizionati dalla pressione signorile
e usuraia, nonché il nodo delle relazioni tra feudatari e vassalli
sull’imbrigliamento della produzione ai fini della commercializzazione.
Viceversa nella pesca del corallo e del tonno non c’erano
grovigli da districare e la politica promozionale procedeva con ben altra
speditezza. La pesca del corallo venne rilanciata all’inizio del secolo anche
con la costruzione delle torri litoranee di difesa, specie nella zona costiera
tra Bosa, Alghero e Castellaragonese, dove essa si praticava. A questa attività
erano dedicate, nei periodi migliori, circa trecento barche provenienti dalla
Liguria (e, al traino, da Marsiglia) e sempre meno dalla Catalogna. Mentre le
tonnare erano cinque in tutta l’isola.
Le fortificazioni di Cagliari e Alghero, chiavi di volta del
sistema difensivo sardo, erano state spogliate dell’artiglieria leggera per
guarnire le torri litoranee man mano che si costruivano. L’amministrazione ne
aveva in carico 19 tra il Logudoro e la Gallura e 24 nel capo di Cagliari. Il
castello di Cagliari è si fortificato e moderno ma le mura e il suo armamento
si vanno sgretolando e arrugginendo per
insufficiente manutenzione, malgrado le immense spese sin qui sostenute,
stimate a più di un milione. Ad aumentare il senso di insicurezza della città
si aggiunga la presenza massiccia di francesi quasi padroni del commercio entro
il porto, e una forte concentrazione, proprio dentro le mura del castello, di
schiavi mori i quali non solo sono in pari numero con i residenti, ma fruiscono
anche della massima libertà di movimento. Ad attizzare l’incubo del pericolo
francese si ricorda che nell’agosto del 1609 la flotta del duca di Guisa aveva
fatto scalo a Cagliari e costui era stato sentir dire che “entro l’anno i francesi avrebbero messo alla prova i cavalli e i
cavalieri sardi ”.
Nel 1605-06 con apprensione veniva denunciato che col
crescere del commercio e del benessere crescevano parimenti i delitti, né
bastava a reprimerli il ristretto personale della Reale Udienza. L’epicentro
del fenomeno si collocava in uno dei poli più cospicui dell’allevamento sardo,
il Monteacuto, sia perché il suo capoluogo, Ozieri, era dilaniato da feroci
pregiudizi di parte che avevano finito col travolgere il personale di giustizia
feudale e dove si faceva anche mercato della refurtiva incrociandosi con le
regioni confinanti, la Gallura su tutte, appartenenti a Signori diversi non
residenti.
Il Monteacuto col vicino Goceano restava un focolaio attivo
di fatti banditeschi. In quest’area, tra il 1610 e il 1612, operò una nutrita
banda di malfattori capeggiata da due elementi di Bono, Maurizio Flore e Andrea
Addis, che reclutando i suoi componenti tra i paesi limitrofi, soprattutto
Benetutti e Illorai, poteva mettere insieme fino a una ventina di uomini tutti
a cavallo e ben armati con archibugi e balestre. Poteva inoltre contare su una
diffusa rete di connivenze, non solo parentali, utili per le incombenze
logistiche. Essi istigavano la popolazione a evadere le tasse e si accanivano
contro i funzionari locali di nomina regia. E’ da credere che questa sorta di
furore iconoclasta fosse rivolta più che alle istituzioni agli individui che “entrano in carica poveri e ne escono ricchi
”. I delitti più ricorrenti erano i furti di bestiame, nei quali primeggiano i
cavalli, i saccheggi e gli smantellamenti di case, culminanti sovente in
assassinii e violenze sessuali. Epicentro rituale di queste azioni risiedeva
nel disonorare platealmente quelle famiglie, che per privati rancori o per
l’appartenenza all’autorità locale e ai ceti abbienti divenivano oggetto delle
loro scorrerie. Per reprimere un così ramificato episodio banditesco fu
necessario inviare, nel 1612, una compagnia militare da Cagliari.
La Sardegna a prevalente economia armentizia, per tutto il
seicento, doveva restare un’area a specifica vocazione banditesca. Nella
primavera del 1629 un giudice della Reale Udienza veniva dislocato nel capo di
sopra perché operasse contro i banditi e ladroni i quali prosperavano grazie
alla vasta libertà di cui godevano. Tra i fautori di questa libertà a
delinquere va annoverata un'istituzione ben infiltrata nel nord dell’isola:
l’inquisizione, che stendeva su parenti e familiari il manto dei suoi gelosi
privilegi immunitari. Tra il 1616 e il 1618 l’inquisizione fu al centro di un
pesante conflitto di competenza con l’amministrazione regia a causa di due
famosi banditi sottratti alla forza pubblica mentre venivano trasferiti dalle
carceri baronali di Tempio a quelle regie di Sassari. Nell’impresa e nei suoi strascichi
repressivi risultarono implicati alcuni familiari degli addetti al santo
tribunale. Pur collocandosi nello stesso periodo, fu tutt’altra cosa, non
foss’altro per l’ampiezza e incidenza in ambienti urbani la grande ondata di
banditismo che pose il principato di Catalogna sull’orlo della rovina.
I vent’anni di regno di Filippo III furono caratterizzati
dall’insorgere in Sardegna di una controversia tra l’arcivescovo di Cagliari e
quello di Sassari per il primato religioso. La polemica aveva profonde radici
storiche che risalivano al medioevo quando la Sardegna era divisa in giudicati
e il titolo di primate di Sardegna e Corsica era attribuito all’arcivescovo di
Pisa.
L’arcivescovo di Cagliari, tuttavia, perché la città era sede
del vicerè, di fatto veniva guardato come “primate” e così, nel corso del XVI
secolo, cominciò a intitolarsi “primate” con grande contrarietà
dell’arcivescovo di Sassari.
La disputa andò avanti per lungo tempo. La questione offrì
l’occasione alle due città di vivere una curiosa esperienza nella quale è
possibile individuare i contraddittori caratteri della cultura del tempo. A
Sassari e a Cagliari iniziò una frenetica attività di scavi archeologici per
rintracciare le reliquie dei santi martiri che comprovassero quale delle due
città avesse contribuito prima e maggiormente al radicamento del cristianesimo
in Sardegna.
Così, nel giugno del 1614, furono avviati scavi nella
basilica di Porto Torres alla ricerca dei corpi dei martiri turritani Gavino,
Proto e Gianuario. Contemporaneamente furono eseguiti scavi nella basilica di
San Saturnino a Cagliari mentre altri ne furono avviati alla ricerca dei corpi
dei santi martiri.
La disputa continuò negli anni successivi senza però sortire
alcun risultato. Il papa non prese alcuna decisione e così il titolo di primate
continuò ad essere portato dall’arcivescovo di Pisa il quale, nel frattempo,
intervenne nella disputa per difendere le sue prerogative.
Filippo III fu considerato re corrotto e crudele e accrebbe
con la sua incapacità al disfacimento del grande impero spagnolo. Egli morì nel
1621. Gli successe il figlio sedicenne Filippo IV d’Asburgo.
FILIPPO IV D’ASBURGO (1605-1665)
IV
RE DI SPAGNA – RE DI SICILIA – RE DI NAPOLI
13°
RE DI SARDEGNA DAL 1621 AL 1665
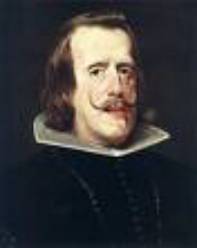 Figlio di Filippo III, salì al trono
sedicenne, sotto la tutela del conte duca di Olivares che per oltre vent’anni
continuò la tradizione dei “favoriti” onnipotenti dirigendo la politica
spagnola in mezzo a numerosi disastri.
Figlio di Filippo III, salì al trono
sedicenne, sotto la tutela del conte duca di Olivares che per oltre vent’anni
continuò la tradizione dei “favoriti” onnipotenti dirigendo la politica
spagnola in mezzo a numerosi disastri.
Con Filippo
IV, più intelligente e colto del padre ma a lui accomunato per mancanza di
carattere, si ufficializzava a tutti gli effetti l’abdicazione del potere regio
nelle mani di un “privato” consentendo il recupero di un ruolo preminente ai
vertici dello stato da parte dell’aristocrazia.
La politica dell’Olivares determinò il fallimento della
partecipazione spagnola alla guerra dei trent’anni, la definitiva perdita dei
Paesi Bassi, la riconquista della libertà da parte del Portogallo, nonché altre
crisi interne che portarono alla ribellione della Catalogna.
Filippo IV, pressato da crescenti necessità finanziarie, fu
portato ad aumentare specialmente nei confronti di quei regni il cui carico
fiscale era considerato modesto (la Catalogna, Valenza, l’Aragona e la
Sardegna), l’incremento del prelievo fiscale.
In Sardegna si manifestarono profondi conflitti fra i ceti,
l’economia decadde a causa di sfavorevoli congiunture e le principali attività
finirono nelle mani di speculatori (prevalentemente genovesi e napoletani), i
feudatari ripresero ad esercitare una opprimente pressione fiscale, le campagne
furono rese insicure da una crescente massa di sbandati che spesso costituivano
bande armate.
La politica del governo Olivares non tenne conto della
complessità della situazione sarda, le somme ricavate dai donativi furono
incamerate dal fisco centrale e utilizzate altrove, e ben poco fu investito per
migliorare le difese dell’isola, che rimasero fatiscenti. L’unico punto del
programma dell’Olivares che in Sardegna trovò attuazione fu quello relativo
agli obiettivi della politica militare del governo centrale. Così fu costituito
un “tercio” composto esclusivamente da soldati sardi, comandato da ufficiali
sardi, che fu inviato a combattere nei principali teatri della guerra dei
trent’anni. Questa esperienza segnò l’inizio di fortunate carriere per molti
degli ufficiali, generalmente cadetti delle grandi famiglie feudali, che
trovarono così una decorosa sistemazione economica e sociale. Per le classi
inferiori, che offrivano il grosso della truppa, l’esperienza fu invece
alquanto negativa.
L’isola, una
volta consolidato il dominio, non fu più un problema per la Spagna degli
Aragona e durante i secoli XVI e XVII la Sardegna è interamente pacificata. Non
è in questo tempo necessario neppure il mantenimento di un esercito regolare.
La nobiltà di allora era molto gelosa dei suoi privilegi e il male maggiore si
fondava nella mancanza di collaborazione e di armonia tra le casate più
rappresentative, con ripercussioni nella vita civile dell’epoca. Rivalità, pertanto,
e soprattutto tra famiglie nobili, tra nobili e clero, tra feudatari e ministri
del re. E sotto queste classi che occupano i punti vitali dell’organizzazione
isolana, e accanto a una classe borghese sempre più importante – commercianti,
letterati, avvocati, medici, ecc. – si estende la massa del popolo. Questo
popolo orgoglioso della propria terra si sente, forse passivamente, legato per
devozione e fedeltà al monarca.
La Sardegna al disopra delle rivalità di classe era un regno
tranquillo, fedele collaboratore nelle imprese dei re spagnoli. Dei sardi
intervennero nella conquista di Granada; dei sardi figurano nei reggimenti
delle Fiandre; dei sardi si trovano presenti a Lepanto; dei sardi passano in
Spagna a combattere le rivolte di Napoli e di Sicilia e frati sardi vengono
inviati in Palestina per la custodia dei Luoghi Santi e in America ad
evangelizzare gli indios. Quando sotto Filippo IV l’unità dei territori
ispanici sembrava sgretolarsi – sollevazione in Catalogna, separazione del
Portogallo, rivolta in Biscaglia e in Andalusia, sollevazione di Masaniello a
Napoli – in Sardegna non si verificano perturbamenti o disordini, già dalla
fine del secolo XV alla fine del XVII.
Il coinvolgimento nella unificazione delle forze armate
(union de las armas) comportò per il regno l’appesantimento delle sue
esposizioni finanziarie verso la Corona, solo parzialmente compensata da una
attenzione di ritorno nei confronti delle esigenze istituzionali dell’isola.
Quando nel parlamento sardo del 1621 venne sottoposto l’ordine sovrano di
munire le isole di Sant’Antioco e San Pietro di torri d’avvistamento e difesa,
lo stamento nobiliare sostenne essere più funzionale la flotta. Questo
orientamento conquistò ulteriore terreno nel parlamento del 1624 in considerazione
del fatto che la sua entrata in funzione avrebbe potuto riflettersi
sull’attuale sistema difensivo (castelli, torri, milizie di terra) in termini
di loro contenimento funzionale e di costi. In quel parlamento la linea che
puntava sul sistema difensivo mobile venne ribadita e precisata in un progetto
integrativo con cui il regno si obbligava a reperire nell’isola gran parte
della spesa necessaria per sei galere richieste a suo tempo ed ora ritenute
insufficienti a fronteggiare la flotta barbaresca. Tutto ciò purchè la Corona,
a sue spese, ne aggiungesse altre due, oltre a due galeoni armati per il
servizio invernale.
Lo stamento nel suo insieme si era espresso con la
schiacciante maggioranza del 78,5% a favore del progetto. Ma la difficoltà di
realizzazione del progetto dipendevano dalla sua pratica fattibilità e anche e
non poco dal quadro generale dell'armamento marittimo militare del mare
interno. La “flotta spagnola del Mediterraneo” non fu mai in grado di porre un
salutare freno alla pirateria, tanto più che la sua consistenza ed efficacia si
ridussero gradualmente nel corso dei seicento.
Sullo sfondo di questa poco incoraggiante realtà la Corona si
accinse con una certa tempestività, dal 1628 almeno, a saggiare la fattibilità
del progetto sardo col principe di Melfi, Giovanni Andrea Doria, puntando
sull’armamento in prima istanza di sei galere ipotizzando di far venire le
residue due dalla squadra genovese. Poiché potesse fungere da capitano generale
della istituenda flotta occorreva che il Doria fosse un “vassallo sardo”. Nella
trattativa si inserì la vendita di terre in proprietà libera, senza vincoli
feudali, della barbagia di Belvì ma l’ipotesi incontrò una immediata
opposizione forte del privilegio di inalienabilità di quelle terre stabilito da
Ferdinando il Cattolico (1479-1516).
L’attacco inglese a Cadige aveva nel frattempo accresciuto i
timori per la vulnerabilità delle coste sarde, mal garantite dalla milizia di
terra. Nella primavera del 1627 il vicerè visitò Sassari trovandola assolutamente
sguarnita e con le piazzeforti di Alghero e Castellaragonese in tali condizioni
che secondo il parere di ufficiali competenti sarebbero occorsi notevoli e
sostanziali interventi per riattarle. Ai successivi controlli del 1631 l’intera
milizia si presentava demotivata, con pochi ufficiali e anch’essi tanto
insoddisfatti da far pensare di costituire al suo interno dei nuclei di pronto
intervento con soldati abili e preparati alla bisogna.
Con tutti i suoi consueti difetti, in assenza di una flotta e
vista la sporadica presenza di truppe straniere mercenarie, la leva di terra
restava l’unica difesa del regno. I tentativi di migliorare i sistemi di
reclutamento imposero periodiche esercitazioni che dovettero servire a
qualcosa.
Nel 1637 si verificò uno sbarco francese a Oristano,
nell’ambito del duro conflitto che opponeva la Francia alla Spagna, già dal
1631. La flotta francese, forte di 45 vascelli, apparve al largo del Golfo di
Oristano nel febbraio del 1637; le difese dell’isola erano assolutamente inadeguate
e le truppe francesi, dopo un cannoneggiamento della Gran Torre, il 22 febbraio
sbarcarono, riuscendo a prendere Oristano, indifesa, e a saccheggiarla. La
riscossa fu organizzata dal governatore di Cagliari, Diego Aragal, che impegnò
i miliziani e le poche truppe a disposizione che arrivarono in soccorso da
diverse località dell’interno. Così i francesi furono sorpresi con il loro
bottino mentre tentavano di imbarcarsi e, duramente sconfitti dalla cavalleria
miliziana, furono costretti a lasciare sul campo alcune bandiere che ancora
oggi sono esposte nella cattedrale di Oristano. Secondo un contemporaneo
cronista dell’episodio, Canales de Vega, i sardi a cavallo erano 900 contro i
5.000 fanti bellicosi e indisciplinati. Si aggiunga purtroppo che entrando
nella città abbandonata dai francesi la milizia, con la sua endemica
indisciplina, esplose in un’orgia devastatrice di tale violenza da fare
esclamare allo storico Aleo che: “non
recarono si gran danno i francesi, quanto i medesimi sardi ”.
Tutto questo ebbe pesanti riflessi sull’economia regionale e
un seguito negativo per i contadini che non trovarono conveniente rinnovare i
contratti di locazione in terre che guardavano il mare, per l’insicurezza
indotta dall’invasione dei francesi che, per quanto breve, ebbe seri
contraccolpi sulla vita economica e sulle relazioni commerciali all’interno
dell’isola.
Forse per
diretto influsso dello sbarco francese e del lamentevole stato delle difese
costiere, nel 1638 si stringeva la trattativa col Doria, nominato vicerè del
regno, per giungere almeno al varo delle due galere pattuite. La costruzione e
l’armamento delle due galere si protrassero: per la “Capitana” tra ottobre 1638
e maggio 1639 e per la “Patrona” fino a novembre 1641. L’assenso da parte del parlamento
per l’entrata in funzione delle galere fu successivamente dato ad Andrea Doria
Landi, figlio ed erede del principe. A detta dei funzionari regi la gestione
delle due galere rese somme molto considerevoli al principe senza che questi si
curasse di rimpiazzare il personale e l’armamento mancanti e di procedere ai lavori di manutenzione. Sicchè nel 1648,
dopo avere usato le due galere al limite dell’usura, tra ufficiali, marinai,
timonieri e prodieri si era al di sotto del 17% della gente di mare occorrente,
non solo per l’inevitabile logoramento fisico ma anche perché l’insoddisfacente
trattamento aveva spinto diversi elementi a disertare in cerca di più remunerata occupazione. Un tantino
migliore era il livello, ma non lo stato, degli effettivi della ciurma: tra
forzati, buonavoga e schiavi si era al 4,5% al di sotto dell’organico, in
condizioni tuttavia di malnutrizione e sbrindellato equipaggiamento. Infatti
sul finire del 1651 una delle due galere, la “Patrona”, era dovuta restare
disarmata nel porto di Denia, in attesa di potere essere convogliata a Cagliari
per il riattamento. Parte del personale era andato a rafforzare la “Capitana”,
la quale, inviata a Genova per il carico di un “tercio” lombardo, vi giunse in
tali condizioni da far dubitare che potesse continuare a tenere il mare. Sul
finire degli anni 1650 si aveva la difficoltà a reperire i fondi necessari
perché “Capitana” e “Patrona” potessero continuare a navigare mentre navi
francesi intercettavano in uscita dal porto di Oristano le barche cariche di
grano. Tuttavia, di li a breve, si addivenne al varo di una nuova galera, la
“San Francesco”, e alla costruzione in Cagliari di un arsenale capace per
qualsivoglia squadra navale.
Nel frattempo, paventandosi una nuova invasione dell’isola, si
mobilitò la cavalleria feudale. Era anche un modo per distoglierla dalle faide
degli Alagon di Villasor e i Castelvì di Laconi che in quegli anni
insanguinavano con improvvise concentrazioni e scorrerie le campagne del
cagliaritano, turbando la vita della capitale. Tali episodi giunsero a
conoscenza di Filippo IV che scrisse al suo “visitatore” in Sardegna, don
Pietro Martinez Rubio, il 28 aprile 1652. Il 31 agosto il sovrano consigliò al
suo “visitatore”, qualora lo ritenga opportuno di inviare prigioniero (in
Spagna) il marchese di Villasor, che era scappato dalla Spagna senza permesso
ed era sbarcato a Pula. Il 9 ottobre esilia il poeta Giuseppe Delitala
Castelvì, per salvargli la vita, giacchè era sul punto di essere assassinato
dai signori di Villasor.
Già nel 1573 anche in Sardegna prese corpo la Reale Udienza
aggregando all’avvocato fiscale, che fino ad allora (alle dipendenze del
vicerè) fungeva da magistrato del re, altri tre magistrati; uno di questi ebbe
l’incarico, in qualità di giudice criminale, di istruire e relazionare le
cause. Nel 1606 il disbrigo della materia criminale fu snellito con la nomina
di un ulteriore giudice di corte. Successivamente, in seguito all’aumento della
criminalità e per porre fine alla invadenza dei tribunali signorili, nel
parlamento venne formulata la richiesta di aprire nella Reale Udienza una
“distinta” sala criminale che avrebbe dovuto costituirsi affiancando altri due
giudici a quello che già c’era nella Reale Udienza, immessovi nel 1606, col
compito di dedicarsi esclusivamente alla materia criminale. Nel commentare la
richiesta il giurista Dexart esclama: ”faxit
deus quod opus tam bonum quanto citius perficiatur ” (facesse Dio che il
lavoro si esegua tanto bene quanto presto). Ora se la sala tardò vent’anni ad essere
avviata non fu tanto a causa della copertura finanziaria bensì per l’ostilità
del baronaggio.
Dopo che il sovrano ebbe vincolato il salario dei futuri
addetti il vicerè, a metà degli anni quaranta, trattò con Cagliari e Sassari
l’accordo ma esso fu prontamente respinto da alcuni baroni non residenti, più
nel timore che si moderassero i loro profitti che per il bene della comunità.
Costoro fondarono la loro opposizione su due motivi: uno che essendo l’isola di
dimensioni ridotte e spopolata non era impellente dividere le cause civili da
quelle criminali; l’altro che pur essendo i salari alquanto contenuti essi
causavano comunque conseguenti spese per i vassalli. L’importanza della posta
in gioco risalta da un ampio argomentato “Discurso politico” redatto nel 1646
che fornisce una motivata risposta a un così robusto fronte di opposizione.
Esso si rifà alla particolarità costituzionale dei regni spagnoli contenuta
nella raccolta di leggi risalenti a Filippo II (1556-1598) nella quale
specificatamente si separa la materia civile da quella criminale. Il “Discurso”
rifacendosi alla richiesta parlamentare del 1630 ricordava che la crescita dei
traffici, dei delitti e della criminalità imponevano si evolvesse la forma di
governo. Né poteva addursi come ragione rilevante dell’opposizione l’essere
l’isola spopolata perché non poteva considerarsi tale con circa 400.000 anime
ripartite in 7 città e 370 paesi. Ma il punto era che l’incremento dei furti,
degli omicidi, della falsa testimonianza, dei falsari, era frutto non solo
della crescita dei traffici e della popolazione, bensì anche del modo in cui la
giustizia baronale (o tribunali signorili) trattava i crimini, forse per
cupidigia o per interesse o per rispetto specie nei feudi dei grandi baroni non
residenti, dove venivano dati in appalto tutti gli uffici giudiziari. Non era
un caso che bande di delinquenti imperversassero in Monteacuto, che l’attività
dei falsari prosperasse in Gallura arrivando a ridurre a mal partito l’erario
pubblico, che i furti di bestiame fossero più frequenti nelle barbagie di
Ollolai e di Seulo: tutti feudi di signori non residenti.
I “visitatori” dell’isola inviati dal sovrano o dalla Corona
descrivono l’eccessivo numero di reati dovuti ad un banditismo di insistenza e
di interessi pastorali le cui tecniche non avevano molto da invidiare a quello
barbaricino degli ultimi tempi; esso si esprimeva con una ferocia, una mobilità
e una capacità di aggregazione degne di nota. “I banditi scorrazzavano, depredavano e uccidevano non solo nei luoghi
deserti, ma ancora, raccolti in
bande, entravano nottetempo nei villaggi dove saccheggiavano le case dei più
benestanti ”.
Soprattutto a fine 1650 quando gli abitanti erano disarmati,
avendo il vicerè proibito il possesso delle armi, giunsero a formarsi squadre
banditesche di apprezzabile consistenza e audacia. Si era tentato di risolvere
il problema introducendo (o reintroducendo) nelle zone interne, all’inizio del
1650, le milizie barracellari. Sul finire del decennio, per rendere più
incisiva la lotta al dilagare della delinquenza, si trasformò i barracelli in
“soldati di campagna” inquadrati in compagnie. Nonostante ciò non pare siano
stati raggiunti sostanziosi e durevoli effetti. Sul modello delle risorte faide
feudali, alle “bardane”
(razzie) si contrapponevano “bardane”: assalito di notte da una banda di
malfattori, tutto il paese di Bitti si ribellò e reagì contrattaccando i
banditi.
Il quadro tracciato dal “Discurso” aveva in effetti il fine
preciso di dimostrare come solo la nuova sala criminale potesse porre un
termine ai guasti prodotti nei gradi bassi della giustizia con la pratica della
composizione dei delitti. Occorre anche aggiungere che le cause d’appello erano
comunque tante e così mal istruite da non potersi far fronte con un solo
“ministro”, per giunta con appena quattro ore settimanali a disposizione. Per
tutte queste ragioni altro rimedio non vi era se non la separazione delle
materie. Il timore che il costo dei processi gravasse sui vassalli era
infondato giacchè le indennità dovute ricadevano sui delinquenti riconosciuti
colpevoli e che, essendo il costo della vita nell’isola alquanto modesto, erano
comunque più basse che altrove: 2-3 ducati giornalieri contro i 6 della Sicilia
e i 10 di Napoli.
Nel settembre 1650 veniva attivata la nuova sala criminale
cui fecero seguito, con la sua entrata in funzione, lamentele dovute ad un
potenziamento considerevole della burocrazia regia, donde il patetico tentativo
di rigetto del nuovo organismo.
Intanto gli stamenti avevano formulato una serie di richieste
da presentare al re che tendevano a far si che la Corona trovasse, nei
confronti della Sardegna, una nuova linea politica capace di affrontare e
risolvere i problemi. Le richieste furono presentate a Madrid dove Filippo IV
diede garanzia per il loro accoglimento, ma esse non ebbero mai attuazione.
Crebbe così ancor più il malcontento generale che lasciò intravedere come nella
società sarda di quegli anni andasse maturando una coscienza politica e una
inquietudine sociale anche se non paragonabile a quella che si andava
manifestando negli altri regni della Corona.
Nella seconda metà del 1630 l’isola fu investita da
una terribile congiunzione di flagelli, non tutti naturali. Una “influenza”
generale nel 1638, intersecandosi con le leve dei due “tercios” inviati in
Lombardia e in Galizia provocò un calo del 25% della popolazione facendo
scarseggiare forze di lavoro. A determinare poi molti anni di cattivi raccolti
concorsero ora piogge eccessive, ora siccità tali da ridurre la terra
improduttiva, nonché quattro anni consecutivi segnati dalla piaga delle
cavallette che distrusse ogni filo d’erba. A questa biblica calamità si
sovrappose la grave mortalità che nel 1635-36 causò un crollo nel settore
zootecnico. In effetti con tanta gente che vagava per i campi sostenendosi solo
con erba selvatica, e l’influenza del 1638, difficilmente correlabile con la
crisi epidemica che travagliò l’Italia nei primi anni del 1630, si raggiunse un
apice di debilitazione generale conseguente all’accumularsi della crisi
armentizia con quella ceralicola che fu molto grave specie nel 1639.
La Sardegna ebbe altre due grandi crisi demografiche nella
seconda metà dei seicento. La prima si abbattè sull’isola subito dopo la metà
del secolo al limitare di una produzione agricola relativamente alta, di cui
ben poco avevano beneficiato i produttori, largamente espropriati dalle città
(tramite l'annona), dagli ecclesiastici (con la decima), da baroni e mercanti
(con i cespiti feudali e l’usura), questi ultimi quasi tutti genovesi, oltre
che dalle gravose esigenze militari della monarchia in quegli anni impegnata a
reprimere la rivolta catalana. A quella repressione l’isola contribuì con
uomini di leva e cavalli, ma soprattutto con grano, orzo e legumi. In cambio importava
la peste, che tra aprile e maggio 1652 attaccava Alghero e Sassari. Dalla
capitale del Logudoro questa si mosse verso est, inoltrandosi in Anglona e
nella Gallura; verso sud tra agosto e settembre precipitandosi verso il
campidano di Oristano; ai primi del 1653 entrava a Sanluri. A fine giugno, nel
clima euforico determinato dalla stasi del morbo, si pensa di attirare colonie
di genovesi, napoletani e siciliani per ripopolare Sassari e Alghero, ma sul
finire del 1653 il vicerè traccia un consuntivo della mortalità da epidemia,
che assomma a 54.314 persone, di cui 22.000 nella sola Sassari. Purtroppo ai
primi del 1654 da Villasor giungono le avvisaglie della seconda ondata che
rapidamente investe tutto il campidano. Questa volta cade anche la capitale del
regno; nel novembre 1655 la pestilenza compare nel sobborgo di Villanova, nel
febbraio 1656 capitola il Castello e ad ottobre Cagliari è ancora in
quarantena. L’epidemia vi rimane fino al 1657 inoltrato, toccando una seconda
volta alcuni villaggi del campidano di Oristano, mentre non sembra sia
penetrata nel massiccio roccioso della Barbagia e in Ogliastra.
Gli stati del tempo si presentavano piuttosto impotenti di
fronte alle epidemie. Vieppiù lo era la Sardegna che non disponeva ancora di
una stabile magistratura sanitaria. Il protomedico del regno, residente a
Cagliari, aveva competenza comunque meramente tecnica. Come era venuto, il
morbo se ne andò: l’operato delle autorità servì solo a creare un robusto
cordone sanitario per proteggere la capitale e per alleviare e contenere le
conseguenze che furono piuttosto pesanti per le finanze dei centri colpiti che
dovevano pagare di tasca propria i soccorsi loro prestati.
I quegli anni e in quei frangenti si verificò una grave
sottovalutazione dell’epidemia da parte del vicerè di allora, Lemos, per il
quale, ufficialmente, la peste non esisteva nell’isola, egli definì il flagello
dovuto semplicemente a febbri non meglio identificate. Quando la situazione
precipitò fu accusato di non avere preso alcuna misura sanitaria e richiamato a
Madrid per discolparsi. Le funzioni di vicerè vennero assunte da Bernardino
Mattia Cervellon, persona che godeva del favore popolare, che promosse una
manifestazione di fede invocando l’aiuto di Sant’Efisio – martire cagliaritano
– perché facesse cessare il flagello; fu così che da allora fu avviata la
tradizionale sfilata-processione del 1° maggio a Cagliari.
I collegi gesuitici di Cagliari e Sassari, attivi dalla
seconda metà del cinquecento, erano in condizione di conferire gradi accademici
con validità esclusivamente canonica e sulla loro elevazione in università si
discusse lungamente e conflittualmente nel parlamento. Con l’intento di
incentivare la formazione dei quadri intellettuali, per non fare ricorso alle
università di Spagna e d'Italia o di altri regni, già nel 1602 si formulò una
concreta ipotesi di istituire una università che per Cagliari, nel 1605, ebbe
l'assenso regio e l'anno dopo la legittimazione pontificia, mentre per Sassari
una consimile richiesta restava per il momento lettera morta. Ora Cagliari
accedeva a tutti gli effetti giuridici alla facoltà di costituire una
università pubblica e nel 1626 essa entrava in funzione con quattro cattedre di
teologia, due di scolastica, due di medicina e tre di filosofia.
Solo nel 1634 l’università di Sassari raggiungeva
l’adeguamento, anche se parzialmente strutturale, a quella di Cagliari. Occorre
però precisare che nel 1611 munifiche donazioni furono devolute al collegio
gesuitico sassarese al fine di conseguire i gradi accademici di “baccellierato”
e dottorato per gli studenti poveri. L’anno dopo il collegio sassarese veniva
di fatto dal Generale della Compagnia innalzato ad università pontificia
sull’esempio di altri collegi. In assenza di bolla pontificia, le autorità
cittadine nel 1617 strapparono per i gesuiti sassaresi il riconoscimento regio
del titolo di università – non quella di “studio generale” – e limitatamente
per le sole facoltà di filosofia e teologia. Quella di Sassari, in seguito a
difficoltà economiche e cause giudiziarie, nel 1679 restava una università
gesuitica con privilegio regio, ma non pontificio, il che, se non costituiva un
caso unico della Corona d’Aragona e nel resto d’Europa, la distingueva
sostanzialmente da quella di Cagliari la quale per il diverso ruolo della città
giunse a metà secolo ad appropriarsi della nomina del rettore che da quel
momento non fu più (di diritto) l’arcivescovo, bensì (da esso eletto) il
canonico della cattedrale.
C’è da aggiungere il poco noto diploma del 18 ottobre 1632
col quale Filippo IV stabiliva che non si potevano allontanare i professori
dalle università se non con sentenza del giudice.
Purtroppo bisogna riconoscere che queste università non
mantennero per molto tempo il relativo splendore dei primi giorni. Col tempo,
infatti, le cattedre cominciarono ad andare deserte e i pochi insegnanti
disponibili privilegiarono il più remunerativo insegnamento privato. D’altra
parte il calo di interesse per l’istruzione universitaria, sul versante sia
degli studenti che dei docenti, fu legato al restringersi degli sbocchi
occupazionali che si era delineato sin dagli inizi degli anni 1630-40, proprio
mentre decollavano le università sarde.
Filippo IV fu colui che favorì maggiormente la diffusione
della cultura nell’isola. E’ nota la carta reale che diresse al marchese di
Castel Rodrigo, datata 11 aprile 1658, in cui si stabilisce che i libri non
siano “compresi nella proibizione di
contrabbando ” ordinando pertanto che nei porti sardi “non si impedisca il commercio dei libri e l’ingresso e l’uscita di essi
”. E non risponde a verità il divieto da parte del sovrano di “ogni genere di rappresentazione teatrale
”. La carta reale del 6 maggio 1650, cui si riferiscono alcuni storici,
riguarda una disposizione attinente il regno di Castiglia ed estesa a tutti i
regni della Corona d’Aragona, e non per vietare o ridurre la possibilità di
espansione di cultura nell’isola bensì per ricordare al vicerè di Sardegna che
anche questa doveva mantenersi fedele alle disposizioni estese a tutti gli
stati. La morte di una persona della famiglia reale, una guerra o una calamità
pubblica erano motivo sufficiente affinchè, in segno di lutto o di dolore, si
chiudessero temporaneamente i teatri pubblici. Filippo IV, tanto incline ai
divertimenti, specialmente al teatro come spettatore, attore e perfino, secondo
voce diffusa tra il popolo, come autore, non poteva prendere tale decisione se
non per un giustificato motivo.
Nell’agosto del 1665 arrivò in Sardegna, come vicerè, il
marchese di Camarassa Emanuele de los Cobos. Egli era venuto nell’isola pieno
di pregiudizi, motivo per il quale assunse un atteggiamento di diffidenza e di
chiusura nei confronti dei sardi, Di lui si parlerà molto negli anni a venire.
Filippo IV morì nel 1665 lasciando un paese assai indebolito
dalle lunghe guerre e ridotto nella sua estensione territoriale. Lo sostituì
suo figlio Carlo II d’Asburgo, di quattro anni, sotto la reggenza della madre
Marianna d’Austria e di altri.
CARLO
II D’ASBURGO (1661-1700)
V
RE DI SPAGNA – RE DI SICILIA – RE DI NAPOLI
14°
RE DI SARDEGNA DAL 1665 AL 1700
 Quando Carlo II d’Asburgo, figlio di
Filippo IV, salì al trono, aveva quattro anni ed era un bambino malaticcio. Il
peso del governo fu affidato a un consiglio di reggenza presieduto da sua
madre, la regina Marianna d’Austria, e da altri ministri.
Quando Carlo II d’Asburgo, figlio di
Filippo IV, salì al trono, aveva quattro anni ed era un bambino malaticcio. Il
peso del governo fu affidato a un consiglio di reggenza presieduto da sua
madre, la regina Marianna d’Austria, e da altri ministri.
La regina si muoveva in una situazione di decadenza generale,
il governo era incapace e inetto e il malgoverno accentuò la decadenza della
Spagna che fu trascinata nelle diverse coalizioni europee contro Luigi XIV
durante la guerra che fu detta dei “nove anni”. I rovesci militari che si
succedettero costrinsero la Spagna a cedere i territori delle Fiandre e buona
parte delle conquiste, comprese alcune colonie americane.
E così la Spagna, ormai in una situazione di crisi
irreversibile, aveva rinunciato a esercitare un ruolo egemonico in Europa,
mentre le condizioni di salute del suo re cominciavano a interessare la
diplomazia internazionale.
Carlo II nel 1680 aveva sposato Maria Luisa d’Orleans ma,
poiché era impotente, non aveva avuto figli. Rimasto vedovo, nel 1689, aveva
contratto un secondo matrimonio con Anna di Baviera Neoburg. Ormai l’impotenza
del re non era più un mistero, la certezza della estinzione del ramo spagnolo
degli Asburgo andava ponendo alle potenze europee il problema della
successione. Esse cominciarono a pensare concretamente alla spartizione
dell’impero spagnolo dopo la morte di Carlo II.
Entro questa cornice di riferimento si compì l’ultima fase
della storia dell’unione personale del regno di Sardegna alla dinastia degli
Asburgo di Spagna e, con il regno di Carlo II, il lungo periodo spagnolo della
storia della Sardegna si avviò a conclusione. La vicenda aveva avuto inizio nel
1665, quando Emanuele de los Cobos marchese di Camarassa, nominato vicerè di
Sardegna assunse il suo ufficio essendo ancora in vita Filippo IV, in un
momento in cui le tensioni e il malcontento nell’isola erano al culmine. Il
nuovo vicerè, condizionato dalla sua diffidenza nei confronti dei sardi, si
isolò politicamente e, dopo la morte del vecchio re, adottò un comportamento
ancora più chiuso.
In questa difficile situazione si verificò in Sardegna un
fatto di inaudita gravità: all’alba del 20 giugno 1668, a Cagliari, fu trovato
assassinato l’attempato Agostino di Castelvì marchese di Laconi il quale
conduceva una battaglia antigovernativa per la concessione delle cariche
istituzionali ai nobili nativi dell’isola. I partigiani del marchese si
vendicarono un mese dopo freddando, il 20 luglio, a schioppettate, il vicerè
marchese di Camarassa considerato, dagli amici e dai parenti il mandante
dell’assassinio di colui che aveva tentato di agitare a corte le ragioni del
malessere dell’isola. Il fatto fu interpretato come un movimento di ribellione
contro la corona e scatenò le immediate reazioni di Madrid: furono inviate
truppe e istruiti processi. L’episodio esasperò ancor più i rapporti fra la
nobiltà sarda e quella di comando proveniente dalla penisola spagnola. C’è
ancora una lapide che lo ricorda, al n. 32 di via Nicolò Canelles:
PARA PERPETUA NOTA DE
INFAMIA DE QUE FUERON TRAYDORES DEL REY NUESTRO SEÑOR …
Alcuni anni dopo, l’atteggiamento del governo centrale nei
confronti della Sardegna sembrò modificarsi, la tensione diminuì e furono anche
concessi molti titoli nobiliari e molti benefici, quasi a volere chiudere lo
strappo degli anni precedenti. Al primo consigliere di Cagliari fu concesso di
portare nelle cerimonie solenni una medaglia d’oro con lo stemma della città e
l’effigie reale, ornamento che ancora oggi il rappresentante del sindaco –
l’Alter Nos - porta nella processione di Sant’Efisio. Negli stessi anni fu
portato a termine nella cattedrale di Cagliari il mausoleo di Martino
d’Aragona.
Il prestigio della feudalità nel suo insieme uscì fortemente
scosso dalla crisi Camarassa, anche se negli stamenti alcuni dichiararono che
per il regno le ferite erano ormai guarite. Lo strappo, tuttavia, non fu più
compiutamente ricucito e solo nel 1686 il vicerè provvide a far togliere dalle
torri di Cagliari ciò che restava delle teste degli sventurati protagonisti
della congiura.
Nel 1668 Carlo II attua l’attesa e importante riforma
monetaria che consiste nell’emettere nuove monete di buona lega e bello stile
in sostituzione soprattutto delle numerosissime monete false di piccolo taglio.
Nel 1671, dopo circa ottant’anni, cessa in Sardegna anche la coniazione dei
cosiddetti brutti “maltagliati”, cosa che invece si protrarrà ancora per
decenni in altre parti d’Europa.
Con la stessa prammatica del 1668 si dichiarano esenti da
diritti reali tutti coloro che si dedicheranno alla pesca del corallo. Già nel
secolo XVI l’industria del corallo acquistò un certo splendore; in Alghero
duecento fregate e duemila uomini si dedicavano a questa attività. Alfonso X il
Saggio ne “El lapidario”, del 1279, dice che il corallo (molto apprezzato e
importante a quei tempi) “è ricavato in
molti luoghi, ma il migliore di tutti è quello che si trova nel mare
d’Inghilterra e nell’isola di Sardegna ”. Non fu mai sufficientemente
sfruttato dai sardi.
La produzione granaria nella Sardegna conobbe forti
oscillazioni di breve e lungo periodo. Dopo metà secolo, sotto i colpi della
grave epidemia degli anni 1652-57, essa cala di nuovo e piuttosto bruscamente
per restare a lungo depressa e subire una robusta mazzata dalla dura carestia
del biennio 1680-81. In tale occasione si verificò un’alta mortalità forse più
consistente di quella epidemica, proprio perché agì in simultanea su scala
isolana, tanto che il morbo spinse i regni della Corona a chiudere i commerci.
Il bilancio finale tracciato dalla giunta dello stamento militare, fa sommare i
morti a 80.000 anime circa. Annate calamitose, più circoscritte nello spazio,
si ripeterono nella seconda metà degli anni ’80. Nel biennio 1685-86 si ebbe
scarso raccolto nelle diocesi di Ales, Oristano e Sassari. Il caso sardo fu
comunque tutt’altro che anomalo, si inserì a pieno titolo nella congiuntura
mediterranea di fine secolo.
Si torna a battere sul sistema difensivo statico per il
sostanziale fallimento di quello mobile, attestato su poche, macilente e mal
equipaggiate galere, per le quali c’era persino difficoltà a garantire il
sostegno finanziario. Il sovrano, per compensare quelle difficoltà, nel 1686
dovette autorizzare l’impiego delle galere nella poca credibile efficacia della
guerra di corsa. L’amministrazione delle torri litoranee nel Logudoro registrò
a fine secolo entrate annue inferiori di un terzo a quelle del meridione. Si
aggiunga che vi fu nell’isola anche una generale riduzione dei salari, più
forte per artiglieri e soldati. Molte torri vennero ridotte a semplici vedette;
venne abolita quella di Portoscuso e altre poste a salario ridotto. Al termine
di questa operazione i militari addetti alle torri a salario ridotto sono: 84
soldati nel nord e 107 soldati nel sud. Senza contare quelle a spese dei
feudatari, in tutta l’isola le torri effettive ed efficienti si ridussero del
57,15% rispetto ad un secolo prima, quando il progetto sembrava
promettentemente avviato verso l’ipotizzato tetto di 132. Al parziale
declassamento delle torri litoranee seguì il taglio dei salari, che non fu
episodio isolato. Nel 1691 fece seguito una generale sospensione degli
stipendi, nonostante la giunta patrimoniale denunciasse “lo stato deplorevole degli impiegati, molti dei quali furono ridotti a
dover limosinare “.
Nel 1700 il
debito pubblico con gli interessi incidono per il 26,5% sulle spese ordinarie.
Questo risultato del fiscalismo regio, congiuntura agricola e parassitismo
delle classi dirigenti locali, che scaricano sull’amministrazione il reale
costo delle torri costiere e sui contadini quello delle galere, sono i fattori
che finiscono col concorrere, cumulando gli effetti, ad aprire falle
deficitarie sempre più ampie nella struttura dei bilanci sardi. Il processo nel
lungo periodo si presenta irreversibile, mettendo a sua volta in moto il
meccanismo perverso di un sempre più massiccio indebitamento
dell’amministrazione locale verso terzi, costituiti da un ristretto gruppo di
finanzieri, i più cospicui dei quali continuano ad essere genovesi.
Nell’ultimo
parlamento del seicento si registra un peraltro timido ritorno di fiamma di
Sassari, che vorrebbe ospitare il governo viceregio per almeno un anno del suo
triennio. Ma Sassari fu protagonista per un altro fatto. Dove con più
pertinacia si esprimeva il corporativismo urbano era nel divieto a tenere
bottega nei villaggi, confermato nel 1684, motivato dalla necessità di impedire
il contrabbando. Ma la Giunta Patrimoniale, nel 1687, facendo notare che il
fenomeno non interessava tutte le città, si espresse contro tale normativa in
quanto i poveri, che formavano il maggior numero della popolazione sarda non
potendo per mancanza di mezzi trasportare nelle lontane città i pochi frutti
che raccoglievano, li commerciavano nello stesso loro paese. La città di
Sassari insisteva per confermare tale proibizione mentre diverso era
l’atteggiamento di Cagliari dove non esisteva tale divieto, col risultato che
il numero di dette “botteghe” in occasione di feste e di fiere nei villaggi,
era molto maggiore che non in tutte le città prese insieme. “E fa veramente pietà – esclamava la giunta
- il vedere che, mentre in altri regni
e provincie si formano commissioni allo scopo di creare nuove industrie e cercare
con ogni mezzo possibile di accrescere il commercio, sola fonte di ricchezza
dei popoli, la città di Sassari pretende invece di restringere ed annullare
quel poco che esiste nel regno ”. D’altronde il commercio in Sassari
languiva per le violenze e le vessazioni usate nel 1679 verso i pochi
commercianti e negozianti di quella piazza costretti ad esportare per una pari
somma di quel che importavano, pena il raddoppio delle gabelle, mentre nelle
altre città esse si ribassavano di oltre la metà.
In questo
declinare di secolo la giurisdizione signorile deve guardarsi anche dalle
città, le quali nel parlamento reclamano che i baroni non abbiano la facoltà di
perseguire i sindaci delle comunità rurali nell’esercizio delle loro funzioni.
Esse insomma affiancano la burocrazia regia nel favorire il decollo delle
autonomie locali, come evidente garanzia di maggior agilità del mercato
interno. Assieme all’accaparramento dell’iniziativa parlamentare da parte delle
città, proprio lo sviluppo delle autonomie locali, sia pure in forma anch’esso
di prevalente municipalismo, costituisce l’altro fatto nuovo dei parlamenti
sardi nella seconda metà del 1600. In esse si consolida il costume delle
contrade e delle singole comunità di presentare le proprie istanze direttamente
alla Corona in sede parlamentare.
Particolarmente
significativo al riguardo è il caso della gallurese Tempio contro cui si era
rivolta l’ostinazione di Sassari nel perseguire il divieto di commercio nei
villaggi, nonostante il parere contrario da parte della giunta patrimoniale.
Tempio nel 1698 insisteva nel perorare la propria erezione in città, in nome di
un conclamato illustre passato e delle civili condizioni e qualità dei suoi
abitanti.
La spinta
alla liberazione del commercio interno esprime quindi l’emergere con prepotente
vitalità dell’economia rurale isolana. Essa si congloba in nuovi poli di
aggregazione territoriali i quali contendono alle statutarie città il controllo
del mercato. Loro e non più i baroni. La comparsa dei villaggi nella scena
parlamentare, rompendo la crosta sclerotizzata della tradizione, rappresenta il
versante politico più rilevante di quanto non appaia a prima vista.
Si è già
detto che gli “scolopi” – educatori – istituirono a Roma la prima scuola
popolare gratuita d’Europa ed ebbero sedi in Sardegna prima che in Spagna.
Infatti sono scolopi dell’isola quelli che creano il primo nucleo del
Calasanzio spagnolo. Sei scolopi sardi arrivano in Spagna nel 1678, seguiti da
altri con i quali, nel 1683 fonderanno la casa a Moya la quale, tre anni dopo,
verrà annessa alla provincia sarda, “data l’affinità tra sardi e catalani”. E
dei 25 fondatori delle Scuole Pie di Spagna, 18 erano sardi e il resto
napoletani. La provincia sarda constava di quattro collegi: Cagliari,
Noviziato, Isili e Tempio e il totale dei religiosi non superava il numero di
68. Queste scuole promossero in Sardegna nuovi fermenti culturali, già
suscitati e stimolati dalla precedente creazione dell’università.
Un dato poco
conosciuto è quello che la prima vita di San Giuseppe Calasanzio, in spagnolo,
dedicata a Carlo II e pubblicata a Madrid nel 1675, è opera di uno scolopio
sardo, Efisio Soto Real, di Nuraminis, che scrisse diverse opere e fu il
fondatore del collegio delle Scuole Pie di Tempio.
In Sardegna,
quindi, prosperavano, capillarmente diffusi, diversi ordini religiosi, dai
gesuiti ai mercedari, agli agostiniani, ai francescani, ai cappuccini,
domenicani, scolopi.
I sardi che avevano più possibilità o
maggiori aspirazioni andavano via dalla Sardegna al fine di ampliare i loro
studi in Spagna o in Italia, e anche alla ricerca di migliori sbocchi
occupazionali. Bologna, Pisa, Padova, Salamanca, Alcalà, Madrid, Saragozza
erano le università più frequentate dagli studenti sardi. Tra i secoli XVI e
XVII, si sa che fino a tredici sardi diventarono rettori o vicerettori
dell’università di Pisa, dove i giovani che provenivano dall’isola costituivano
un gruppo separato, anche aiutati con sussidi (documentati) elargiti dal re di
Spagna per favorire la loro crescita culturale.
Sarebbe
falso parlare di un grande sviluppo culturale nell’isola in relazione ad altre
parti del continente europeo. Ma in nessun modo l’isola si mantenne estranea ai
movimenti dell’epoca. Tuttavia, vi sono notizie di sardi che si distinsero
fuori dall’isola in Spagna e in Italia, che interessò i rami dello scibile
umano. Raggiunsero fama personaggi come i cattedratici Francesco Boyl, gli
umanisti Gavino Sambicucci e fra Ambrogio Machin, i teologi Giacomo Pinto e
Soto Real, i fiscali Girolamo Olives e Pietro Frasso, lo storico Francesco
Vico, il poliglotta Salvatore Vidal, e altri che ebbero un peso effettivo nella
cultura spagnola del suo tempo per apporti che superarono l’ambito nazionale:
Giovanni Tommaso Porcell, famoso epidemiologo; Vincenzo Bacallar, uno dei
fondatori della Reale Accademia Spagnola della Lingua; Antonio Machoni,
gesuita. Questi sono alcuni dei nomi che possono essere ricordati ma sono
sufficienti per dare un’idea di quali
uomini esistessero in quei tempi, sempre in relazione alle modeste condizioni
dell’isola.
La Sardegna,
pertanto, non volse le spalle né alla vita, né alla cultura del momento. Si
coltivavano tutti i generi e perfino si scriveva in diverse lingue, fatto che
dimostra la liberalità del governo spagnolo, che non ne impose mai una: la
storia si scriveva in latino o in spagnolo; gli scritti di materia giuridica in
latino; la poesia in spagnolo, in italiano o sardo; il teatro in sardo o in
spagnolo; il romanzo in spagnolo, come gli scritti di argomenti religiosi.
Lo studio
del pensiero sardo, scientifico, filosofico e, soprattutto teologico si va
formando. Certo che un pensiero genuinamente sardo non esiste. Ma c’è un nucleo
di opere che dimostrerebbero per lo meno la compartecipazione o la dipendenza
da culture superiori, che mai sono state scientificamente considerate.
E tra gli
strumenti di base del sapere di allora, si possono ancora ricordare le
biblioteche private di cui oggi abbiamo notizia, sebbene il loro numero non sia
precisamente confortante. Nei secoli XVI e XVII diversi bibliofili cercarono di
riunire importanti collezioni sia di opere inedite sia di manoscritti. Si
ricordino quelle più importanti già appartenute a Nicolò Canelles, quella
dell’arcivescovo di Cagliari Antonio Parragues de Castillejo e quella di
Monserrato Rossellò che constava di 5.000 volumi e che, sebbene incompleta, è
l’unica che si è conservata e costituisce oggi il fondo più importante
dell’attuale biblioteca dell’Università di Cagliari.
Il regno lentamente declinava; la Sardegna era retta da un
sistema di istituzioni in larga misura ancora medioevale. L’ordine pubblico era
in completo sfacelo, intere zone dell’isola erano teatro delle prepotenze di
bande armate a tal punto che uno spostamento da Sassari a Cagliari poteva
diventare una pericolosa avventura.
La grave crisi e l’imminente fine della dinastia sembra,
almeno durante gli ultimi decenni del seicento, non abbia fatto riscontrare
alcuna posizione in merito al distacco del regno di Sardegna dall’unione
personale con il re di Spagna.
Carlo II morì nel 1700 e non avendo eredi, per volere di papa
Innocenzo XI, testò in favore di Filippo di Borbone duca d’Angiò, che aveva
diciassette anni (ed era molto legato a suo nonno Luigi XIV), dando origine
alla guerra di successione spagnola.
FILIPPO V DI BORBONE (1683-1746)
VI
RE DI SPAGNA – RE DI SICILIA – RE DI NAPOLI
15°
RE DI SARDEGNA DAL 1700 AL 1708 E DAL 1717 AL 1720
(periodi
riferiti all’occupazione militare dell’isola)
 Filippo V di Borbone – VI re di Spagna –
figlio di Luigi di Borbone delfino di Francia, successe a Carlo II d’Asburgo
che lo aveva designato suo erede dando origine alla guerra di successione fra
Spagna e Francia da una parte, e Austria, Prussia, Inghilterra, Olanda,
Portogallo, il ducato di Savoia e il principato di Piemonte (gli alleati)
dall’altra.
Filippo V di Borbone – VI re di Spagna –
figlio di Luigi di Borbone delfino di Francia, successe a Carlo II d’Asburgo
che lo aveva designato suo erede dando origine alla guerra di successione fra
Spagna e Francia da una parte, e Austria, Prussia, Inghilterra, Olanda,
Portogallo, il ducato di Savoia e il principato di Piemonte (gli alleati)
dall’altra.
Filippo di Borbone fu proclamato re a Madrid il 18 febbraio
1701, ma la ricusazione del testamento da parte di Carlo III e dalle potenze
europee, alleatesi, provocò la guerra.
Gli alleati si mossero subito (l’Inghilterra, nel 1704,
occupò Gibilterra) e dopo alcuni successi iniziali delle truppe
franco-spagnole, il pretendente Carlo d’Asburgo arciduca d’Austria, ebbe la
meglio sbarcando a Barcellona dove, il 7 novembre 1705, venne accettato quale proprio
re col nome di Carlo III dai catalani, aragonesi, ecc. cioè il nucleo
continentale dell’antica Corona d’Aragona.
Nell’agosto del 1706 il Portogallo, entrato a sua volta nella
coalizione, fece penetrare le sue truppe in Spagna giungendo ad occupare Madrid,
anche se per poco.
Nel 1707 si ebbe una lieve ripresa delle truppe di Filippo V
ma la guerra europea continuò volgendo, invece, in favore della coalizione che
sosteneva l’Asburgo. Infatti nel 1708 gli Alleati ottennero una grande vittoria
a Oudenarde che sembrò decisiva per le sorti della guerra. In questa situazione
maturò l’idea della conquista della Sardegna. Nel 1709 gli inglesi
conquistarono Minorca, l’esercito di Filippo V venne sconfitto a Saragozza e
nel settembre Carlo d’Asburgo occupò Madrid.
Per quanto riguarda la Sardegna, questi fatti avviarono un
rapido processo di trasformazione che si concluse nel 1720. Tra le famiglie
dell’aristocrazia feudale e del clero covavano antichi rancori in parte legati
anche alla crisi Castelvì-Camarassa, e rivalità nuove. Le famiglie
dell’aristocrazia emergente, poi, erano vicine al nuovo partito asburgico, come
pure le famiglie della nascente aristocrazia gallurese. Quindi, dopo un primo
tentativo di sbarco a Terranova, nell’agosto del 1708 una flotta anglo-olandese
di quaranta navi si presentò di fronte a Cagliari e chiese la resa. Purtroppo
mentre erano in corso le trattative l’ammiraglio inglese Leake fece bombardare
la città senza alcuna ragione. Dopo una breve resistenza le truppe d’invasione
presero possesso della città e quindi dell’isola, mentre i partigiani di
Filippo V furono costretti a fuggire in Spagna.
Cagliari, capitale del regno di Sardegna, si arrese all’alba
del 13 agosto 1708 all’ammiraglio inglese Leake il quale, a nome di Carlo III,
promise di rispettare tutti i privilegi e i diritti già in godimento. Il 16
agosto fu nominato vicerè il filo-asburgico Fernando de Silva che,
immediatamente chiese la consegna delle chiavi di tutte le città e paesi del
regno; poi pretese nuove tasse dai sudditi e ordinò il sequestro dei patrimoni
di chi si era opposto alla conquista dell’isola, mentre ai partigiani che
avevano perorato e facilitato l’invasione vennero profusi titoli e benefici. Il
7 ottobre dello stesso 1708 i maggiorenti del regno, in una fastosa cerimonia
svoltasi nel duomo di Cagliari, tra salve di artiglieria, suoni di campane e la
musica della cappella del duomo, giurarono fedeltà al re Carlo III.
Intanto Filippo V non stette li solo a subire e iniziò una
controffensiva. In breve tempo la situazione in Spagna, dove il popolo era a
lui favorevole, fu ribaltata e le truppe di Carlo d’Asburgo furono poste in
difficoltà.
Nel 1710 l’esercito
spagnolo riportò una serie di vittorie e Filippo V riconquistò Madrid
attestandovisi saldamente.
La guerra europea sembrava non dovesse mai finire e mentre i
due schieramenti continuavano a logorarsi, il 17 aprile 1711 morì l’imperatore
Giuseppe I e suo fratello Carlo divenne Imperatore del Sacro Romano Impero con
il nome di Carlo VI. Questo spaventò molto gli alleati che vedevano, in
prospettiva, ricostituita l’antica potenza di Carlo V d’Asburgo. La nuova
improvvisa situazione impose alla diplomazia europea la ricerca di una
soluzione che arrivasse a una pace che portasse comunque alla divisione dell’eredità
spagnola, e così le potenze europee, nel 1712, avviarono il congresso di
Utrecht che si concluse nell’aprile del 1713 con la stesura di un trattato di
pace le cui clausole però, a loro volta, non furono in seguito accettate e,
anzi, condussero a una nuova crisi che si ricompose definitivamente solo nel
1720.
Il trattato di Utrecht riconosceva Filippo V sovrano di
Spagna in cambio della cessione del regno di Sicilia ai duchi di Savoia, e
Gibilterra agli Inglesi. Ma, come detto, questo trattato non piaceva molto a
nessuno dei due contendenti, né a Filippo V né tantomeno a Carlo VI che non si
era rassegnato a rinunciare alla corona spagnola.
Per tutto questo a rimetterci furono soprattutto i catalani
di Barcellona i quali, abbandonati dall’imperatore Carlo VI, loro re,
capitolarono nel settembre del 1714 seguiti, nel giugno dell’anno successivo,
da Maiorca e Ibiza. Con tutti costoro Filippo V fu durissimo: abrogò ogni
privilegio e pose fine al riconoscimento della Corona d’Aragona come istituzione
giuridica.
Nel 1714, Filippo V rimasto vedovo e risposatosi con
Elisabetta Farnese, erede del ducato di Parma, vide riaprirsi una nuova
prospettiva per il reinserimento in Italia degli interessi della Spagna.
A questo punto è forse opportuno ricordare che la Sardegna
era occupata, dal 1708, dalle truppe di Carlo VI; in pratica i re di Sardegna
in quell’epoca furono contemporaneamente due: Filippo V che ne era stato
spossessato e Carlo VI l’occupante. Inoltre, fra il marzo e il settembre del
1714, con la definizione del trattato di pace, la Sardegna ufficialmente passò
agli Asburgo (insieme ai Paesi Bassi, al ducato di Milano e al regno di Napoli)
mentre la Sicilia venne assegnata ai Savoia come ricompensa per la loro
politica.
Le mire politiche di Filippo V e di sua moglie Elisabetta
Farnese, però, cominciarono a insospettire le potenze europee che avviarono in
gran segreto la formazione di una coalizione anglo-franco-imperiale per
fronteggiare la Spagna.
A Filippo V non mancò l’occasione per passare al confronto
armato tra la Spagna e la Triplice Alleanza. Il re incoraggiato da molti
personaggi della sua corte – soprattutto dal cardinale Giulio Alberoni, suo
primo ministro – avrebbe voluto inviare subito in Italia una flotta con un
potente corpo da sbarco, ma quando il Consiglio di Stato si pronunciò per
l’intervento l’Alberoni suggerì, per evitare brutte sorprese, di limitare
l’impresa inizialmente alla conquista della Sardegna.
E così, salpata il 29 luglio 1717 e fatta sosta a Maiorca, la
flotta d’invasione composta da centodieci navi, il 17 agosto si presentò lungo
le coste dell’isola e il 20, giunta nel golfo di Cagliari, iniziò le operazioni
di sbarco per liberare la Sardegna “dall’ingiusta oppressione e dal tiranno
governo austriaco”. A Flumini di Quartu
sbarcarono 8.000 fanti e 600 cavalieri che si assestarono a Monte
Urpinu, mentre il vicerè nominato dal re Filippo V, Giovanni Bette, marchese di
Leide, pose il suo quartiere generale presso la chiesa della vergine di Lluc,
vicino Quartu. Egli invitò i sardi a prestare giuramento in favore di Filippo V
promettendo un indulto generale nei confronti di chi si era schierato con gli
Asburgo. Il 29 agosto 1717, malgrado i proclami bellicosi del vicerè asburgico,
la città di Cagliari, cannoneggiata, aprì le porte agli spagnoli che, in poco
più di due mesi, si impossessarono di tutta l’isola.
Il 12 ottobre fu nominato un nuovo vicerè, Giuseppe
Armendariz marchese di Castelforte il quale, contrariamente alle promesse di
indulto del suo predecessore, si comportò severissimamente dando inizio ad un
duro regime militare oppressivo e fiscale, perseguitando tutti i seguaci
dell’imperatore. L’iniziale simpatia con la quale fu accolto il ritorno delle
truppe spagnole ben presto si trasformò in odio. Gli ex partigiani degli
Asburgo ai quali, come detto, in un primo momento era stato promesso un indulto
generale, ebbero invece i beni confiscati e furono costretti a rifugiarsi in
Gallura dove organizzarono una fiera resistenza, unendosi ai banditi che
infestavano la regione.
Mentre la delusione per il ritorno della Sardegna sotto
l’amministrazione spagnola andava estendendosi nell’isola, Filippo V,
approfittando delle incertezze della diplomazia internazionale, riprese con
maggiore vigore il disegno di reinserimento della Spagna in Italia. Quindi
ordinò al marchese di Leide di spostarsi con la flotta verso la Sicilia dove,
il 5 luglio 1718, sbarcò 30.000 uomini, muniti di un imponente apparato
d'artiglieria e ben equipaggiati. L’isola alla fine dello stesso mese cadde
nelle mani delle truppe spagnole.
A questo punto le potenze europee si coalizzarono nuovamente
e il 2 agosto 1718 Inghilterra, Francia, Olanda e Austria, stipularono a Londra
un patto di quadruplice alleanza contro la Spagna accusata di volere sovvertire
le clausole del trattato di Utrecht, con l’obiettivo di procedere a una nuova
sistemazione dell’assetto territoriale europeo.
Iniziò dunque un nuovo conflitto. La flotta inglese, dopo
avere distrutto quella spagnola al largo di Palermo, l’11 agosto fece sbarcare
in Sicilia un’armata austriaca, mentre le truppe francesi invadevano la
Catalogna. La nuova guerra divenne insostenibile per la Spagna e nel febbraio
del 1720 si giunse così al trattato di pace che fu firmato a Londra e
pubblicato all’Aia.
In base a questo trattato Filippo V rinunciò alle sue
conquiste e i regni di Napoli e di Sicilia andarono a Carlo d’Asburgo. Lo
stesso trattato interessò Vittorio Amedeo di Savoia in quanto stabiliva che la
Sicilia, già posseduta o assegnata ai Savoia in base al trattato di Utrecht,
fosse data agli Asburgo. Questi ultimi, a loro volta, dovevano cedere la
Sardegna ai Savoia. La cessione “dell’isola maggiore del regno di Sardegna” ai
Savoia suscitò le proteste della Santa Sede che, nel lontano 1297, aveva dichiarato
inalienabile questo regno da essa istituito.
L’isola in attesa della definitiva cessione ai Savoia doveva
essere formalmente consegnata a Carlo d’Asburgo in quanto era occupata dalle
truppe spagnole. La procedura iniziò l’8 maggio 1720 a Palermo con la stipula
del trattato in base al quale i Savoia cedevano il regno di Sicilia agli
Asburgo i quali, in cambio, cedevano a loro volta il regno di Sardegna ai
Savoia.
Il 20 maggio 1720 Vittorio Amedeo II nominò primo vicerè
sabaudo il barone Filippo Guglielmo Pallavicino di Saint-Remy che sbarcò a
Cagliari il 16 luglio, con alcuni reggimenti piemontesi. Un ufficiale della
nave inglese che portò il Pallavicino da Palermo a Cagliari, osservava nel suo
diario di bordo che “la Sardegna non
presenta nessun altro vantaggio per il principe che quello di portargli il
titolo di re ”. Era vero, ma non era poco per una dinastia che da secoli
cercava un regno territoriale e che, con esso, avrebbe fatto la sua fortuna
italiana.
Il 31 luglio arrivarono anche il principe Ottajano,
rappresentante dell’imperatore, e l’ammiraglio inglese Byngh, e si diede inizio
alle procedure per il passaggio delle consegne in un clima di reciproca
cortesia ed in forma pacifica e solenne.
Il 4 agosto il vicerè spagnolo Chacon cessò le sue funzioni
consegnando l’isola al rappresentante dell’imperatore e il 5 le truppe spagnole
(circa 4.000 uomini) lasciarono l’isola per la madre patria. Il successivo 8
agosto 1720 il principe Ottajano consegnò il regno di Sardegna al
rappresentante di Vittorio Amedeo II alla presenza delle prime voci dei tre
stamenti (parlamento). A partire da questo momento il barone Pallavicino di
Saint-Remy assunse formalmente i suoi poteri che, in base al trattato dell’Aia,
erano identici a quelli esercitati dagli altri vicerè spagnoli. Tale trattato,
infatti, imponeva il mantenimento di tutti gli ordinamenti esistenti.
Con tale atto si concluse il lungo periodo di dominazione
catalano – aragonese - spagnola dell’isola protrattosi per quattro secoli, dal
1323 al 1720.
La consegna, nello stile dell’epoca, coincise con feste e
luminarie che coinvolsero tutte le città della Sardegna e culminarono il 2
settembre nel duomo di Cagliari col giuramento solenne. La cerimonia cominciò
alle cinque del pomeriggio quando i giudici patrimoniali, la Reale Udienza e i
tre stamenti si recarono al palazzo viceregio per accompagnare il Saint-Remy in
duomo. Il corteggio passò solenne fra due ali di popolo. L’ordine di questi
personaggi era rigorosamente stabilito: i dignitari entrarono in chiesa tra
canti e suoni di campane, il vicerè si sedette sul soglio appositamente
predisposto, di fronte all’altare maggiore e circondato dalle più alte autorità
che si disposero lungo i gradini dell’altare. Si procedette quindi con il
giuramento di fedeltà al vicerè da parte di tutti i membri degli stamenti e,
infine, il Saint-Remy giurò a sua volta in lingua spagnola fedeltà agli statuti
del regno, Le feste durarono ancora tre giorni.
Riepilogando, Filippo V esercitò il suo potere sul regno di
Sardegna sino al 1708, e cioè sino all’occupazione militare dell’isola da parte
di Carlo III d’Asburgo, che avvenne il 13 agosto e si protrasse sino al 1717. Dal 1717 al 1720 la Sardegna fu rioccupata
dagli spagnoli di Filippo V. Poi, nell’agosto dello stesso 1720 il regno fu
“restituito” agli Asburgo e da questi ceduto a Vittorio Amedeo II di Savoia.
Nel 1724 Filippo V, gravemente ammalato, abdicò in favore del
figlio Luigi che moriva però dopo pochi mesi di regno; Filippo allora riprese
la Corona affidando il governo alla moglie Elisabetta Farnese la quale seppe
attuare un’abile politica che permise alla Spagna di riprendere parte dei suoi
antichi possessi europei.
Filippo V morì nel 1746.
Al termine di circa quattrocento anni di questa travagliata
storia sin qui molto succintamente descritta, si può dire che la Sardegna
iberica reale e feudale era in ogni caso fondamentalmente basata su una
conquista violenta, ed i suoi abitanti erano considerati quasi sempre dei vinti
dai catalano-aragonesi. Il governo impiantato dai vincitori tenne poco conto
delle libertà giudicali e comunali, tendendo piuttosto a ripagarsi delle spese
sostenute nelle campagne militari. Però è anche indiscutibilmente vero che alla
Corona d’Aragona e di Spagna si deve l’origine della nuova Nazione dei “Quattro
mori” e la creazione del “Regno di Sardegna” attraverso la quale passa la
storia d’Italia risorgimentale e monarchica.
E per concludere si può dire che l’avvento degli Aragonesi
nell’isola non è da ritenersi né trionfo né sconfitta ma la dolorosa nascita
della Sardegna di oggi.
CARLO
III D’ASBURGO - VI IMPERATORE
(1685-1740)
VII
RE DI SPAGNA – RE DI NAPOLI – RE DI SICILIA
16°
RE DI SARDEGNA DAL 1708 AL 1717
(periodo
riferito all’occupazione militare dell’isola)
 Carlo III figlio di Leopoldo I d’Asburgo
fu l’ultimo discendente in linea maschile degli Asburgo d’Austria. Egli era,
già dal 7 settembre 1701, il pretendente al trono di Spagna designato dalla
diplomazia internazionale per garantire un certo equilibrio politico europeo, e
per frenare eventuali disegni di egemonia sia dei Borboni sia degli Asburgo.
Carlo III figlio di Leopoldo I d’Asburgo
fu l’ultimo discendente in linea maschile degli Asburgo d’Austria. Egli era,
già dal 7 settembre 1701, il pretendente al trono di Spagna designato dalla
diplomazia internazionale per garantire un certo equilibrio politico europeo, e
per frenare eventuali disegni di egemonia sia dei Borboni sia degli Asburgo.
La cosa però
non era gradita alla diplomazia spagnola che vedeva così smembrato il suo
impero e diminuito il ruolo della Spagna in Europa.
In conseguenza di ciò scoppiò una guerra europea che vide
contrapposti il re Filippo V di Borbone e Carlo d’Asburgo. A sostegno dei
contendenti si formarono due schieramenti: l’Inghilterra e l’Olanda si
schierarono con gli Asburgo d’Austria. L’elettore di Baviera con la Francia di
Luigi XIV e, in un primo momento, il duca di Savoia si schierarono con Filippo
V di Borbone re di Spagna.
Nei primi anni di guerra sembrava che i francesi potessero
reggere bene il confronto, tanto da far sperare di chiudere il conflitto a
favore di Luigi XIV. Intanto nel 1703 le potenze della coalizione riconoscevano
Carlo d’Asburgo re di Spagna. Il duca di Savoia, come ricompensa per il suo
impegno, chiese il ducato milanese che però gli fu rifiutato per cui passò a
far parte dell’altra coalizione, alterando il rapporto di forze e consentendo
alle truppe austriache di attaccare frontalmente la Francia. La Spagna, che
territorialmente era stata sino ad allora risparmiata, fu direttamente
coinvolta dalle operazioni militari e, nel 1704, gli inglesi presero Gibilterra.
Il 14 ottobre 1705 Carlo d’Asburgo, sostenuto dalle truppe
della coalizione, sbarcò a Barcellona e riuscì a conquistarla. La popolazione
dell’intera Catalogna si sollevò contro Filippo V cui fece seguito anche il
regno di Valenza e, il 7 novembre 1705, Carlo d’Asburgo venne riconosciuto dai
catalani, aragonesi, ecc., quale proprio re col nome di Carlo III.
Nell’agosto del 1706 il Portogallo, entrato a sua volta nella
coalizione, fece penetrare le sue truppe in Spagna giungendo a occupare Madrid.
L’occupazione della capitale però durò poco, la popolazione della città nello
stesso 1706 si sollevò cacciando la piccola guarnigione portoghese.
La guerra europea continuava e sembrava volgere a favore
della coalizione che sosteneva l’Asburgo: nel 1708 la grande vittoria ottenuta
a Oudenarde sembrò decisiva per la sorte della guerra. In questa situazione
maturò l’idea della conquista della Sardegna che avvenne nel 1708; nel 1709 gli
inglesi conquistarono Minorca mentre Carlo d’Asburgo, dopo avere sconfitto a
Saragozza le truppe di Filippo V, occupò Madrid.
In Sardegna
le famiglie dell’aristocrazia emergente, dopo i fatti di Camarassa–Castelvì,
erano vicine al partito austriaco. Gli Alagon si posero a capo del partito
filo-asburgico che si andava formando nell’isola. La tensione salì alle stelle
a causa di una imprudenza commessa dal padre Ignazio Trincas, un frate
mercedario residente a Saragozza. Questi, quando Madrid fu occupata dai
portoghesi e l’arrivo nella capitale dell’arciduca Carlo sembrava imminente,
redasse una lista di sostenitori sardi dell’arciduca unitamente a una lista di
partigiani di Filippo V. Una copia del documento giunse nelle mani del sovrano
che fece arrestare immediatamente alcuni dei personaggi indicati nella lista la
quale era stata compilata dal frate sulla base di valutazioni soggettive e
prive di fondamento politico. Solo successivamente ci si accorse dell’errore
commesso. Comunque, l’elenco maldestramente compilato dal Trincas aveva ormai
reso palese che nell’isola si erano consolidati due schieramenti e agli alleati
apparve importante, per ragioni strategiche, togliere a Filippo V il controllo
della Sardegna.
L’impresa fu decisa in Spagna con l’aiuto dei partigiani
locali – gli Alagon de Silva in particolare – i quali presero ad agire
apertamente, soprattutto in Gallura. Così nel 1708 un contingente di truppe
imperiali sbarcava a Terranova trovando però una coraggiosa resistenza,
nell’agosto dello stesso anno una flotta anglo-olandese si presentò di fronte a
Cagliari e chiese al vicerè spagnolo la resa. Questi fu subito propenso ad
abbandonare l’isola senza tentare una ulteriore resistenza. Purtroppo, mentre
erano in corso le trattative per la resa, l’ammiraglio inglese Leake fece
bombardare la città senza alcuna ragione. All’alba del 13 agosto 1708 Cagliari
– capitale del regno – si arrese all’ammiraglio inglese il quale, a nome di
Carlo III, promise di rispettare tutti i privilegi già in godimento. Subito
dopo Cagliari, aderirono al nuovo governo Alghero e Castellaragonese (oggi
Castelsardo). Iniziò così il periodo “austriaco” della storia della Sardegna.
Il 16 agosto 1708 fu nominato vicerè filo-asburgico Fernando
de Silva che, immediatamente, chiese la consegna delle chiavi di tutte le città
e paesi del regno, poi pretese nuove tasse dai sudditi per mantenere
l’esercito, per rifornire di cereali Barcellona, per contribuire alle spese
matrimoniali del re con la principessa Isabella di Brunswick, ecc. Il suo
governo non lasciò né rimpianti né apprezzabili ricordi tranne forse un
arrogante emblema asburgico nella parrocchiale di San Giacomo a Orosei. Con la
stessa protervia ed esosità si comportarono gli altri quattro vicerè che gli
succedettero, provocando qualche tumulto popolare per la requisizione del grano
e l’introduzione della gabella sul tabacco.
Il 7 ottobre dello stesso 1708 – nello stile dell’epoca – i
maggiorenti del regno, in una fastosa cerimonia svoltasi nel duomo di Cagliari,
tra salve di artiglieria, suoni di campane e la musica della cappella del
duomo, giurarono fedeltà al re Carlo III.
Le fortune di Filippo V, però, erano in ripresa dopo alcune
vittorie nei confronti delle truppe di Carlo III ottenute nel 1710. Tanto più
che l’anno seguente, il 17 aprile, essendo morto senza eredi l’imperatore
Giuseppe I, il fratello Carlo gli succedette al trono imperiale col nome di
Carlo VI. Questo spaventò molto gli alleati che vedevano ricostituita l'antica
potenza di Carlo V per cui, dopo molti preliminari diplomatici, fra marzo ed
aprile del 1713 fu firmata la pace di Utrecht che riconosceva Filippo V sovrano
di Spagna e delle Indie (Americhe), in cambio della cessione del regno di
Sicilia ai duchi di Savoia, e di Gibilterra e Minorca agli inglesi.
Tra il marzo e il settembre del 1714, con la definizione del
trattato di pace la Sardegna ufficialmente passò agli Asburgo, cessò quindi di
essere contesa tra i due sovrani e passò da un’amministrazione militare ad
un’amministrazione civile.
Le clausole del trattato di Utrecht non piacevano a nessuno
dei due contendenti, né a Filippo V né tanto meno a Carlo d’Asburgo che non si
era rassegnato a rinunciare alla corona Spagnola.
Filippo V pensò, intanto, alla riconquista della Spagna. A
rimetterci furono soprattutto i Catalani di Barcellona che, abbandonati
dall’imperatore, loro re, capitolarono l’11 settembre 1714 seguiti, nel giugno
successivo, dagli abitanti di Maiorca e di Ibiza. Con tutti costoro Filippo V
fu durissimo: abrogò ogni privilegio autonomistico e pose fine, così, al
riconoscimento della Corona d’Aragona come istituzione giuridica. Poi rivolse
le sue attenzioni al regno di Sardegna e al regno di Sicilia.
Salpata il 29 luglio del 1717, la flotta di centodieci navi
giunse a Cagliari il 22 agosto dove sbarcarono a Flumini di Quartu 8.000 fanti
e 600 cavalieri che si attestarono a Monte Urpinu. Il giorno 29 la città,
cannoneggiata, aprì le porte agli spagnoli che poi, in poco più di due mesi
espugnarono Alghero e Castellaragonese e si impossessarono dell’intera isola.
Un anno dopo ripresero pure la Sicilia.
Lo stesso giorno dello sbarco, il 22 agosto 1717, fu nominato
vicerè spagnolo Giovanni Francesco Bette, ma in pratica governò nell’isola il
luogotenente Giuseppe de Armendariz che si comportò severissimamente e diede
inizio ad un terribile regime militare perseguitando i seguaci dell’imperatore,
molti dei quali si rifugiarono nei monti della Gallura.
Nel 1718 Gonzalo Chacon, nominato nuovo vicerè di Sardegna,
provvide a rinforzare le difese dell’isola nel momento in cui Inghilterra,
Francia e Olanda, unite ora all’Austria in un patto di quadruplice alleanza
contro la Spagna, accusata di volere sovvertire le clausole del trattato di
Utrecht, il 2 agosto di quell’anno 1718 stabilirono a Londra di “restituire il
regno di Sardegna all’imperatore Carlo VI”.
Infine per tenere insieme in un unico regno la Sicilia con il
Napoletano (già in possesso degli Asburgo), “accettarono che fosse scambiata fra l’imperatore e Vittorio Amedeo II
di Savoia l’isola maggiore del regno di Sardegna ”, malgrado le proteste
della Santa Sede che, nel lontano 1297, aveva dichiarato inalienabile questo
regno da essa istituito.
La guerra che seguì fu un disastro per la Spagna; la flotta
inglese, dopo avere distrutto quella spagnola al largo di Palermo, l’11 agosto
fece sbarcare in Sicilia un’armata austriaca, mentre le truppe francesi
invadevano la Catalogna. Questa situazione costrinse Filippo V a subire, il 26
gennaio 1720, le condizioni imposte dalle potenze alleate.
Il 20 maggio 1720 Vittorio Amedeo II di Savoia nominò vicerè
sabaudo il barone Filippo Gugliemo Pallavicino di Saint-Remy che raggiunse
Cagliari il 16 luglio. L’ufficiale della flotta inglese che portò il vicerè da
Palermo a Cagliari, osservava nel suo diario di bordo che: ”la Sardegna non presenta quasi nessun altro
vantaggio per il principe che quello di procurargli il titolo di re ”. Era vero, ma non era poco per una dinastia che da
secoli cercava un regno territoriale e che, con esso, avrebbe fatto la sua
fortuna italiana.
Il 31 luglio arrivarono a Cagliari anche il principe
Ottajano, rappresentante dell’imperatore, e l’ammiraglio inglese Byngh, e si
diede inizio alle procedure per il passaggio delle consegne in un clima di
reciproca cortesia e in forma pacifica e solenne.
Il vicerè
spagnolo Gonzalo Chacon smise le sue funzioni il 4 agosto 1720. Quattro giorni
dopo, l’8 agosto, l’incaricato imperiale Giuseppe de’ Medici consegnò il regno
di Sardegna nelle mani di Luigi o Ludovico Desportes perché lo desse a Vittorio
Amedeo II. Il suo luogotenente, barone di Sait-Remy diventò ufficialmente
vicerè del regno il 2 settembre, giurando, in lingua spagnola, agli stamenti
parlamentari di osservare, in ottemperanza degli accordi internazionali, le
leggi e i privilegi concessi dai precedenti governi.
Seguendo lo stile dell’epoca, le luminarie e le feste che
coinvolsero tutte le città della Sardegna, durarono alcuni giorni.
Riepilogando, gli austriaci ebbero il possesso del regno di
Sardegna dal 13 agosto 1708 al 1717. Sino al 1714 “militarmente”, e
successivamente al trattato di Utrecht, il regno fu assegnato “ufficialmente” a
Carlo d’Asburgo. Dall’agosto 1717 la
Sardegna fu nuovamente occupata militarmente dagli spagnoli di Filippo V sino
al 1720, quindi restituita agli Asburgo e da questi ceduta a Vittorio Amedeo II
di Savoia nell’agosto dello stesso 1720.
Carlo VI imperatore fu di mediocre personalità, incapace di
riforme e opere civili notevoli anche per l’opposizione degli “stati”. Egli
morì improvvisamente a Vienna nel 1740.
VITTORIO AMEDEO II DUCA DI
SAVOIA (1666-1732)
17°
RE DI SARDEGNA DAL 1720 AL 1730
 Figlio
di Carlo Emanuele II succede al padre nel 1675 all’età di nove anni, nella
guida del Ducato d’Aosta e del Principato di Piemonte e sotto la reggenza della
madre Giovanna Battista di Nemurs che si protrarrà sino al 1684.
Figlio
di Carlo Emanuele II succede al padre nel 1675 all’età di nove anni, nella
guida del Ducato d’Aosta e del Principato di Piemonte e sotto la reggenza della
madre Giovanna Battista di Nemurs che si protrarrà sino al 1684.
L’antichissima dinastia dei Savoia non era mai riuscita fino
al 1720 a guadagnarsi un reame, per cui il regno di Sardegna costituiva la
realizzazione di un sogno atavico, l’istituzione sovrana che la poneva fra le
grandi casate d’Europa. Come raggiunse questo risultato lo dicono qui,
succintamente, gli avvenimenti del XVIII secolo.
Lo scenario politico internazionale dell’epoca era in
continua evoluzione e quindi, periodicamente, si era alla ricerca di nuovi
assetti politici territoriali o commerciali. Tali circostanze rendevano
possibile ai Savoia di applicare la teoria delle “alleanze alternative”, in
base alla quale essi erano disponibili ad appoggiare uno dei due schieramenti
per modificare il rapporto di forze in campo.
Raggiunta la maggiore età, liberatosi dalla pressante
reggenza della madre e assunto in pieno il governo dello stato, Vittorio Amedeo
II nel 1690 entrò nella Grande Alleanza in guerra contro la Francia. Nella
successiva pace generale (1697) ebbe confermato dall’Europa il ricupero di
Pinerolo segnando un successo nell’opera di unificazione del Piemonte e
sottraendosi alla soggezione francese.
Quando nel 1701 scoppiò la guerra di successione spagnola il
duca di Savoia si schierò con Filippo V di Borbone re di Spagna. Come
ricompensa per il suo impegno, chiese il ducato Milanese che però gli fu
rifiutato per cui passò a far parte dell’altra coalizione (1703), alterando il
rapporto di forze e consentendo alle truppe austriache di Carlo d’Asburgo –
pretendente al trono di Spagna – di attaccare frontalmente la Francia e
coinvolgere così, direttamente, il suolo spagnolo nelle operazioni militari.
Conseguenza di tutto questo fu che quando il 12 luglio 1713 fu firmata la pace
di Utrecht, confermata a Astatt il 7 marzo 1714, il trattato prevedeva, fra le
altre clausole, la cessione da parte di Filippo V, del regno di Sicilia ai
duchi di Savoia come ricompensa per la loro politica, sennonché la difficoltà
di poter governare un paese così lontano facevano desiderare ancora, a Vittorio
Amedeo II, il Milanese.
Le clausole del trattato di Utrecht, però, non piacevano a
nessuno dei due contendenti e la guerra continuò ancora per alcuni anni, e cioè
sino al 26 gennaio 1720. Nel febbraio successivo si giunse al trattato di pace
che fu firmato a Londra e pubblicato all’Aia. Filippo V dovette sottostare a
quanto stabilito a Londra dalla Quadruplice Alleanza, già dal 2 agosto 1718.
Tale decisione interessò anche Vittorio Amedeo II in quanto stabiliva che la
Sicilia, già assegnata nominalmente ai Savoia dal trattato di Utrecht, fosse
“restituita” a Carlo d’Asburgo VI imperatore, in cambio della “isola maggiore
del regno di Sardegna”, da cedere, successivamente, dagli Asburgo ai Savoia.
Tutto ciò malgrado le proteste della Santa Sede che, nel lontano 1297, aveva
dichiarato inalienabile questo regno da essa istituito.
La Sardegna completamente spagnolizzata per tradizione,
lingua e cultura, senza il parere né l’approvazione degli stessi sardi (allora
non esisteva l’autodeterminazione dei popoli), passa nel 1720 sotto il dominio
dei Savoia, con i quali non aveva alcun vincolo né etnico, né storico, né
linguistico. L’isola passa così da una grande monarchia di Stati autonomi al
dominio di un piccolo Stato assoluto, senza marina, mentre da esso la separava
un grande tratto di mare e col quale non aveva avuto mai alcuna relazione.
L’unico legame col Piemonte lo si può addurre al fatto che Vittorio Amedeo II
era l’undicesimo discendente di Giacomo II d’Aragona, stabilendo in questo modo
una continuità dinastica, per essere la madre del nonno di Vittorio Amedeo,
Caterina, figlia di Filippo II d’Asburgo.
I Savoia non avevano accettato volentieri il cambio della
ricca Sicilia con il piccolo regno di Sardegna, povero ed arretrato. Viste le
clausole del trattato di Londra, però, il regno di Sardegna era rimasto
comunque il tramite per cui la famiglia poteva contare di appagare la sua
secolare aspirazione a una corona reale che, alla fin fine, fu anche il
risultato della loro costante “politica matrimoniale” e delle “alleanze
alternative”. Fu così che Vittorio Amedeo II realizzò quanto aveva intuito il
suo avo Amedeo VI nel XIV secolo, e cioè essere l’Italia il luogo ideale per
l’espansione e affermazione della casata. Per la verità, fin dal XV secolo i Savoia
erano re di Cipro e di Gerusalemme; ma si trattava di regni nominali, di nessun
valore giuridico e non di veri regni territoriali come il regno di Sardegna.
Il luogotenente di Vittorio Amedeo II, barone di Saint-Remy
Filippo Guglielmo Pallavicino divenne primo vicerè sabaudo il 2 settembre,
giurando, in lingua spagnola, agli stamenti parlamentari durante una solenne
cerimonia svoltasi nel duomo di Cagliari, di osservare, in ottemperanza degli
accordi internazionali, le leggi e i privilegi concessi dai precedenti governi.
Fu una grave remora che impedì per lungo tempo ai nuovi sovrani di operare
sostanziali riforme nel campo sociale ed economico.
Va comunque detto che i vicerè piemontesi non avevano simpatia per gli isolani, essi
consideravano il popolo sardo inferiore al proprio; il nuovo governo giunse
sino a proibire il matrimonio dei suoi ufficiali con donne sarde.
Il primo periodo dell’amministrazione piemontese fu
caratterizzato dal senso di precarietà del rapporto fra la dinastia e la Sardegna
dovuto alla loro propensione ad utilizzare l’isola come pedina di scambio per
ottenere territori nel nord Italia, ciò finì per tradursi in un profondo
disagio politico, economico e sociale che i sardi vissero malamente durante il
regno di Vittorio Amedeo II.
Sul piano della politica interna i Savoia dovevano governare
un paese di cultura e tradizioni molto vicine a quelle spagnole nel quale erano
parlate due lingue, lo spagnolo e il sardo. Inoltre le aspirazioni
autonomistiche che si erano manifestate nella seconda metà del XVII secolo, ma
che la classe politica isolana non aveva saputo concretizzare, erano latenti in
una società apparentemente apatica e frustrata. In questa situazione che
rendeva l’isola diversa da tutti gli altri domini che i Savoia governavano, si
aprì un processo di evoluzione politica, sociale e culturale che avrebbe dovuto
staccare la Sardegna dall’area di influenza della Spagna per inserirla nella
nuova realtà gravitante, per lingua e cultura, verso l’Italia. Tale processo
richiedeva chiarezza e profonde conoscenze reciproche, si creò invece una
situazione condizionata dalla scarsa conoscenza e dalla diffidenza, e
l’incomprensione tra sardi e piemontesi divenne una costante.
L’arrivo in Sardegna mostrò ai nuovi venuti quale fosse la
reale situazione dell’isola. Il paese apparve povero e spopolato, tutti i beni
demaniali erano da lungo tempo in completo abbandono e generalmente fatiscenti;
mancavano completamente le strade; i ponti erano pochi e malandati; l’industria
estrattiva, un tempo fiorente, era ridotta quasi al nulla; i porti avevano
bisogno di grandi lavori per renderli efficienti; le principali attività
commerciali erano totalmente in mano agli stranieri e soffocate dalla mancanza
della libera circolazione delle merci; l’allevamento e l’agricoltura erano
impediti dal sistema feudale e dall’arcaicità dei metodi di conduzione; infine
le università e le scuole erano letteralmente in rovina.
La nuova amministrazione ereditava una situazione
difficilmente gestibile, gli antichi ordinamenti rappresentavano un grosso
limite e la loro esistenza era oltretutto garantita dai trattati internazionali
che imponevano ai Savoia di non modificare le istituzioni del Regno.
L’azione iniziale del governo fu forzatamente piuttosto
debole e alcune volte contraddittoria in relazione ad alcuni problemi molto
delicati che tuttavia furono affrontati e in parte avviati a soluzione, come
per esempio quello riguardante i rapporti con la Chiesa.
Molti prelati romani consideravano ancora efficace il
principio della supremazia della Chiesa sulla Sardegna. La gerarchia
ecclesiastica era in buona parte filospagnola, godeva di molti privilegi
fiscali e giurisdizionali che utilizzava per indebolire l’autorità del vicerè e
la funzionalità dell’amministrazione reale. Il clero era molto numeroso e
pretendeva di mantenere i propri privilegi in materia di immunità, di diritto
di asilo, di giurisdizione. Delinquenti comuni invocavano l’immunità in luoghi
dove vigeva il diritto d’asilo, familiari di ecclesiastici invocavano
l’esenzione dai tribunali ordinari e così via. In simili circostanze, mente
l’amministrazione tentava di limitare questi privilegi, molti funzionari reali
furono considerati nemici della Chiesa e scomunicati per avere ostacolato i
privilegi. Questo quotidiano conflitto faceva maturare la consapevolezza della
necessità di riforme radicali in materia.
Altro fenomeno di vasta portata fu quello riguardante il
banditismo che tormentò intere zone dell’isola soprattutto nel nord e, in
particolare, in Gallura e in Anglona. Il fenomeno coinvolse intere popolazioni
e spesso fu interpretato come la forma di una volontà di ribellione alla nuova
situazione creatasi con il passaggio di dinastia, forse con qualche
implicazione politica.
I banditi generalmente vivevano alla macchia, organizzati in
bande, ed erano spalleggiati e protetti a livello locale da una rete di
connivenze, spesso vi erano coinvolti gli stessi feudatari, certamente le elites locali e la Chiesa, per cui quasi
sempre essi riuscivano a farla franca nei confronti della giustizia reale. I
primi provvedimenti per porre un freno alla situazione furono presi dal vicerè
Del Costanzo nel 1728.
Vittorio Amedeo II potè fare ben poca cosa nei confronti
dell’isola per affrancarla dalle gravi carenze e difficoltà in cui gli fu
assegnata giacchè lo stesso trattato di Londra gli imponeva – almeno in questa
fase iniziale – il mantenimento di tutti gli ordinamenti esistenti. Egli invece
fu, nei confronti del resto del suo regno, un solerte ed efficace riformatore
dell’amministrazione dello Stato e diede impulso agli studi, alle riforme
legislative, alle opere pubbliche e architettoniche per l’abbellimento di
Torino. Gli ultimi dieci anni di regno di Vittorio Amedeo II furono di
prosperità per lo stato sabaudo, per l’amministrazione del quale il re creò una
capace classe dirigente.
La fine del primo re sardo della casata dei Savoia fu
alquanto infelice. Nel 1730 abdicò in favore del figlio Carlo Emanuele III; ma
l’anno dopo pretese di risalire sul trono. Imprigionato, morì a sessantasei
anni fra moti d’ira e crisi depressive il 31 ottobre 1732 nel castello di
Rivoli.
CARLO
EMANUELE III DI SAVOIA (1701-1773)
18°
RE DI SARDEGNA DAL 1730 AL 1773
 Carlo
Emanuele III , piccolo di statura e gracile, successe al trono nel 1730
all’abdicazione del padre Vittorio Amedeo II nel 1730. Egli era appena salito
sul trono che fu coinvolto nella guerra di successione polacca e combattè al
fianco di Spagna e Francia contro Austria, Russia e Prussia. Grazie all’abilità
dei suoi comandanti occupò nel 1734 la Lombardia imperiale, mentre l’anno dopo
gli Alleati, col concorso di alcune compagnie sarde, cacciarono gli austriaci
anche da Palermo. Purtroppo, la pace di Vienna del 1738 ritolse al regno di
Sardegna la Lombardia, lasciandogli Novara e Tortona.
Carlo
Emanuele III , piccolo di statura e gracile, successe al trono nel 1730
all’abdicazione del padre Vittorio Amedeo II nel 1730. Egli era appena salito
sul trono che fu coinvolto nella guerra di successione polacca e combattè al
fianco di Spagna e Francia contro Austria, Russia e Prussia. Grazie all’abilità
dei suoi comandanti occupò nel 1734 la Lombardia imperiale, mentre l’anno dopo
gli Alleati, col concorso di alcune compagnie sarde, cacciarono gli austriaci
anche da Palermo. Purtroppo, la pace di Vienna del 1738 ritolse al regno di
Sardegna la Lombardia, lasciandogli Novara e Tortona.
Non trascorsero due anni che scoppiò la
guerra di successione austriaca fra il pretendente Carlo duca di Baviera,
assistito da Francia, Spagna e Prussia, e Maria Teresa, figlia del defunto
imperatore Carlo VI. Carlo Emanuele III prima alleato col pretendente, si
schierò poi con Maria Teresa subendo le rappresaglie franco-spagnole che
giunsero a minacciare pure l’isola. Allora, nel 1744, fu costituito, su
proposta dell’aristocrazia del Regno, il glorioso Reggimento di Sardegna che fu
affidato al comando del duca di San Pietro. Nella susseguente pace di
Aquisgrana del 1748, che riconosceva Maria Teresa imperatrice d’Austria, il
compenso a Carlo Emanuele III per il suo sacrificio fu minimo avendo ottenuto
solo Vigevano e Voghera.
Negli anni di pace che seguirono tutti
gli sforzi dell’amministrazione furono indirizzati verso le riforme strutturali
dello Stato riguardanti soprattutto la Sardegna, per la quale venne
definitivamente meno la probabilità di una sua cessione in cambio di altra
terra, anche se i Savoia non avevano deposto l’idea di utilizzarla come pedina
di scambio. Il periodo fu caratterizzato dal diffondersi delle idee facenti
capo all’illuminismo. Il bisogno di riformare le strutture dello Stato era già
stato sentito da Vittorio Amedeo II ma fu con Carlo Emanuele III, sulla base
anche di profondi mutamenti sociali che questa esigenza si fece più sentita.
Frattanto
in Sardegna, mentre andava attenuandosi il problema dei rapporti con la Chiesa,
persisteva il grave fenomeno del banditismo soprattutto in Gallura e in
Anglona. Spesso la sua origine era da individuare in rivalità tra famiglie, o
all’interno della stessa famiglia. Tra le molte di esse che animarono le
cronache di quei tempi è esemplare la funzione avuta dai Delitala a Nulvi. Essi
erano una nobile famiglia, ricca e potente, in seno alla quale agli inizi del
XVIII secolo si erano formate due fazioni che avevamo scaricato le loro
tensioni interne in un vero e proprio conflitto coinvolgendo la popolazione del
villaggio. Tra i personaggi che animarono il banditismo di questo periodo
figurano i soggetti più disparati, come la romantica figura di donna Lucia
Delitala, idealizzata dal Manno. Essa era descritta non come una donna
quarantenne ma una virago di modi terribili e dalle abitudini mascoline, aveva
i baffi come un granatiere e si serviva delle armi e del cavallo sempre come un
granatiere. Altra famiglia implicata nel banditismo fu quella di Valentino di
San Martino, antichi partigiani degli Asburgo. A Sassari operò la banda di
Pietro Mele che arrivò a uccidere pubblicamente in piena città.
Il vicerè marchese di Rivarolo diede
notevole impulso alla repressione del fenomeno. Egli prese di mira il
banditismo in Anglona, che aveva come epicentro Nulvi dove vivevano i Delitala.
Occupò militarmente l’Anglona ponendo un presidio di cavalleggeri a Nulvi e, in
seguito, ne mise uno anche a Ozieri facendo battere la campagna da compagnie di
dragoni. In meno di due anni, adottando una spietata politica di repressione riportò,
almeno apparentemente, la sicurezza nei villaggi. Si dice che il marchese
girasse portandosi dietro il giudice e il boia. Nell’esecuzione delle pene
capitali metteva in scena un apparato terribile e generalmente la testa del
condannato veniva mandata al paese di origine per esservi appesa. Il numero
delle esecuzioni era così elevato che il patibolo di Sassari veniva chiamato
“lu palazzu de Rivarolo”. Nel triennio del suo mandato (1735-38) si calcolano
in circa tremila i sardi che impiccò, incarcerò ed esiliò. In aperta lotta con
le tradizioni ispaniche, che il popolo seguiva e avrebbe seguito per molto
tempo, vietò il vestire alla spagnola e comandò di distruggere i balconi
spagnoli.
Il
vicerè Rivarolo fu anche il primo ad
occuparsi concretamente del problema del ripopolamento dell’isola. Egli infatti
segnalò ripetutamente al governo lo spopolamento di vaste regioni come una
delle cause della povertà e degli squilibri dell’isola. Furono così elaborati i
primi progetti di ripopolamento ricorrendo non ai sardi ma a coloni forestieri
capaci di portare esperienze di lavoro più evolute che sarebbero servite per il
miglioramento dell’intero assetto della società sarda.
Nel
1736 avviò così le trattative per convincere gli abitanti di Tabarca a
trasferirsi in Sardegna; i tabarchini vivevano infatti in condizioni precarie,
oggetto delle continue vessazioni del Bey di Tunisi. Le trattative si
conclusero nel 1738 con il concorso di Bernardino Genovès duca di San Pietro.
L’insediamento dei tabarchini permise la fondazione di Carloforte e poco dopo
la colonia si accrebbe per l’arrivo dei pugliesi capeggiati da Giovanni
Battista Segni (antenato di Antonio che fu Presidente della Repubblica).
Carloforte è una cittadina posta sull’isola di San Pietro. Già antica colonia
fenicia essa andò spopolandosi nel medioevo divenendo facile approdo per i
corsari saraceni. Gli abitanti di Carloforte parlano ancora oggi il dialetto
della loro stirpe di origine genovese.
La
presenza della nuova colonia contribuì a ridare vitalità allo sfruttamento
delle miniere dell’iglesiente; le barche dei carlofortini infatti, prendevano
il minerale dalla rada di Buggerru e lo trasportavano nell’isola di San Pietro
dove veniva caricato su navi di grosso tonnellaggio.
Oltre
alla soluzione di questi problemi, l’amministrazione avviò una politica tesa a
ridimensionare l’eredità spagnola. Lo sforzo maggiore fu compiuto per favorire
l’introduzione della lingua italiana per la quale si ebbe un lungo braccio di
ferro fra l’amministrazione piemontese e le classi dominanti sarde che
parlavano e scrivevano in spagnolo, lingua che volevano conservare. Il sistema
scolastico era poco diffuso nel territorio ed era completamente controllato
dalla Chiesa secolare per l’istruzione elementare, e dai gesuiti e gli scolopi
per l’istruzione superiore. Non bisogna dimenticare che l’accesso agli studi
era riservato a pochi privilegiati che potevano permettersi di sostenere le
spese per frequentare le scuole. Nonostante gli sforzi compiuti, ancora alla
fine del XVIII secolo, lo spagnolo era parlato e scritto correntemente in molte
città e centri dell’isola.
Fu
sviluppata la raccolta e il commercio del sale. Furono stipulati accordi
commerciali con la Svezia che, nel 1744, aprì un consolato a Cagliari.
Nonostante
questi interventi, la situazione generale dell'isola rimase difficile. Un
gruppo di nobili sardi contrari al governo piemontese e soprattutto coloro che
avevano provocato il banditismo ai tempi del Rivarolo, si rifugiarono in
Corsica da dove fomentarono episodi di vera e propria guerriglia, come
l’assalto di un migliaio di soldati ad Aggius nel 1746. Per paura di una forte
reazione del governo, essi cercarono protezione all’estero, i fuoriusciti
andarono a Nizza e proposero di cedere l’isola alla Francia dicendo di essere
pronti a fare insorgere la Gallura e a favorire l’occupazione di tutta l’isola.
L’offerta rimase lettera morta.
La
più decisa azione riformatrice fu intrapresa quando, il 12 settembre del 1759,
il conte Giambattista Lorenzo Bogino fu nominato reggente della segreteria di
Stato per gli affari della Sardegna. Il Bogino nell’attuare le sue riforme non
seguì alcun progetto e programma precostituito, i suoi interventi furono
piuttosto episodici e frammentari, dettati dalla necessità di porre rimedio a situazioni
contingenti che minacciavano di vanificare l’azione del governo nell’isola.
Egli, tuttavia, si impegnò con energia e dinamismo introducendo uno stile di
azione severo, oculato e rigoroso. Le riforme interessarono diversi settori
della vita civile ma non riuscirono a incidere sull’assetto fondamentale
dell’isola e, in particolare, non portarono all’abolizione del feudalesimo.
Nei
suoi interventi il Bogino si preoccupò soprattutto di salvaguardare gli
interessi dello Stato che il benessere dei cittadini. Così le riforme da lui
volute, oltre che non incidere sul feudalesimo, finirono per non interessare il
settore delle opere pubbliche, del commercio e dell’imprenditoria, settori,
cioè, dove le riforme avrebbero potuto incidere maggiormente per migliorare le
condizioni di vita della Sardegna e colmare il ritardo e il divario dell’isola
nei confronti dei territori di terraferma.
Le
riforme principali interessarono l’agricoltura, il riordino delle
amministrazioni locali, della giurisdizione, degli uffici amministrativi e
della pubblica istruzione. Volle interventi mirati a far passare la
cereagricoltura da uno stato di dipendenza da situazioni contingenti di natura
climatica, per esempio, a una situazione di stabilità che liberasse le
popolazioni dalla fame e dalla precarietà. Nel 1767 si ottennero i primi
effetti benefici con l’attuazione dei “monti frumentari” in ogni centro
abitato, avente il compito di costituire adeguate riserve di cereali per
sottrarre i contadini alle conseguenze delle calamità naturali e della carestia
e di fornire semenze a prezzo modico.
Si
preoccupò inoltre di riorganizzare gli ospedali emanando il regolamento del
1763 relativo agli ospedali di Cagliari, esteso a tutta l’isola entro il 1768.
Il
Bogino rilanciò l’attività mineraria promuovendo oltre che lo sfruttamento la
ricerca di nuovi minerali. L’attività di ricerca diede buoni frutti e nel 1764
fu fatta la scoperta dell’antimonio a Ballao dove il prodotto fu estratto ed
esportato; fu scoperto l’allume di rocca a Segariu, il ferro ad Arzana e, nel
1765, il diaspro.
Dopo
il concordato del 1726 i rapporti con la Chiesa erano migliorati, ma le cause
di frizione erano ancora presenti. Le decime ancora riscosse e la giurisdizione
ecclesiastica erano due spine nel fianco dell’amministrazione e mal si
conciliavano con le idee di riformismo del governo. Le esenzioni di cui godeva
facevano del clero il ceto più ricco della Sardegna le cui rendite complessive
erano più del doppio delle rendite del governo e delle città.
Il
Bogino si preoccupò anche di disciplinare le attività giudiziarie. Pur con
limiti derivanti dall’esistenza delle giurisdizioni baronali ed ecclesiastiche
per il momento intoccabili, con atto del 1759 si procedette a razionalizzare la
procedura penale e le norme per l’abilitazione dei giudici a svolgere la loro
funzione solo per quanto riguarda i tribunali reali. In seguito, nel 1770,
pressato dalla ripresa dei commerci con la terraferma, il Bogino costituì i
tribunali di consolato a Cagliari e a Sassari per la trattazione delle cause
mercantili e marittime. Fu anche possibile procedere alla riorganizzazione degli uffici giudiziari.
Anche in altri settori l’attività
riformatrice del Bogino lasciò la sua traccia profonda e così, nel 1763, fu
posta in atto la riorganizzazione dell’Archivio di Stato a Cagliari. Nel 1768
fu riformato anche il sistema monetario, con apposite regole fu disciplinato il
sistema della circolazione delle monete.
Nel
1767 fu organizzato il servizio postale interno con la istituzione di corrieri a
cavallo fra Cagliari e Sassari, con tappe intermedie a San Gavino, Oristano,
Bosa e Alghero. Una speciale compagnia si occupava di questo collegamento che
avveniva nelle due direttrici e collegava le due città in quarantuno ore. Il
percorso veniva completato settimanalmente fra il venerdì e la domenica sera,
quando il corriere giungeva a Porto Torres da dove la corrispondenza per la
terraferma partiva per Livorno. Il 19 settembre 1772 fu attivato il servizio
postale regio a livello nazionale.
La
riorganizzazione delle Università – fondate da Filippo III nel 1617 – fu un
altro importante obiettivo centrato dal Bogino. La riforma ebbe inizio nel 1759
quando fu istituita a Cagliari una
scuola di chirurgia affidata al chirurgo piemontese Plazza. Il processo di
rinnovamento condusse alla costituzione di una commissione per studiare le
riforme dei due atenei sardi, prendendo come modello Torino. Con un diploma
reale del 1764, fu rifondata l’Università di Cagliari e nel 1765 quella di
Sassari; le due Università divennero istituzioni scolastiche governative ed
entrambi gli atenei ebbero così un corpo docente di buon livello culturale. Il
rinnovamento fu però solo strutturale, le due università non raccolsero impulsi
culturali innovativi, né li trasmisero. L’unico illuminista chiamato a operare
in Sardegna fu Giambattista Vasco. Non si può dimenticare però la costituzione
della Biblioteca Universitaria di Cagliari tramite libri acquistati per i
professori, doni del re e di qualche privato. La biblioteca si accrebbe anche
di tutte le pubblicazioni della stamperia reale di Torino.
Oltre
che alle università, il Bogino pensò anche agli altri livelli di istruzione;
così nel 1760 fu predisposto un piano di studi per il riordino dell’istruzione
inferiore che riprendeva le linee precedenti. Si trattò, anche qui, di una
riforma di struttura perché i metodi di insegnamento rimasero quelli di prima e
le scuole non crebbero di numero né di qualità. Anche le scuole secondarie
(dette di latinità) fecero scarsi progressi e rimasero in mano a gesuiti e
scolopi.
Altro
importante campo di intervento dell’attività del Bogino fu quello delle
amminstrazioni locali. Con un editto del 1771 si procedette al riordino
dell’amministrazione di città e villaggi che consentì di eliminare le antiche
istituzioni di origine catalana e divenne garanzia nei confronti delle
prepotenze del feudatario. Questo fu l’ultimo grande intervento voluto dal
ministro Bogino che, dopo la morte di Carlo Emanuele III fu licenziato dal
nuovo sovrano e messo a riposo. Non bisogna però dimenticare che le riforme del
Bogino tendevano fondamentalmente a cancellare tutto ciò che spontaneamente
persisteva del periodo spagnolo: Castellaragonese diventa Castelsardo (1767);
cambierà lo stemma di Cagliari che durante mezzo secolo savoiano aveva
mantenuto, acquartierati, i pali d’Aragona, con la croce dei Savoia. Il Bogino
che fu, senza dubbio, il migliore ministro sabaudo, fu il primo a pensare che
l’isola non doveva raggiungere un alto grado di civiltà per non attrarre su di
essa le mire di altri stati stranieri.
Nel
periodo sin qui esaminato, scarsa o quasi nulla fu la diffusione delle idee
dell’illuminismo nelle scuole e nelle università. Ciò non esclude che a livello
personale alcuni intellettuali sardi conoscessero a fondo tali idee, anzi.
Molti furono gli autori che scrissero libri che trattarono problemi legati a
varie tematiche (agronomia, botanica, medicina, storia, ecc.). Animatore della
vita culturale di quel periodo fu il Cossu, membro di diverse accademie. Ci fu
una grande diffusione di nozioni di agricoltura curata da sacerdoti e uomini di
cultura che culminò con la fondazione a Cagliari di una Accademia Agraria.
Altri centri di cultura divennero i seminari che incrementarono il loro
patrimonio librario con i lasciti dei vescovi alle loro diocesi. Così a
Cagliari finì buona parte dei libri di monsignore Del Carretto, prelato
illuminato che aveva invitato gli ecclesiastici a dotarsi di libri non solo di
teologia. Fiorirono le tipografie a Cagliari e a Sassari, e in quell’epoca si
ebbero i primi giornali.
Nel
1767 il regno sardo si era annesso le “isole intermedie” delle Bocche di
Bonifacio: Caprera, La Maddalena, Spargi, Budelli, ecc. (che fanno corona alla
Costa Smeralda); due anni dopo, nel 1769, il ducato di Genova cedette la
Corsica alla Francia.
Negli
ultimi anni del suo regno, Carlo Emanuele III aveva manifestato la sua
opposizione alle intenzioni della Santa Sede di sopprimere la Compagnia di Gesù
(Gesuiti) che in Sardegna controllava l’istruzione superiore e disponeva del
feudo di Musei, dell’azienda di Domus De Maria, oltre che di numerosi conventi.
Questa sua avversione si concretizzò ospitando nell’isola numerosi esuli
provenienti da diverse parti d’Europa.
Durante
quasi tutto il settecento piemontese la Sardegna ricadde in uno stato di
prostrazione dell’inventiva per la mancanza di adeguamento tra una tradizione
linguistica e culturale, che faticosamente sopravvive, e le direttrici del
nuovo governo che presuppongono una diversa condizione ideologica. “Fa riscontro la scarsissima produzione
letteraria, storica e scientifica nel primo cinquantennio del dominio sabaudo,
di gran lunga inferiore a quella del secolo XVIII, cioè nell’ultimo secolo di
governo spagnolo ”, ebbe a dire F. Loddo Canepa ne “La Sardegna dal 1720 al
1848”.
Il
re Carlo Emanuele III compì, nei suoi quarantatrè anni di regno, l’unità
legislativa, politica, istituzionale degli Stati sardi. Alla sua morte,
avvenuta nel 1773, gli succedette il figlio Vittorio Amedeo III.
VITTORIO AMEDEO III DI SAVOIA (1726-1796)
19°
RE DI SARDEGNA DAL 1773 AL 1796
 Vittorio
Amedeo III succedette nel febbraio del 1793 e immediatamente sollevò dal loro
incarico i ministri fra i quali il conte Bogino accusato da alcuni ambienti di
corte di avere subornato la volontà di suo padre re Carlo Emanuele III.
Vittorio
Amedeo III succedette nel febbraio del 1793 e immediatamente sollevò dal loro
incarico i ministri fra i quali il conte Bogino accusato da alcuni ambienti di
corte di avere subornato la volontà di suo padre re Carlo Emanuele III.
Vittorio Amedeo III era sposato ad una
infante spagnola, Maria Antonia Fernanda dei Borbone di Spagna, figlia di
Filippo V e di Isabella Farnese, che diede al re dodici figli, dei quali
regnarono progressivamente Carlo Emanuele IV (1796), Vittorio Emanuele I (1802)
e Carlo Felice (1821). Nell’ingresso del Santuario di Bonaria vi è una lapide
commemorativa che ricorda la regina Maria Antonia Fernanda deceduta il 23
novembre 1785.
Il
nuovo re aveva un temperamento diverso da quello di suo padre. Era poco
interessato a una politica mediterranea e maggiormente propenso a riprendere la
politica continentale dei suoi predecessori. La prodigalità eccessiva e la vita
di corte volutamente splendida porteranno sull’orlo della rovina le finanze
sabaude, assorbite in gran parte dalle spese militari.
In
Sardegna il processo delle piccole innovazioni marginali non fu tuttavia
interrotto soprattutto a opera di alcuni vicerè. Così fu ulteriormente
incrementato lo sviluppo delle università e fu introdotta la facoltà di
matematica in aggiunta alle quattro già esistenti dal 1765 e cioè: teologia,
giurisprudenza, medicina e filosofia.
Con
la costituzione della giunta dei ponti e delle strade e lo stanziamento di
15.000 scudi, fu avviata una timida politica di interventi nel campo delle
opere pubbliche. Continuarono anche gli interventi di colonizzazione: il
visconte Asquer fondò Gonnesa nel 1774 e in Gallura, dagli stazzi, si formarono
altri centri. Fu rafforzata la flotta per difendere le coste dagli attacchi dei
pirati barbareschi.
Nel
1773, per volere di Clemente XIV, fu soppressa la Compagnia di Gesù, in
conseguenza del moto che contro l’ordine si era sollevato in tutta l’Europa. La
presenza dei gesuiti, infatti, era considerata dai sovrani europei un ostacolo
al pieno esercizio della sovranità e Vittorio Amedeo III dovette adeguarsi alla
situazione. I loro beni nell’isola, e cioè i conventi, il feudo di Musei e
l’azienda di Domusdemaria, furono incamerati dal fisco; conservarono però i
loro insegnanti superiori anche perché l’università ne aveva bisogno.
La
politica dei Savoia riprese comunque il suo carattere di indecisione nei
confronti della Sardegna, così che si registra una ripresa delle concessioni ai
feudatari e un regresso nei rapporti con la Chiesa. Furono inoltre inviati
nell’isola funzionari piemontesi poco preparati e spesso poco onesti, il che
fece esplodere il vecchio contrasto tra sardi e forestieri, anche perché era
difficile accettare il fatto che valorosi giovani laureati isolani non
potessero essere impegnati a ricoprire gli stessi uffici.
Il
malcontento cominciò a serpeggiare fra la popolazione. Ma il fatto più grave
che caratterizzò il crescente malumore nell’isola fu la sollevazione di Sassari
del 1780, a causa del cattivo raccolto del 1779. Questa carenza di grano favorì
l’opera degli speculatori come il governatore Alli Maccarani, persona altezzosa
che non godeva grande credito presso la popolazione. Egli era impegnato nella
speculazione facendo incetta di grano dal continente e interrompendo, così, il
libero commercio del frumento. Cercò poi di intervenire nella fabbricazione
della “panatica” (il pane di città) introducendo ad un prezzo maggiore il suo
grano che era anche avariato. Il prezzo del grano salì alle stelle e il 23
aprile 1780 la popolazione si ribellò, assalì la frumentaria e la saccheggiò,
la stessa sorte toccò al palazzo civico e ad altri uffici pubblici. Furono
saccheggiate le case di alcuni speculatori e il vescovo sfuggì alla violenza
lanciando alla folla pane e monete. Il giorno successivo l’aristocrazia
sassarese fece gratuite distribuzioni e il governatore Maccarani fu rimosso per
volontà del re.
Fra
le riforme proseguite da Vittorio Amedeo III, c’è da segnalare la riapertura –
10 aprile 1793 – della zecca di Cagliari che non batteva più moneta dal 1717,
cioè dal periodo di Carlo VI imperatore. Forse è opportuno ricordare che i
Savoia furono costretti, perché obbligati dai trattati di Londra e dell’Aia,
rispettivamente del 1718 e 1720, a mantenere immutato il sistema monetario
sardo instaurato quattro secoli prima da Giacomo II d’Aragona, primo re di
Sardegna. Nel regno si ha quindi una doppia monetazione espressa dalla lira
sarda e dalla lira piemontese che obbliga, tra territori di uno stesso stato
(isola e terraferma), ad un cambio della moneta quasi si trattasse di due stati
differenti.
A
partire dal maggio 1789 si apre il periodo della rivoluzione francese destinato
a segnare profondamente la storia d’Europa e della Sardegna. Il 14 luglio 1789,
con la presa della Bastiglia scoppiò in Francia la rivoluzione. Dall’ottobre
1791 le idee rivoluzionarie ebbero un’eco sempre maggiore in tutta l’Europa e
così le potenze europee si coalizzarono perché temevano che la Francia potesse
diventare un pericolo per tutti.
Quando
il 7 febbraio 1792 si strinse un’alleanza fra Austria e Prussia contro la
Francia la situazione precipitò fino a sfociare in guerra aperta il 20 aprile.
Vittorio Amedeo III, in base alle proprie convinzioni, si alleò con l’Austria dal
luglio successivo. In realtà la Francia, per scongiurare questa sua alleanza,
aveva proposto a Vittorio Amedeo di cedergli la Lombardia se si fosse alleato
con lei. Il Savoia scelse però l’Austria e questa fu una mossa politica
completamente sbagliata, infatti la situazione politica francese andò
radicalizzandosi e il 10 agosto, dopo l’assalto alle Tuileries, il re di
Francia fu sospeso e imprigionato. Il 21 settembre 1792 la monarchia fu abolita
e fu proclamata la repubblica.
La
guerra volse a favore dei francesi, le truppe continuavano la loro avanzata e
mentre a Parigi si preparava il “governo del terrore” i rivoluzionari invasero
Nizza e la Savoia, che vennero successivamente riconosciute definitivamente
alla Francia con la pace di Parigi del 1796.
Sul
fronte italiano l’esercito austro-piemontese andò dissolvendosi e la
conservazione del Piemonte ai Savoia sembrò molto difficile. In questo clima di
esaltazione rivoluzionaria fu aperto il processo contro Luigi XVI. Dichiarato
colpevole fu condannato a morte il 15 gennaio 1793 e il 21 gennaio il re venne
decapitato. La guerra si estese a livello europeo coinvolgendo l’Inghilterra,
l’Olanda e la Spagna.
Questi
avvenimenti fecero rinascere prepotente nella classe colta e nel popolo sardo
la coscienza dell’autonomia. Fu molto apprezzata la “Storia” scritta dal Gazano
nel 1775, e la diffusione di quella del Fara, che circolava manoscritta, essa
portò a conoscenza di un passato dell’isola tanto illustre da far crescere, in
maniera incontenibile, il disprezzo per i piemontesi. Nello stesso periodo
sempre più decisa aumentava l’avversione nei confronti del sistema feudale,
ormai considerato da tutti come il principale ostacolo per la rinascita della
Sardegna.
Possiamo
prendere come punto di riferimento il 1790, quando fu nominato vicerè di
Sardegna Vincenzo Balbiano, un personaggio ambiguo e inetto che entrò in
contrasto con il ministro Graneri. Il Balbiano conosceva bene la situazione
della Sardegna, infatti era stato governatore di Sassari subito dopo l’allontanamento
del Maccarani. Egli aveva intuito e segnalato al re le ragioni del malcontento
proponendo che una parte degli uffici venisse assegnata ai sardi, che fossero
rimossi i giovani continentali dalla condotta riprovevole e che venisse
migliorata l’amministrazione della giustizia. In effetti, però, il Balbiano
come del resto buona parte dei funzionari piemontesi, non aveva compreso la
portata del malcontento che trovava il suo fondamento nella ritrovata coscienza
nazionale.
Sull’onda
dei successi i rivoluzionari rivolsero le loro attenzioni all’isola
sonnacchiosa e inerte, ben convinti della “felice posizione della Sardegna nel
Mediterraneo” e della facilità dell’impresa, data la debolezza militare delle
guarnigioni piemontesi nell’isola.
La
notizia dell’invasione del Piemonte giunse in Sardegna in ottobre e gettò
l’opinione pubblica nello sconforto. Di fronte al pericolo, su iniziativa
dell’aristocrazia sarda, vista l’inettitudine del vicerè, fu convocato lo
stamento militare. Fu questo un fatto eccezionale, visto che nei precedenti
settant’anni i piemontesi non avevano mai consentito riunioni stamentarie. Da
più parti fu avviato l’arruolamento di miliziani a cavallo e a piedi, armati
sommariamente ma sorretti dall’entusiasmo e da una ritrovata coscienza
nazionale.
Non
passò molto che la flotta francese salpò da Tolone in dicembre e il 29 dello
stesso mese del 1792 sette navi entrarono nella rada di Cagliari ma furono
respinti dai cannoni di Sant’Elia. L’8 gennaio 1793 i francesi senza colpo
ferire presero Carloforte, nell’isoletta di San Pietro, ribattezzata “l’isola
della libertà”. Il 27 e il 28 gennaio la flotta francese schierata in battaglia
cominciò a cannoneggiare Cagliari provocando molti danni; anche le artiglierie
della difesa, però, colpirono ripetutamente le navi. Sebbene disturbata dal
cattivo tempo che fece naufragare il “Leopard”, vascello da 84 cannoni, la
flotta, riorganizzatasi, il 14 febbraio, dopo un massiccio bombardamento, fece
sbarcare a Margine Rosso, nel litorale di Quartu Sant’Elena, 4.000 uomini ben
armati ed equipaggiati che si avviarono verso Cagliari passando all’interno
della zona paludosa di Molentargius. Lungo questi tormentati percorsi erano
state però schierate le fanterie miliziane che ben appostate opposero una forte
resistenza che fece indietreggiare i francesi. Ben presto la ritirata si
trasformò in fuga scomposta che permise alla cavalleria miliziana di fare una
strage di quel che era rimasto del corpo di spedizione. I superstiti furono
reimbarcati il 19 febbraio e la flotta lasciò definitivamente il Golfo di
Cagliari il 26 febbraio. A San Pietro e Sant’Antioco restava un presidio
francese di 700 soldati.
Contemporaneamente
in un altro teatro di guerra un secondo corpo di spedizione francese tentò un
nuovo sbarco. Le truppe stavolta provenivano dalla Corsica e fra loro vi era
anche un giovane e brillante ufficiale di carriera, il tenente colonnello di
artiglieria Napoleone Bonaparte il quale, passato da Bonifacio all’isolotto
gallurese di Santo Stefano, bombardava La Maddalena. L’impresa, che si
proponeva di prendere la guarnigione per poi trasferirsi a Palau e occupare la
Sardegna settentrionale, fallì miseramente il 26 febbraio, per la resistenza
opposta dai sardi guidati da Giacomo Manca di Thiesi e da Domenico Millelire.
Le notizie della vittoriosa resistenza dei sardi giunsero a Torino in un
difficile momento, ma rincuorarono gli ambienti di corte e stupirono l’Europa.
Il 25 maggio dello stesso 1793, attaccata da navi alleate spagnole, s’arrese
anche la repubblica di San Pietro, effimera “isola della libertà”.
Subito
sperando nella ricompensa del sovrano per la fedeltà al trono, su iniziativa
del canonico Sisternes, il 29 aprile 1793 una delegazione formata da sei
rappresentanti degli stamenti sardi si recò a Torino per fare al re alcune
richieste che erano state elaborate dopo animate discussioni. Il documento nel
quale le richieste erano contenute è noto come “le cinque domande”. In
particolare si richiedevano: la convocazione degli stamenti secondo il vecchio
ritmo decennale; il ripristino degli antichi privilegi; di riservare
esclusivamente a persone indigene tutti gli impieghi civili e militari, tranne
i più alti; di creare a Torino uno speciale ministero per le questioni
dell’isola; di istituire a Cagliari un Consiglio di Stato per il controllo di
legittimità anche nei confronti dell’operato del vicerè. I delegati, arrivati a
Torino, non riuscirono a farsi ricevere dal re se non dopo tre mesi, senza però
ottenere da lui una risposta.
Il
governo assunse un atteggiamento dilatorio, i delegati stamentari furono
mantenuti in una posizione di attesa, nessuno dava loro risposta o li prendeva
sul serio, in primo luogo il ministro Graneri da cui dipendevano gli affari
della Sardegna. Nell’isola, intanto, il malessere generale aumentava,
alimentato dall’incomprensione dei piemontesi. Il 6 maggio 1793 si ebbe una
sollevazione popolare a Sassari per la mancanza di pane, in luglio a Uri e Ossi
contro il feudatario, e nei mesi successivi altre sollevazioni si verificarono
in centri limitrofi.
Il
vicerè, impaurito, adottò una politica di repressione e il 4 settembre, mentre
i delegati aspettavano pazientemente a Torino, il Balbiano ottenne un biglietto
reale per lo scioglimento degli stamenti. Fu questa una grave provocazione, ma
gli stamenti continuarono a riunirsi. Agli inizi del 1794 il re tornò a Torino
e il primo aprile diede la risposta alle “cinque domande” presentategli a suo
tempo. Questa pervenne al vicerè senza che i delegati stamentari ne sapessero
nulla. Allora la tensione popolare giunse al culmine, in città e nell’isola
crebbe la volontà di rivolta. Così, temendo una sollevazione popolare, il 28
aprile, a Cagliari il Balbiano fece presidiare la città e arrestare i
personaggi più eminenti. Fu la scintilla che esasperò ulteriormente gli animi
dei nobili e del popolo cagliaritano e che provocò l’insurrezione che il vicerè
non fu in grado di fronteggiare.
Lo
stesso 28 aprile 1794 i rivoltosi catturarono tutti i cinquecentoquattordici
funzionari piemontesi, compreso il vicerè e, accompagnatili al porto li
imbarcarono su una nave. Il 7 maggio successivo essi furono costretti a
lasciare l’isola mentre le funzioni di governo furono esercitate dalla Reale
Udienza, le cui riunioni erano seguite sempre da un pubblico numeroso e
interessato. La notizia della sollevazione di Cagliari giungeva a Torino
inaspettata perché “non si era mai
creduto che l’agitazione degli animi dovesse crescere a tanto irritamento
”. Il re rispose con gravi parole: “essere
stato il suo cuore profondamente addolorato al conoscere che un popolo,
mostrandosi nell’animo così fedele, fosse trascorso ad eccessi che così
palesemente offendevano l’autorità sovrana ”. Incuranti del dolore arrecato
al re Vittorio Amedeo III, l’esempio rivoluzionario fu presto seguito dalle
altre città sarde. Per celebrare tale ricorrenza, con legge regionale del 14
settembre 1993 n. 44, questa giornata (28 aprile) è stata proclamata festa
regionale e denominata “SA DIE DE SA SARDIGNA”.
Nel
periodo successivo, in attesa che fosse ripristinata la legalità
costituzionale, le funzioni di governo continuarono ad essere esercitate dalla
Reale Udienza. Fu costituito un comitato permanente composto da due
rappresentanti di ciascun stamento e da un giudice della Reale Udienza. A capo
del nuovo organismo fu posto Giovanni Maria Angioy.
L’11
giugno il Graneri, considerato uno dei responsabili della situazione, fu
sostituito alla guida degli affari della Sardegna da Pietro Avogrado. Il nuovo
responsabile convinto della necessità di una politica di riconciliazione operò
perché il contenuto delle “cinque domande” fosse accettato dal re. L’impegno fu
premiato: gran parte di esse furono accettate con un biglietto reale del 22
luglio 1794 con il quale le riunioni stamentarie furono autorizzate e furono
avviate a soluzione le altre richieste. Fu anche nominato il nuovo vicerè,
marchese Filippo Vivalda di Castillino, che partito da Livorno il 31 agosto
1794 giunse a Cagliari il 6 settembre unitamente a Gavino Poliaccio marchese di
Planargia, nuovo capitano delle armi. Particolare era la posizione di
quest’ultimo, fautore di una restaurazione antiliberale e antiborghese e legato
agli ambienti dei feudatari sassaresi. Dopo l’arrivo a Cagliari del nuovo
vicerè la situazione non si modificò e la furia popolare non si placò.
Iniziò
quindi per il nuovo vicerè la fase delicata della vicenda, cioè quella di
pacificare gli animi e salvaguardare gli interessi della monarchia. Ormai,
però, la scena politica sarda era lacerata dal grave contrasto fra i due
partiti che facevano capo all’Angioy e al Pitzolo. Il programma politico del
partito dei “novatori” guidato da Giovanni Maria Angioy si prefiggeva di
limitare le prerogative del vicerè al quale riconosceva una funzione puramente
istituzionale. Mentre gli uomini del partito del Pitzolo, i “moderati”, erano
propensi a mantenersi nei limiti delle richieste delle “cinque domande” e
rispettosi delle prerogative del vicerè. La situazione divenne pesante nel
corso del 1795 durante il quale si verificarono sanguinose sommosse che
interessarono tutta l’isola. Per tutto il mese di giugno crebbe la temperatura
e il capitano delle armi Gavino Poliaccio marchese della Planargia adottò
misure repressive; si dice che addirittura volesse fare arrestare l’Angioy. Il
vicerè, pressato dagli stamenti, chiese al Planargia di recedere dai suoi
atteggiamenti, ma sia lui che il Pitzolo non gli ubbidirono per cui il 6 luglio
fu chiesta dagli stamenti la loro sostituzione. Poiché il vicerè temporeggiava,
nello stesso giorno scoppiò la sommossa e Gerolamo Pitzolo fu trucidato in
piazza dalla folla inferocita. Ma gli animi non si placarono e il 22 luglio fu
assassinato in carcere anche il marchese Gavino Poliaccio della Planargia.
In
questo clima i lavori stamentari continuarono e si focalizzarono sulla
possibilità di abolire il sistema feudale e riaffermare la concordia del Regno.
Con sempre maggiore frequenza si manifestarono sollevazioni popolari contro i
baroni. La nobiltà sassarese e i feudatari logudoresi, temendo per i feudi e
per i loro privilegi, pensarono di staccare il capo di Sassari da quello di
Cagliari e una loro proposta in tal senso, inviata a Torino, non fu accettata
dal re. L’idea della possibile frattura fra Cagliari e Sassari preoccupò il
vicerè Vivalda che, d’altra parte, sembrava favorevole all’abolizione dei
feudi.
Nel
sassarese la situazione diventò esplosiva, petizioni e proteste contro la
feudalità si verificarono in tutto il nord dell’isola e fu ancora rivolta
generale. Il 28 dicembre del 1795 schiere
di insorti provenienti da tutto il logudoro raggiunsero le vicinanze di
Sassari e la assediarono con l’intenzione di entrarvi e bruciare le case dei
feudatari. Nel frattempo tutti i feudatari di Sassari e alcuni rappresentanti
del governo erano fuggiti dalla città. Il 29 anche la popolazione di Sassari si
sollevò e costrinse le autorità ad aprire le porte consentendo agli assedianti
di entrare. I rivoltosi occuparono la città facendo prigionieri il governatore
e l’arcivescovo che furono allontanati e il 31 inviati a Cagliari sotto scorta.
Così
per porre fine alla situazione, dopo delibera degli stamenti del 2 febbraio
1796, il vicerè Filippo Vivalda, il 13 febbraio, inviò a Sassari il giudice
della Reale Udienza Giommaria Angioy con poteri di “alter nos”, accolto dalle
popolazioni come un liberatore. Per circa tre mesi l’Angioy cercò di risolvere
il rapporto fra feudatari e vassalli attraverso atti legali e, concretamente,
pose le basi per l'abolizione del feudalesimo. Ma egli sentì molto l’influenza
dei fatti italiani. Le truppe francesi erano considerate dai democratici
italiani le rappresentanti di un paese che aveva stilato un programma di
portata europea per la cacciata dei tiranni. L’Angioy pensava forse che il moto
nazionale sardo potesse concludersi con la proclamazione di una repubblica
sarda, come ebbe ad affermare una volta andato in esilio. L’evoluzione
dell’azione politica dell’Angioy spaventò molti. D’altra parte il 28 aprile era
stato firmato l’armistizio di Cherasco che scioglieva tutte le comunità
repubblicane del Piemonte preferendo che tutto il territorio tornasse sotto i
Savoia. Il programma della liberazione dai tiranni doveva essere mantenuto
soltanto se giovava ai francesi.
A
questo punto l’Angioy si sentì isolato, rendendosi conto che gli veniva meno il
consenso della classe dirigente cagliaritana e il sostegno governativo, allora,
si mosse il 2 giugno 1796 da Sassari con l’intenzione di arrivare a Cagliari e
lungo la strada le popolazioni lo accolsero – come nel febbraio – da
liberatore. La sua marcia verso Cagliari con la sua schiera di paesani armati,
fu rallentata a Macomer e fermata a Oristano l’8 giugno, lo stesso giorno che
il re accettava, finalmente, le famose “cinque richieste” degli stamenti sardi
e concedeva l’amnistia generale. Privato dell’ufficio di “alternos” dal vicerè
su parere degli stamenti, il 9 giugno 1796 l’Angioy fu messo al bando e il
giudice Del Rio, con 2.500 uomini, gli fu mandato incontro. Ormai braccato,
scappò, il 15 giunse a Sassari, il 17 si imbarcò per Livorno e dopo alcuni mesi
di peregrinazioni fu costretto a fuggire in Francia dove visse da esule e in
povertà a Parigi fino alla morte, avvenuta nel 1808.
Tutte
le forze reazionarie che avevano temuto per l’abolizione dei feudi e i moderati
che lo avevano fermato, trassero un sospiro di sollievo, come anche il re e il
suo traballante governo. Sembrò che le popolazioni fossero stanche dei moti
antifeudali, si cercò una pacificazione che però non fu facile, perché le
truppe inviate in Logudoro usarono la mano pesante. Così il 20 luglio fu presa
Bono, patria di Giommaria Angioy, da una colonna di soldati ai quali si
permisero violenze di ogni genere. Successivamente furono occupati militarmente
Ossi, Tissi, Usini e Osilo. Il giudice Giuseppe Valentino fu mandato a Sassari
con pieni poteri e, per la sua inflessibilità nei confronti dei congiurati, si
meritò l’epiteto di “carnefice e giudice dei suoi concittadini”. La resistenza
degli angioyani fu dura a morire e, in alcune zone, durò fino al 1800.
Neppure
Vittorio Amedeo III sentiva simpatia per la Sardegna fino al punto che trattò
segretamente con la corte di Vienna per scambiare l’isola con territori in
terra ferma.
Il
14 ottobre di quel memorabile anno 1796 moriva Vittorio Amedeo III lasciando un
regno impoverito, logorato da guerre disastrose alla mercè dello straniero. Gli
succede al trono sardo l’ascetico e religiosissimo figlio quarantacinquenne
Carlo Emanuele IV, sposato da ventun anni con Maria Clotilde dei Borboni francesi.
CARLO EMANUELE IV DI SAVOIA (1751 – 1819)
20°
RE DI SARDEGNA DAL 1796 AL 1802
 L’ascetico e religiosissimo
quarantacinquenne Carlo Emanuele IV salì al trono sardo il 14 ottobre 1796 in
un momento in cui carestia e miseria affliggevano il regno in completo sfacelo,
e vulnerabile alla propaganda rivoluzionaria. Numerose cospirazioni vengono
scoperte e duramente represse.
L’ascetico e religiosissimo
quarantacinquenne Carlo Emanuele IV salì al trono sardo il 14 ottobre 1796 in
un momento in cui carestia e miseria affliggevano il regno in completo sfacelo,
e vulnerabile alla propaganda rivoluzionaria. Numerose cospirazioni vengono
scoperte e duramente represse.
Nel vano tentativo di risollevare le misere condizioni del
paese Carlo Emanuele IV ricorrerà ad ulteriori gravosi tributi inasprendo ancor
più i disagi del popolo che, capeggiato dai giacobini torinesi, darà l’assalto
al palazzo reale e, dopo la partenza del sovrano nel cuore della notte,
saccheggerà il tesoro della corona.
Era il momento in cui Napoleone conquistava la Lombardia e il
nord Italia. Attaccato da Austria, Russia e Inghilterra dopo la spedizione in
Egitto nel 1798, Napoleone chiese l’alleanza del regno di Sardegna e, di fronte
all’esitazione di Carlo Emanuele IV, fece invadere il Piemonte, impose al
sovrano la rinuncia ai domini di terraferma e l’abbandono di Torino dandogli la
facoltà di trasferirsi in Sardegna, unico possesso rimastogli. E così, l’8
dicembre 1798, Carlo Emanuele IV cedette ai francesi ogni autorità sul
Piemonte, la città di Cagliari era nuovamente la capitale di un regno rientrato
nei confini dell’isola. Per effetto della pace di Luneville il principato di
Piemonte, decurtato dei territori tra Sesia e Ticino, fu trasformato in
“divisione militare francese” e, infine, nel settembre 1802, fu annesso alla
Francia.
Il 9 dicembre 1798 Carlo Emanuele IV fu costretto a lasciare
il Piemonte e ad andarsene in esilio a Firenze. Il 24 febbraio 1799 si imbarcò
a Livorno su sette navi e salpò per Cagliari con tutta la famiglia: moglie, zii
e fratelli fra cui Vittorio Emanuele e Carlo Felice destinati a succedergli. I
piemontesi parlarono allora di “esilio in terra straniera” e non di un
mutamento dentro la stessa patria! Un frate sardo, il P. Tommaso Napoli, afferma che trovandosi a Torino nel 1799,
notò che la maggior parte dei piemontesi non conosceva la Sardegna e che “i più ignoravano la sua esistenza, o che
paese fosse ”.
Il 3 marzo Cagliari accolse il primo re di Sardegna che
ponesse piede nell’isola dopo Carlo V, al meglio delle sue modeste possibilità,
anche se fu colta di sorpresa. Il corteo reale ricevuto dalle più alte autorità
e dal vicerè sul molo, si snodò fra le vie della città in festa e gli ospiti
furono in gran parte alloggiati nel palazzo viceregio il cui arredamento fu
sistemato in gran fretta con il concorso generoso di alcune famiglie dell’aristocrazia
cagliaritana; anche altri palazzi furono ceduti agli illustri ospiti. Nella
modesta ma efficiente reggia di piazza Castello furono accreditati gli
ambasciatori e i diplomatici stranieri.
La presenza nell’isola del re fuggiasco giungeva in un
momento particolare. Le ferite lasciate aperte dai moti del 1794-95 (cacciata
dei piemontesi dall’isola) non erano state rimarginate e molta parte
dell'opinione pubblica guardava con sospetto i nuovi venuti che, a loro volta,
temevano rappresaglie. Tuttavia gli angoli vennero smussati grazie all’opera di
Vincenzo Cabras, reggente dell’intendenza generale e di Vincenzo Sulis, e
l’esperienza sarda della famiglia reale iniziò nel modo meno traumatico
possibile.
L’attività di governo di Carlo Emanuele IV in Sardegna fu
minima, agevolata dall'atteggiamento moderato degli stamenti parlamentari i
quali rinunziarono perfino ai vantaggi del regio diploma dell’8 giugno 1796
(accettazione delle “cinque richieste”) e subirono passivamente l’inasprimento
della politica fiscale per reperire le risorse necessarie a sostenere le spese
per mantenere la famiglia reale e consentire la vita della corte del regno le
cui finanze erano piuttosto modeste e provate.
La presenza della corte favorì la restaurazione del potere dei
feudatari e l’abolizione e
smantellamento del potere degli stamenti, mentre l’assolutismo regio venne
nuovamente ristabilito e l’opinione pubblica liberale, con grande amarezza,
vide svanire tutti i benefici del precedente periodo.
Il re poi, dal canto suo, sognava di riavere il Piemonte e
agognava a evadere dalla Sardegna, e infatti egli restò a Cagliari poco più di
sette mesi. Giacchè, nel frattempo, le truppe della coalizione riconquistarono
il Piemonte, il sovrano, il 18 settembre 1799, lasciò Cagliari per Livorno
animato dalla speranza di tornare a Torino, lasciando in Sardegna come vicerè
suo fratello Carlo Felice. Ma dopo che Carlo Emanuele fu arrivato a Livorno gli
austriaci gli impedirono di trasferirsi in Piemonte e lo costrinsero a risiedere
prima a Firenze e, successivamente, a Napoli.
Frattanto Carlo Felice aveva preso a organizzare il governo
dell’isola adottando le misure necessarie per fronteggiare una difficile
situazione interna causata dalla ripresa dei contrasti tra feudatari e vassalli,
e dall’incerta situazione internazionale. Instaurò un regime oppressivo,
efficiente e poliziesco grazie al quale furono sgominate le ultime roccaforti
di resistenza angioyana. Quando nel settembre del 1800 scoppiarono nuovi moti a
Thiesi, Carlo Felice fece assalire il villaggio da un contingente militare. I
thiesini nell’aspro combattimento persero cinquanta uomini, la resistenza fu
vinta, alcuni capi furono arrestati, condotti a Sassari e impiccati. Analoga
sorte toccò ai ribelli di Santulussurgiu. Egli continuò a governare in modo
spietato, stroncando negli anni successivi i tentativi di insurrezione
organizzati dal Cilloco che, sbarcato dalla Corsica dove si era rifugiato dopo
la sollevazione del 1796, tentò di prendere Tempio. Questa sua durezza nella
repressione gli valse il nomignolo di “Carlo Feroce”.
La Sardegna era completamente isolata mentre sulla terraferma
l’ascesa di Napoleone sembrava non trovare ostacoli. Carlo Emanuele IV non
rivide più Torino, forse travolto da quelle vicende che non riesce a dominare,
il 4 giugno 1802, non avendo discendenti diretti, abdica in favore del fratello
Vittorio Emanuele I duca d’Aosta. Tornato esule prima a Firenze, poi a Napoli
(dove perse la consorte il 7 marzo 1802) e infine a Roma, si ritira dalla scena
politica e si fa gesuita. Morì completamente cieco nel Noviziato di S. Andrea
del Quirinale il 6 ottobre 1819.
Il secolo XVIII apertosi col governo illuminato di Vittorio
Amedeo II, si chiuse quindi pesantemente per i Savoia.
VITTORIO EMANUELE I DI SAVOIA (1759-1824)
21°
RE DI SARDEGNA DAL 1802 AL 1821
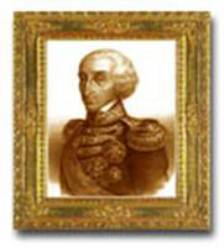 Quando il mediocre e sussiegoso Vittorio
Emanuele I duca d’Aosta divenne re il 5 giugno 1802, il regno attraversava un
momento in cui l'avvenire della dinastia era molto scuro. Aveva quarantatrè anni
ed era sposato da tredici anni con Maria Teresa d’Austria–Este che gli aveva
dato, sino ad allora, tre figli; ma l’erede maschio, il piccolo Carlo Emanuele,
era morto a Cagliari il 9 agosto 1799 facendo terminare la discendenza dei
Savoia. Fu inumato nella cripta della cattedrale di Cagliari dove riposano pure
le spoglie dell’ultimo rampollo della casata dei conti di Barcellona, sovrani
della corona di Aragona e re di Spagna.
Quando il mediocre e sussiegoso Vittorio
Emanuele I duca d’Aosta divenne re il 5 giugno 1802, il regno attraversava un
momento in cui l'avvenire della dinastia era molto scuro. Aveva quarantatrè anni
ed era sposato da tredici anni con Maria Teresa d’Austria–Este che gli aveva
dato, sino ad allora, tre figli; ma l’erede maschio, il piccolo Carlo Emanuele,
era morto a Cagliari il 9 agosto 1799 facendo terminare la discendenza dei
Savoia. Fu inumato nella cripta della cattedrale di Cagliari dove riposano pure
le spoglie dell’ultimo rampollo della casata dei conti di Barcellona, sovrani
della corona di Aragona e re di Spagna.
Dal giorno in cui, l’8 dicembre 1798, Carlo Emanuele IV aveva
ceduto ai francesi ogni autorità sul Piemonte, la città di Cagliari era
nuovamente la capitale di un regno rientrato nei confini dell’isola. Il regno
di Sardegna, dunque, tornò ad essere soltanto sardo.
Mentre Vittorio Emanuele I vagava povero per la penisola
italiana, prima a Napoli poi a Roma, abbandonato da quasi tutti i piemontesi,
in Sardegna si spegnevano gli echi di qualche debole impulso rivoluzionario
espresso dal notaio cagliaritano Francesco Cilocco e dal parroco di Torralba
Francesco Sanna Corda per proclamare la repubblica sarda, ma il primo fu
catturato e giustiziato mentre il secondo cadde durante uno scontro a fuoco.
L’ascesa di Napoleone sembrava incontenibile, nel dicembre
del 1804 si auto incoronò imperatore, poi si proclamò re d’Italia e quindi tramontarono
definitivamente le speranze di Vittorio Emanuele I di riprendersi il Piemonte.
Il re di Sardegna aveva assistito alle vicende napoleoniche stando sulla
terraferma, lontano dai suoi domini isolani ai quali peraltro avrebbe
rinunciato volentieri.
Quando si formò la terza coalizione contro la Francia e la
guerra riprese in Europa, Vittorio Emanuele non tralasciò occasione di proporre
la Sardegna come pedina di scambio in trattative internazionali di rilievo. In
un primo momento sembrò che l’isola potesse essere acquistata dall’Inghilterra
interessata, in seguito ad alcune considerazioni che l’ammiraglio Nelson, dopo
la sua permanenza a La Maddalena, aveva fatto in relazione alla posizione strategica della Sardegna nel
Mediterraneo. Durante le fasi conclusive del negoziato di pace di Presburgo,
imposto da Napoleone nel dicembre del 1805, sembrò che l’isola potesse essere
ceduta alla Francia in cambio di Parma e Piacenza. Tutti questi progetti si
dimostrarono assolutamente senza fondamento.
Vittorio Emanuele I nell’agosto del 1805 abbandonò Roma e si
trasferì a Gaeta, rifiutando qualsiasi offerta francese di scambio territoriale
riguardante il Piemonte oppure la Sardegna “che
ha diritto – diceva – alla nostra
riconoscenza perché ci ha conservato una corona sulla testa ”. L’11
febbraio 1806 il re partì per raggiungere il suo piccolo regno. Arrivò a
Cagliari il 18 salutato con gioia dai sudditi soprattutto perché poneva fine al
governo di Carlo Felice e dei suoi favoriti.
La presenza del re in Sardegna era questa volta destinata a
durare sino al 1814 a causa delle circostanze che sul piano internazionale
isolarono definitivamente l’isola la cui inviolabilità fu protetta dalle flotte
della coalizione anti-napoleonica. Cagliari divenne l’effettiva capitale del
piccolo regno ed ebbe una corte dove i Savoia vissero al riparo dalle vicende
internazionali. L’arciduca Francesco d’Austria–Este, fratello della regina,
sbarcato a Cagliari nel maggio del 1811 per sposare Beatrice, la figlia del re
(il matrimonio fu celebrato nel duomo di Cagliari il 20 giugno 1812), ci ha
lasciato un quadro dettagliato della vita che la piccola corte svolgeva con
molta modestia, ben lontana dall’etichetta di Torino.
In questo contesto anacronistico nel quale i Savoia vivevano
aggrappati a una realtà che minacciava di sfuggire loro, la condizione della
Sardegna era piuttosto grama. Il governo era debole e influenzato dai continui
intrighi dei cortigiani. L’azione della monarchia si rivolse al riordino della
burocrazia e della legislazione, ma fu debole e condizionata da difficoltà di
altro genere. La situazione economica del piccolo regno si faceva
intollerabile. Il disavanzo del bilancio superò le 400.000 lire sarde e crebbe
di anno in anno anche per fare fronte alle crescenti esigenze della corte la
cui permanenza è da considerare come un altro flagello. Le popolazioni
languivano e gli impiegati non percepivano lo stipendio da anni. Per la incerta
situazione diplomatica determinatasi dopo il 1806, la Sardegna visse isolata e
privata del commercio con i porti francesi e italiani.
Negli stessi anni le carestie del 1805 – 1811 e 1812 resero
palpabili le conseguenze della fame mietendo vittime e generando disordini
sociali. Particolarmente grave fu la carestia del 1812, di cui rimane ancora
memoria nei racconti popolari. In questa circostanza il sistema dei “monti
frumentari” si mostrò insufficiente a fronteggiare la situazione; schiere di
affamati e disperati si mossero verso le città alla ricerca di cibo; molti morirono lungo la strada.
Un altro flagello colpì negli stessi anni l’isola: le
incursioni dei pirati tunisini e algerini ripresero con intensità dopo lo
sbarco a Carloforte che consentì loro di fare moltissimi prigionieri. Negli
anni successivi le navi tunisine, tripoline e algerine scorrazzavano lungo le
coste della Sardegna tentando di sbarcare in diversi punti. Si determinò uno
stato di tensione perenne e le popolazioni si organizzarono per difendersi
dalle incursioni, malamente sostenute dalla piccola flotta reale.
In questo clima maturò la congiura ideata da Salvatore
Cadeddu, segretario dell’università e tesoriere del Comune di Cagliari, e altri
avvocati, professionisti e artigiani di Cagliari. La dimensione culturale nella
quale la congiura maturò si riallacciava in qualche modo alla tradizione
democratica che aveva animato la borghesia cagliaritana nel periodo angioyano,
ma soprattutto al malcontento collegato alla grave carestia del 1812. Riemerse
l’insofferenza nei confronti dei piemontesi molti dei quali “erano venuti
ignudi e vestiti a festa si dipartivano”. I congiurati si riunivano a Cagliari
nella zona di Palabanda (dove oggi è l’orto botanico), per organizzare
l’insurrezione della città, fissata per la notte del 30 ottobre 1812. Il loro
obiettivo era quello di cacciare i piemontesi dopo essersi impadroniti della
città e posto a guardia del palazzo reale il nobile Gabriele Asquer. Essi però
furono scoperti per una ingenua delazione pervenuta al capo della polizia il
quale, prima che il moto scoppiasse, fece arrestare i capi e disperdere tutti i congiurati; alcuni riuscirono a
fuggire, altri furono arrestati e giustiziati o condannati a pene pesantissime.
Il fatto che alcuni congiurati fossero riusciti a fuggire indusse non pochi
contemporanei a pensare che la congiura
fosse stata in qualche modo ispirata dagli ambienti vicini a Carlo
Felice il quale aveva mantenuto legami con tutti i sardi di cui si era
circondato durante il periodo del suo viceregno. La cosa appare improbabile,
visto il disinteresse di Carlo Felice per il potere e l’affetto che lo legava a
suo fratello. In effetti il tentativo di insurrezione, come si è detto, si
riallaccia idealmente ai moti del 1793, ai quali culturalmente può essere
paragonato.
Il re si mostrava continuamente preoccupato di seguire gli
sviluppi della politica internazionale nella speranza di recuperare gli stati
di terraferma. Vittorio Emanuele I che disponeva di una piccola flotta,
meditava uno sbarco a Genova con l’aiuto degli inglesi, ma le sue risorse
economiche non permettevano certo un’impresa del genere.
Frattanto in Europa l’impresa napoleonica in Russia si
concluse, a fine novembre 1812, con un disastro militare. Nel febbraio 1813 si
andò organizzando una forte reazione anti-napoleonica e il malessere per il
continuo stato di guerra in cui l’imperatore aveva cacciato l’Europa
serpeggiava ovunque, e anche nell’opinione pubblica francese cominciavano a
mostrarsi molte crepe. Napoleone, però, in marzo riuscì a radunare un nuovo
esercito forte di 180.000 uomini e riprese le operazioni con successo. Allora
si riformò una nuova coalizione, la sesta, e Napoleone fu sconfitto finendo
relegato nell’isola d’Elba il 6 aprile 1814.
Mentre le truppe degli alleati avanzavano in Francia, il re
di Sardegna credette finalmente giunto il suo momento, entrò nella coalizione e
assunse l’impegno di costituire un esercito di 15.000 uomini (per il cui
armamento avrebbe utilizzato il contributo finanziario dell’Inghilterra) e
prese parte con gli austriaci all’invasione della Francia da Nizza e dalla
Savoia contribuendo alla caduta di Napoleone, che avvenne il 9 aprile 1814.
Vittorio Emanuele I, ormai sicuro di poter recuperare i propri domini in
terraferma, partì definitivamente da Cagliari il 25 aprile dello stesso 1814,
lasciando la reggenza a sua moglie Maria Teresa.
Giunse a Torino dove finalmente entrava trionfante il 19 maggio 1814, mentre i soldati francesi
abbandonavano la città “avviliti e imbarazzati”. Di loro restò l’idea di una
efficiente polizia interna che il 13 luglio 1814 suggerì al re l’istituzione di
un “Corpo Cacciatori Reali di Sardegna” trasformato nel 1823 in “Carabinieri
Reali”.
I Savoia furono definitivamente restaurati nei loro antichi
stati il cui territorio fu accresciuto dall’unione al regno di Sardegna della
cessata repubblica di Genova. Vittorio Emanuele I era fermamente intenzionato a
cancellare ogni traccia del periodo rivoluzionario e il suo programma politico
si può riassumere nella volontà di un ritorno incondizionato alla situazione
del settecento. Infatti richiamò in servizio tutti i funzionari del 1798, i
gesuiti, spazzò via il codice napoleonico e ogni residuo della precedente
legislazione, abolendo la tolleranza religiosa. Tale programma trovava
l’avversione di vasti strati dell’opinione pubblica e nella stessa corte, dove
Carlo Alberto principe di Carignano e presunto erede della dinastia, sembrava
aver simpatie liberali. Questa opposizione si ispirava ai principi liberali e
nazionali, vagheggiava l’evoluzione della monarchia assoluta in monarchia costituzionale,
e andava organizzandosi nelle società segrete, la più nota della quali era la
“carboneria”. Tutti però erano accomunati da un forte sentimento
anti-austriaco.
Il 1° novembre 1814 fu discussa a Vienna, dal Comitato dei
Cinque (Austria, Inghilterra, Russia e Spagna), anche l’unione della
recalcitrante repubblica ligure al regno di Sardegna e la successione dei
Savoia – Carignano al trono sardo in caso di morte del re senza figli maschi.
Il congresso di Vienna era ancora in corso quando Napoleone,
fuggito dall’isola d’Elba, il primo marzo 1815, sbarcò a Cannes con pochi
uomini. Il suo arrivo ebbe un effetto straordinario in Francia dove moltissimi,
persino le truppe che gli furono mandate contro per fermarlo, si schierarono
con lui. Il 20 marzo entrava a Parigi e iniziava il periodo conosciuto come “i
cento giorni”. Gli Stati europei, il 25 aprile, ricostituirono la coalizione
anti-napoleonica e radunarono più di un milione di uomini comandati dal duca di
Wellington. Le truppe si concentrarono in Belgio e a Waterloo, il 18 giugno
1815, si concluse la vicenda di Napoleone che fu inviato in esilio nell’isola
di Sant’Elena nell’Atlantico meridionale. Il congresso di Vienna riprese i
lavori e procedette a delineare il nuovo assetto dell’Europa.
Il 16 agosto 1815 anche la regina Maria Teresa lasciò
Cagliari e raggiunse il marito a Torino ed in Sardegna la carica viceregia fu
di nuovo assunta da Carlo Felice.
L’anno dopo ci fu una nuova tremenda carestia, seguita da una
terribile epidemia che terminò solo nell’estate del 1816, mentre il vicerè il
10 giugno si imbarcava per Napoli. Suo reggente fu nominato il generale
tempiese Giacomo Pes di Villamarina che amministrò l’isola con austerità e
rigore; poi Ignazio Thaon di Revel ed infine Ettore Veuillet di Yenne.
Vittorio Emanuele I, una volta a Torino, aveva ristabilito la
speciale segreteria di Stato per gli affari di Sardegna, che prese a occuparsi
dei problemi dell’isola come in passato. In Sardegna dopo la congiura di
Palabanda si era creata una situazione di crescente tensione che richiedeva la
ripresa di una politica riformatrice.
Erano infatti rinate un po’ ovunque le antiche fazioni e nei
villaggi bande di malfattori si fronteggiavano con crescente violenza. Si creò
un clima poliziesco e fu aggravata la legislazione penale, reintrodotta la
tortura, aumentato il gettito delle imposte con una serie di balzelli che
colpivano tutti.
La situazione piemontese rispecchiava quella italiana e
quella del resto d’Europa. In Spagna, nel gennaio 1820, scoppiò la rivoluzione
e il re fu costretto a concedere la costituzione. Sulla scia della rivoluzione
spagnola, nel luglio scoppiò un moto analogo a Napoli e, anche qui il re fu
costretto a concedere la costituzione il 13 luglio. Moti analoghi si verificarono
in Grecia, Portogallo e Germania. Anche a Torino, sull’esempio di Napoli, erano
iniziati i primi moti liberali nei quali era coinvolto anche l’erede designato
dalla corona, il ventitreenne Carlo Alberto di Savoia–Carignano, fresco padre
di un maschietto opportunamente chiamato Vittorio Emanuele (futuro Vittorio
Emanuele II).
Il 10 marzo 1821 scoppiarono i moti liberali che
sollecitavano riforme politiche. Insorsero le guarnigioni di Alessandria e
Vercelli alle quali fecero seguito i militari di Torino inalberando una
bandiera tricolore (forse nero–rosso–azzurro dei carbonari). Non volendo usare
le armi contro i rivoltosi in quanto rifuggiva dall’idea di versare il sangue
dei suoi sudditi, Vittorio Emanuele I preferì abdicare in favore del fratello
Carlo Felice che si trovava a Modena, per cui affidò momentaneamente la
reggenza al giovane Carlo Alberto il quale, il 13 marzo 1821, acconsentì alle
richieste dei rivoltosi. Carlo Felice, indignatissimo, il 16 marzo dichiarò da
Modena di non riconoscere la costituzione e destituì Carlo Alberto. Poi invocò
l’aiuto della Santa Alleanza le cui truppe (austriache) ristabilirono l’ordine
l’8 aprile sconfiggendo gli insorti a Novara. Il giovane principe Carlo Alberto
fu costretto a lasciare Torino e a rifugiarsi a Firenze presso suo suocero. Non solo, per riparare all'infelice
esperienza e rifarsi una credibilità agli occhi della Santa Alleanza, fu
inviato in Spagna con le truppe piemontesi a combattere, con valore, per la restaurazione
della monarchia.
Scrivono gli storici che negli otto anni di permanenza in
Sardegna Vittorio Emanuele I fondò Santa Teresa di Gallura, potenziò il
servizio postale regolarizzato nel 1803, istituì un Monte di Riscatto per
l’ammortamento del debito pubblico, impiantò un’industria cartiera e laniera
senza apprezzabili risultati, creò un esercito ed allestì una piccola flotta
per combattere le incursioni barbariche. Con tutto ciò non fu né amato né
rispettato dai sardi.
Con decreto del 1812 cessò definitivamente l’attività della
zecca di Cagliari nata, successivamente a quella di Bonaria, per volere di
Giacomo II d’Aragona, primo re del Regno di Sardegna, con diploma regio del 27
agosto 1327.
Vittorio Emanuele I confermò la sua rinuncia al trono il 19
aprile 1821 e si ritirò al castello di Moncalieri dove morì il 10 gennaio 1824.
Come il padre e il nonno fu sepolto a Superga, sopra Torino.
CARLO FELICE Duca del Genovese
(1765-1831)
22°
RE DI SARDEGNA DAL 1821 AL 1831
 Undicesimo figlio di Vittorio Amedeo
III, avendo la sua Casa perso la Savoia, dovette cambiare titolo in quello di
marchese di Susa.
Undicesimo figlio di Vittorio Amedeo
III, avendo la sua Casa perso la Savoia, dovette cambiare titolo in quello di
marchese di Susa.
Divenne re di Sardegna mentre si trovava a Modena, dopo la
rinuncia al trono da parte di suo fratello Vittorio Emanuele I, confermata
dallo stesso il 19 aprile 1821. Carlo Felice, dopo avere sconfessato e
destituito suo nipote Carlo Alberto che aveva concesso la “Costituzione” ai
liberali durante la sua reggenza, restò a Modena fino a quando le truppe della
Santa Alleanza non ebbero ragione dei rivoltosi piemontesi. Battendoli a Novara
il 24 luglio. La repressione, in verità, non fu sostanzialmente feroce e di
questo Carlo Felice si dispiacque moltissimo quando il 17 ottobre 1821 si
insediò a Torino.
Carlo Felice è definito dagli storici: “uomo di buona salute,
che non amava sciupare le sue energie e gli piaceva la vita tranquilla;
ripugnava da tutto quello che poteva agitarlo; odiava i letterati, come odiava
i borghesi, odiava i savoiardi come odiava i torinesi e come poi odiò i sardi
…”. Costituzionalmente reazionario era spaventato dal “progresso”.
Nei seguenti dieci anni di regno, dicono i manuali apologeti,
innalzò lo stato al grado di potenza marittima, effettuò la riforma della
gerarchia giudiziaria, stabilì consolati sulle coste dell’Africa e del levante,
adornò Genova e Torino di sontuosi fabbricati.
Anche in Sardegna, che Carlo Felice conosceva bene per essere
stato vicerè dal 1799 al 1806 e dal 1815 all’anno seguente in cui lasciò
Cagliari, mantenendo però il governo nominale sino al 1821, malgrado tutto
lasciò un buon ricordo di sé. Le sue riforme, per quanto avessero un carattere
eminentemente strumentale e pratico, incisero profondamente sulla realtà sarda.
Le principali riforme feliciane furono quattro: la pubblica istruzione,
l'organizzazione sanitaria, la raccolta
e la riforma della legislazione ed infine l’avvio della costruzione della
strada Cagliari–Sassari–Porto Torres detta “Carlo Felice”.
Con l’editto del 24 giugno 1823 l’intero apparato scolastico
venne riformato. In ogni villaggio doveva essere aperta una scuola elementare,
della durata di tre anni, alla quale avrebbero fatto seguito le altre scuole
tradizionali. L’editto prevedeva pene severe nei confronti di quelle famiglie
nobili o facoltose che, senza ragione, avessero tralasciato di mandare agli studi
i propri figli. Il re si adoperò inoltre per riordinare gli studi universitari
e per potenziare le raccolte scientifiche dei due atenei. Nonostante questo
grosso impegno nei primi anni della riforma si ebbero modesti risultati.
Nel febbraio del 1828 Carlo Felice riordinò radicalmente
l’organizzazione sanitaria a partire dalle condotte, e introdusse la
vaccinazione.
Promulgò una
nuova organica raccolta di leggi, detta “Codice Feliciano” che mise ordine
nella marea di leggi che governavano il regno, molte delle quali risalivano ai
tempi giudicali e al periodo catalano. Il nuovo codice fu emanato il primo
settembre 1827 e fu utilizzato fino al 1848, anno della fusione. Esso era
diviso in due parti: la prima comprendeva le norme di diritto di procedura civile,
la seconda comprendeva il diritto e la procedura penale. Questa seconda parte
conteneva alcune novità di grande rilievo sociale: furono abolite le pene che
prevedevano castighi troppo severi o infamanti e, tra l’altro, venne abolita la
responsabilità collettiva degli abitanti dei villaggi per certi reati.
Carlo Felice, infine, approvò nel 1821 il progetto
dell’ingegner Carbonazzi inteso a costruire la strada Cagliari– Sassari–Porto
Torres, chiamata “Carlo Felice”, la quale inizia con un cippo e la statua del
re con tanto di epigrafe nell’attuale Piazza Yenne. La costruzione iniziò nel
novembre del 1822 e si concluse nel 1829, dopo sette campagne di lavoro,
ciascuna di 130 giorni. Le squadre degli operai lavoravano nel periodo compreso
tra febbraio e giugno di ogni anno per sfuggire alle insidie del clima e della
malaria. Tutto ciò rappresenta un bell’esempio nei confronti di come invece
procedono i lavori, a cavallo del secondo e terzo millennio, sulla stessa
importante arteria isolana chiamata oggi strada statale 131.
Negli stessi anni fu definito il problema dell’uso comune dei
territori non chiusi (chiudende). Già nella seconda metà del settecento padre
Francesco Gemelli, un gesuita piemontese che insegnava nell’Università di
Sassari, aveva proposto la diffusione della proprietà privata come strumento
atto a migliorare le condizioni dell’agricoltura sarda. Nei primi anni del
secolo XIX Vittorio Emanuele I aveva emanato il primo editto che però non fu
pubblicato subito; fu Carlo Felice, invece, a farlo il 23 aprile 1823. La sua
applicazione diede luogo, purtroppo, ad abusi ed arbitri gravi che turbarono
l’equilibrio della società. Il malessere si fece sentire soprattutto fra il
1828 e il 1830 e, per venirne a capo, specialmente nel nuorese, fu necessario
l’intervento di colonne volanti di militari a cavallo.
Ad onore del re Carlo Felice va ricordato il suo rifiuto di
entrare a far parte di una lega italiana presieduta dall’imperatore d’Austria,
e la decisa azione contro il porto di Tripoli, eseguita dalla marina sarda nel
1825, quando il Bey tentò di violare certi trattati conclusi con Vittorio
Emanuele I.
Il 17 febbraio 1831 il re s’ammalò; il 24 aprile fece
chiamare da Chambery, in Savoia, Carlo Alberto da lui disprezzato ed avversato
ma impostogli dall’Austria (la Santa Alleanza), e lo presentò ai ministri
radunati attorno al suo letto dicendo: “Ecco
il mio erede e successore; sono sicuro che farà il bene dei sudditi ”. Morì
il 27 aprile del 1831 e fu sepolto ad Altacomba, nella Savoia. “Con lui – disse il vescovo di Annecy che
benedisse la salma – sotterriamo la
monarchia ”. Infatti terminava la dinastia degli Amedei ed iniziava quella
incognita dei Savoia – Carignano.
CARLO
ALBERTO (1798-1849)
23°
RE DI SARDEGNA DAL 1831 AL 1849
 Carlo Alberto discendeva in linea
diretta da Tommaso di Savoia – Soissons. Figlio di Carlo Emanuele I di
Carignano e di Albertina Maria Cristina di Sassonia, perdette presto il padre e
trascorse la prima giovinezza a Parigi, dove la famiglia si era rifugiata in seguito
all’invasione napoleonica del Piemonte. Ritornò a Torino nel 1814, per volere
di Vittorio Emanuele I, dove fu allevato rigidamente a corte col ruolo di erede
designato. Egli era un uomo gigantesco nella persona e di modi gentili,
fondamentalmente triste, e l’indecisione fu il tratto principale della sua
personalità, ma era anche un lavoratore instancabile. Il suo programma era: “tacere e fare; e fare piano: doucement
”.
Carlo Alberto discendeva in linea
diretta da Tommaso di Savoia – Soissons. Figlio di Carlo Emanuele I di
Carignano e di Albertina Maria Cristina di Sassonia, perdette presto il padre e
trascorse la prima giovinezza a Parigi, dove la famiglia si era rifugiata in seguito
all’invasione napoleonica del Piemonte. Ritornò a Torino nel 1814, per volere
di Vittorio Emanuele I, dove fu allevato rigidamente a corte col ruolo di erede
designato. Egli era un uomo gigantesco nella persona e di modi gentili,
fondamentalmente triste, e l’indecisione fu il tratto principale della sua
personalità, ma era anche un lavoratore instancabile. Il suo programma era: “tacere e fare; e fare piano: doucement
”.
Carlo Alberto nel 1817 sposò Maria Teresa figlia del granduca
di Toscana. Da quell’epoca cominciò in lui il
travaglio che lo doveva fare partecipe delle nuove idee della gioventù
liberale del suo tempo. La rivoluzione del 1821 provocava l’abdicazione di
Vittorio Emanuele I. Assente il nuovo re Carlo Felice, era nominato reggente Carlo
Alberto che, sollecitato dai patrioti, il 13 marzo 1821 concedeva lo Statuto.
Carlo Felice, assunto il potere, indignatissimo, il 16 marzo abrogò ogni
concessione del reggente provocando una generale reazione in tutto il Piemonte.
Carlo Alberto fu esiliato, e si rifugiò a Firenze presso suo suocero. Per
rifarsi una credibilità agli occhi di Carlo Felice e della Santa Alleanza fu
inviato, nell’agosto del 1823, in Spagna ove combattè con valore per la
restaurazione della monarchia.
Carlo Alberto assunse il titolo di re di Sardegna dopo la
morte di Carlo Felice, avvenuta il 27 aprile 1831, tra i timori e le speranze
di tutti. Assicurano i passati scrittori monarchici che Carlo Alberto “fu il sovrano delle grandi riforme in ogni
ramo dell’amministrazione giudiziaria, culturale, civile, industriale,
commerciale, militare e politica …”. I suoi primi atti di governo furono
reazionari: nel 1833 la rivoluzione di Genova fu duramente repressa e furono
eseguite varie condanne a morte che colpirono alcuni affiliati alla “Giovane
Italia”. Ma presto prevalsero in Carlo Alberto idee liberali che emersero dal
piano di rinnovamento continentale e insulare che aveva elaborato prima ancora
di salire al trono, visitando le terre regie.
Carlo Alberto attua una serie di riforme soprattutto in campo
economico e giuridico. Una commissione da lui appositamente creata nel 1831,
allo scopo di predisporre nuove norme giuridiche rispondenti alle esigenze
della vita moderna, consente di potere scrivere e promulgare dal 1837 al 1848 i
codici: civile, penale, militare, di commercio e di procedura. Avvia una certa
forma di decentramento amministrativo nei confronti dei Comuni e delle
Provincie; significativo è il suo intervento in tema di opere pubbliche come
dighe e grandi strade di collegamento. Lascia una impronta anche nella cultura
dotando il palazzo reale di Torino di una biblioteca, di una sontuosa armeria
reale, di un medagliere dei Savoia.
Il nuovo sovrano aveva un rapporto profondo con l’isola che
aveva visitato una prima volta nel 1821 e in seguito nel 1829, quando ebbe modo
di girarla tutta accompagnato dal conte Alberto Ferrero de La Marmora, famoso
autore de “Itineraire del l’ile de
Sardaigne ”, che aveva scritto, su suggerimento dell’amico Emanuele Pes di
Villamarina, in cui auspicava l’abolizione del feudalesimo e la estensione
all’isola delle leggi e dei regolamenti vigenti negli Stati continentali.
Una volta salito al trono, Carlo Alberto ricostituì, nel
1833, la Segreteria di Stato per gli affari della Sardegna e pose al suo
vertice il vecchio amico Pes, nobile tempiese, che durante il regno di Carlo
Felice era rimasto in disparte. Il 20 aprile dello stesso 1833 emanò il regio
brevetto che istituiva le Deputazioni di
Storia Patria per la
pubblicazione di opere inedite o rare appartenenti alla nostra storia, e di un Codice Diplomatico dei nostri Stati che nell’isola prese il titolo di “Codex Diplomaticus Sardiniae ”, edito
nel 1861-68.
Negli anni successivi, nonostante gli impegni di governo, il
nuovo re visitò l’isola altre due volte, nel 1841 e ancora nel 1843. Egli
sviluppò un notevole programma di riforme riguardanti i più disparati aspetti
della vita sarda. In particolare, a partire dal 1831 incrementò la politica
delle bonifiche di vasti territori incolti in diverse zone della Sardegna. Gli
interventi più notevoli furono attuati tra Ortacesus, Senorbì e Guasila dove
nel 1831 fu prosciugata una vasta palude; fu continuata la bonifica della
palude di Paulilatino; nel 1838 fu iniziata la bonifica della palude di Sanluri,
e nel 1839 quella di San Lorenzo; nel 1840 Carlo Alberto favorì la bonifica
della palude in agro di Ussana. Fu sviluppata la frutticoltura in diverse
aziende nei territori di Pula ed Elmas, fu potenziato lo sviluppo del centro di
Villasimius, ecc. Questa notevole quantità di iniziative fu sorretta da una
serie di misure legislative per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’industria.
Così, nel 1835, fu istituita a Sassari la Camera di Agricoltura, Commercio e
Arti che aveva il compito di sostenere la pratica più razionale delle colture
agrarie e rendere il commercio isolano attivo.
Nel 1835 il re potenziò il collegamento regolare via mare tra
la Sardegna e il continente, mediante l’utilizzo di una nave a vapore. Fu
favorita la costruzione di nuove strade che facilitassero lo sviluppo dei
collegamenti interni. Fu istituito un servizio di diligenze e un regolare
servizio postale per porre fine al tradizionale isolamento dei villaggi.
Nel 1836 Carlo Alberto avviò la riforma delle amministrazioni
locali, abolì i tribunali feudali e riformò il restante sistema giudiziario e
carcerario mediante l’edificazione di sette carceri centrali. Per combattere il
banditismo furono istituiti i Cavalleggeri
di Sardegna, e per mantenere l’ordine pubblico venne affidato ai miliziani
il servizio di ronda nelle strade e ai barracelli il servizio di guardia nelle
campagne.
Sempre nel 1836 fu istituita la commissione che per otto anni
studiò la razionalizzazione delle monete, dei pesi e delle misure, fino ad
allora espresse in starelli o mois, in quartare, in once, in arrialis, in
pezzas, ecc., e che introdusse nell’isola il sistema metrico decimale.
Ma la
riforma più importante voluta da Carlo Alberto fu, a partire dal 12 maggio
1838, l’abolizione del feudalesimo introdotto in Sardegna dai catalano –
aragonesi nel 1323/24 e mantenuto in virtù di una clausola conservativa del
trattato di Londra del 1718, giurata da Vittorio Amedeo II il 2 settembre
1720. Nel 1838 i feudatari possedevano
ottantatré feudi, che coprivano i due terzi della superficie dell’isola. Alcuni
comprendevano più di una regione e molte decine di villaggi, altri erano di
dimensioni medio piccole. I feudi maggiori erano tutti in mano di famiglie che
non risiedevano in Sardegna, ai feudatari sardi rimanevano comunque
cinquantanove feudi, che comprendevano centotrentadue villaggi con 149.159
abitanti. La popolazione dell’isola raggiungeva nel 1810 i 360.000 abitanti
circa, entro il 1848 arrivò a superare il mezzo milione. La crescita
demografica registrata era quindi conforme a quanto avveniva nel resto
d’Europa.
Il
prestigio che i feudatari avevano era notevole e ancora nella seconda metà del
settecento i loro poteri erano divenuti uno dei principali sostegni della
politica piemontese in Sardegna, fenomeno che si accentuò nella prima metà del
secolo. I feudatari sardi nei decenni che precedettero l’abolizione, per quanto
durante il regno di Carlo Felice si sentissero protetti, videro
progressivamente ridotto il loro ruolo istituzionale. Ma avevano anche compreso
che la monarchia non poteva fare a meno di loro.
Il
primo tentativo di abolizione dei feudi fu fatto nel 1832. A questo progetto si
oppose l’Austria che riferendosi al trattato de L’Aia ingiunse a Carlo Alberto
di non modificare uno dei cardini del sistema istituzionale del “Regnum
Sardiniae”. Dopo che il Pes divenne reggente della Segreteria di Stato, nel
1834, prese avvio la fase decisiva delle procedure di abolizione del
feudalesimo la cui commissione si trovò a operare in un contesto difficile e soltanto
nel 1839 si concluse con l’accettazione del riscatto che si rivelò un grosso
affare per i feudatari. Infatti fu presa come parametro, in via di amichevole
transazione, la rendita di ciascun feudo capitalizzata al cinque per cento. La
somma così ottenuta venne iscritta nel “Gran libro del debito pubblico” a
favore del feudatario. Gli abitanti dei villaggi dovettero sopportare il peso
del riscatto corrispondendo allo Stato, con pesanti tributi annui, le somme
stabilite dagli accordi fatti.
Il XIX secolo è pervaso da un vasto programma di riforme che
scatenarono nel marzo 1848 la rivoluzione liberale nell’Europa centrale. Anche
in Italia, come già detto, a partire dal 1821 andavano delineandosi programmi
politici che ispirarono il “Risorgimento nazionale”. Nel marzo 1831 Giuseppe
Mazzini fondò la “Giovane Italia” sul principio dell’Italia unita, libera e
repubblicana. Nel 1843 Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo pubblicarono due libri
contenenti i programmi politici dei liberali moderati. Il Gioberti ipotizzava
la formazione di uno Stato federale neoguelfo sotto la presidenza del Papa. Il
Balbo, invece, auspicava la fine di ogni ingerenza austriaca in Italia in uno
Stato federale sotto la guida del Piemonte.
La sopravvivenza nella Sardegna degli statuti e privilegi di
epoca spagnola era un elemento che attestava l’inconciliabile separazione fra
il Piemonte e la sua lontana isola, e la compartecipazione con le altre
provincie che comportasse la rinuncia alla sua vecchia istituzione non poteva
essere attribuita agli stessi sardi. E’ quindi indubbio che le idee di fusione
nacquero a Torino; questa convinzione è suffragata dalla totale mancanza di
documenti che comprovino che l’iniziativa fosse partita dalla Sardegna.
Tuttavia è con Carlo Alberto che la Sardegna rompe con la tradizione spagnola
nell’ordine legislativo, con rinuncia degli stamenti sardi ai suoi secolari
privilegi, rinuncia che portava con se l’unione, in eguaglianza di diritti, col
Piemonte.
Sull’onda delle emozioni complesse e di interessi concreti,
una ristretta élite colta dell’isola avanzò la richiesta di rinunciare alla
separazione della Sardegna, di porre fine all’antico ordinamento che, pur con
qualche limite, garantiva autonomia, e di assorbirla in un regno unificato con
il Piemonte, la Liguria e gli altri Stati della dinastia. A spingere per la
“fusione perfetta” vi erano oltre agli interessi economici, suggestioni
ideologiche che avvicinavano i liberali sardi a quelli piemontesi. Quindi, il
29 novembre 1847, per potere godere dei vantaggi della nuova costituzione che
si stava approntando nella parte continentale del regno, i sardi chiesero
spontaneamente al re Carlo Alberto di rinunciare alla cosiddetta autonomia
statuale e il 3 dicembre: “Sua Maestà,
deferendo alle calde istanze delle Deputazioni e degli Stamenti si degnò di
esternare come intende operare la fusione di questa isola con le altre parti
dei suoi Stati di terraferma e formare una sola famiglia di tutti i suoi amati
sudditi con perfetta parità di trattamento …”. Ciò non vuol dire che nel
1847 finì il Regno di Sardegna, ma che lo Stato da composto divenne unitario o
semplice, con un solo popolo, un unico territorio, un solo potere pubblico.
Perciò con la fusione cessò la carica viceregia e cessò pure di esistere il
Parlamento originario che, d’altronde, non si riuniva più dal 1698.
Ai primi di ottobre del 1847 vi furono disordini a Torino e
Genova repressi con decisione dalla polizia; altri ne seguirono dal 23 e poi,
improvvisamente, il 30 ottobre Carlo Alberto avviò il programma di riforme.
Frattanto, il 3 novembre 1847, era stato firmato l’accordo
preliminare per la lega doganale tra il Regno di Sardegna, il Granducato di
Toscana e lo Stato Pontificio, da considerare come il primo passo per la
costituzione di una confederazione di stati italiani secondo il programma
neoguelfo.
Mentre si chiudeva il tormentato anno delle prime riforme,
nel 1848 scoppiarono anche in Italia i moti rivoluzionari collegati a quelli
del resto d’Europa. Dopo che Carlo Alberto aveva riformato la censura, i
liberali piemontesi, guidati da Camillo Benso Conte di Cavour e Cesare Balbo,
chiesero al re la Costituzione. Il Piemonte sembrava quindi porsi alla guida di
un vasto programma di respiro nazionale; nel frattempo in altre parti d’Italia
iniziarono i moti politici rivoluzionari: il 12 gennaio in Sicilia il re
Ferdinando fu costretto a concedere la Costituzione, seguito dal Papa che il 14
concesse una Costituzione per i suoi stati; così pure dovette fare l’arciduca
Leopoldo di Toscana il 17 febbraio.
L’8 febbraio 1848 anche Carlo Alberto aveva concesso la
Costituzione (lo Statuto), la notizia arrivò in Sardegna l’11 salutata da
manifestazioni di giubilo. Lo Statuto fondamentale del regno fu promulgato il 4
marzo 1848, fu l’unico in Italia destinato a sopravvivere e diventerà la legge
fondamentale del Regno d’Italia al compimento dell’unità. Con lo Statuto fu
istituito un sistema bicamerale di modello inglese che prevedeva il senato di
nomina regia, e la camera dei deputati eletta a suffragio limitato. Quindi
furono fissate le elezioni per il 17 – 18 aprile e il primo parlamento fu
inaugurato dal principe di Carignano l’8 maggio 1848.
A partire dal 1848 la Sardegna visse in maniera
contraddittoria la propria “fusione perfetta”. Infatti, passata l’euforia del
momento fu immediatamente evidente che la conseguente estensione dello “Statuto
Albertino” come legge fondamentale che annullava gli antichi ordinamenti del
“Regnum Sardiniae”, non aveva risolto i gravi problemi di fondo che la Sardegna
si trascinava dalla sua storia. Fin dai primi mesi, al facile entusiasmo si
sostituì il bisogno d’una più profonda riflessione su quanto era avvenuto e da
parte di molti intellettuali si cominciarono a manifestare i primi dubbi su
quanto, con estrema rapidità, si era ottenuto. Così molti, riflettendo sulla
portata dello storico evento, avanzarono motivi di critica e di profonda
delusione per quanto era accaduto.
Alcuni polemizzarono tentando di dimostrare l’inutilità della
fusione sottolineando la diversità tra Sardegna e Piemonte. Federico Fenu
pubblica un opuscolo a Cagliari
nell’aprile 1848 dove dice apertamente che i sardi desideravano si l’unione, ma
non la fusione col resto d’Italia; la Sardegna, secondo lui, “dista dal Piemonte di stirpe, di costumi, di
indole, di genio, forse più che gli italiani dagli inglesi “. Era l’amaro
sentimento di chi credeva che il regno autonomo della Sardegna restasse, dopo
cinque secoli, ridotto “alla vile e
misera condizione di provincia del Piemonte “. Così, tra il febbraio e il
marzo 1848, si manifestarono forti tensioni dovute in parte alle voci in base
alle quali si diceva che il re, nonostante la promessa fatta, volesse ritardare
l’applicazione delle riforme in Sardegna. Fu subito chiaro che l’inquietudine
era provocata dalla applicazione della legislazione sabauda a una realtà così
diversa che fece crescere il senso di isolamento e la condizione di inferiorità
dell’isola nei confronti delle altre provincie, facendo esplodere quella che la
storiografia definì la “questione sarda”.
Dopo la fusione, l’apparato amministrativo dell’antico
“Regnum” venne progressivamente smantellato e sostituito da istituzioni e
magistrature che erano state ideate per una realtà diversa ed estranea e
completamente nuove per la Sardegna. L’intero processo durò circa dieci mesi.
L’isola attraversò un momento molto difficile a causa dei contrasti tra
fusionisti e non. I primi moti scoppiarono nel marzo del 1848 provocati dagli
studenti dell’università di Cagliari e di Sassari ed ebbero come movente una
vigorosa campagna contro i gesuiti che culminò nella loro espulsione dalla
Sardegna. Altri moti a carattere annonario si ebbero ad Alghero, Nuoro, Aggius
ed ancora a Sassari, dove vi fu anche un morto.
Il
20 aprile 1848 fu esteso alla Sardegna il decreto sulla libertà di stampa; nel
maggio fu introdotto il servizio militare per la classe 1830; il primo giugno
vennero unificati i tanto invocati servizi doganali e in agosto fu abrogato il
“Codice Feliciano” e sostituito dal Codice Civile e Penale in vigore nei
rimanenti Stati di terraferma. Il 12 agosto dello stesso 1848 fu abolita la
tradizionale divisione dell’isola introdotta agli inizi del secolo. Furono
istituite tre divisioni amministrative con capoluogo Cagliari, Nuoro e Sassari
che rimase in vigore fino al 23 ottobre 1859; esse furono sostituite
successivamente dalle due grandi provincie di Cagliari e Sassari, amministrate
da un governatore.
Così
l’ultimo vicerè, il De Launay che con grande prudenza aveva guidato il governo
dell’isola nel delicato periodo del passaggio, ivi comprese le prime elezioni
per la costituzione del parlamento, il 30 settembre 1848 si congedò dalla
popolazione con un commosso proclama.
Il
7 ottobre dello stesso anno fu riformata l’amministrazione degli enti locali,
che furono resi effettivamente elettivi. Tale riforma sancì l’acquisito potere
della borghesia. Infatti il diritto elettorale era riservato esclusivamente a
coloro che erano iscritti nel ruolo delle imposte dirette con un certo reddito,
nonché ai cittadini maschi che avessero compiuto 25 anni, che sapessero leggere
e scrivere e che pagassero una imposta annua di almeno 40 lire. Il confronto
politico era sostenuto da numerosi giornali, pubblicati a Cagliari e a Sassari.
Infatti a partire dal 1848 si pubblicavano in Sardegna: “Il Nazionale”, “Il
Popolo”, “L’indipendenza Italiana”, “Il Cittadino”, “La Favilla”. Il 17 – 18
aprile 1848 si ebbero le prime votazioni per il parlamento e furono eletti 24
deputati, fra i quali Camillo Benso Conte di Cavour, che venne eletto a
Iglesias. I suddetti 24 deputati furono eletti da non più di 6.000 elettori e,
per poter svolgere il loro compito, dovettero recarsi a proprie spese a Torino,
affrontando notevoli disagi e considerevoli spese che indussero alcuni a
disertare i lavori parlamentari.
Per
far fronte alle sempre più frequenti manifestazioni di insofferenza popolare,
il governo non trovò di meglio per risolvere i problemi che nominare, il 3
marzo 1849, un commissario straordinario nella persona di Alfonso La Marmora
affidandogli pieni poteri per ristabilire l’ordine. Egli godeva nell’isola
indubbie simpatie derivanti dalla sua opera in favore della Sardegna. La sua
azione fu malvista anche perché per venire a capo di situazioni difficili fu
costretto dal governo ad avallare una politica repressiva che scosse sempre più
l’opinione pubblica. Fu un errore politico che dimostrò tutta l’incomprensione
dei governanti nei confronti della questione sarda.
Nel
frattempo era ormai giunto il momento per realizzare un altro degli obiettivi dei
programmi liberali, quello della cacciata dell’Austria. I patrioti lombardi,
entusiasti per i moti che avvenivano a Vienna, Budapest e Berlino, si
ribellarono. Il 18 marzo 1848 insorsero a Milano e dopo cinque giorni
l’esercito austriaco fu costretto a lasciare la città. L’insurrezione dilagò in
tutto il lombardo-veneto e il 22 marzo venne proclamata la repubblica di
Venezia. Sull’onda dell’entusiasmo, il 23 marzo 1848, Carlo Alberto,
rivendicando alla propria casa il compito dell’unificazione italiana, dichiarò
guerra all’Austria, facendo propria per le sue truppe la bandiera
rivoluzionaria tricolore, verde –
bianco – rosso, nata a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 e adottata da molti Stati italiani: dai
repubblicani della Cisalpina, dal governo insurrezionale delle due Sicilie, dal
governo provvisorio della Repubblica Veneta, dal granducato di Toscana e
perfino dalla guardia civica romana.
Fu
la prima guerra d’indipendenza nazionale, ma fu anche una breve fiammata date
le forze in campo. La lotta fu impari malgrado la larga partecipazione di
truppe provenienti da molte parti d'Italia e di molti giovani sardi che,
superando con entusiasmo il fatto che non fosse stato ancora introdotto in
Sardegna il servizio di leva, chiesero di essere arruolati come volontari per
prendere parte a quella che veniva
considerata la guerra di liberazione nazionale. Essi presero parte alle
prime operazioni in un “reggimento sardo” che si distinse il 7 aprile 1848 a
Goito. In particolare, vanno ricordati i “Cacciatori Sardi” che si segnalarono
a Pastrengo, mentre i fanti sardi si distinsero a Peschiera in molti episodi di
valore. Va inoltre ricordato che a Villafranca si ebbe il celebre episodio del
tamburino sardo immortalato da Edmondo De Amicis.
Purtroppo
dopo qualche successo militare (Pastrengo e Goito), l’esercito sardo–piemontese
fu sconfitto a Custoza, il 24 luglio, e cacciato dalla Lombardia. Il regno di
Sardegna fu costretto, il 9 agosto, a firmare l’armistizio che peraltro
denunciò nell’anno successivo, il 12 marzo 1849, riprendendo le ostilità e
affrontando di nuovo gli austriaci del maresciallo Radetzky. Anche questa
seconda fase si concluse, il 23 marzo 1849, con una dura sconfitta che
costrinse Carlo Alberto all’armistizio di Novara. Subito dopo l’armistizio fu formato
il corpo dei “Cacciatori di Sardegna” che, inquadrato nella divisione di
riserva al comando dell’allora principe ereditario Vittorio Emanuele, si coprì
di gloria.
Per
non sottostare alle dure condizioni imposte dal vincitore, Carlo Alberto,
melanconicamente, il giorno stesso abdicò a favore di suo figlio Vittorio
Emanuele II e furono avviati i difficili negoziati per la pace con l’Austria.
Partirà
in volontario esilio per il Portogallo, malato, deluso, maledetto da alcuni,
incompreso da tutti, e di lì a poco morirà, a Oporto, il 28 luglio dello stesso
1849.
VITTORIO EMANUELE II (1820-1878)
24°
RE DI SARDEGNA DAL 1849 LA 1861
PRIMO
RE D’ITALIA DAL 1861 AL 1878
 Dei due figli maschi di Carlo Alberto di
Savoia–Carignano (e di Maria Teresa degli Asburgo–Lorena di Toscana), il
sanguigno e volitivo Vittorio Emanuele II era quello che gli somigliava di
meno, tant’è che si favoleggiò fosse stato sostituito nella culla alla morte
del vero infante reale durante un incendio accidentale.
Dei due figli maschi di Carlo Alberto di
Savoia–Carignano (e di Maria Teresa degli Asburgo–Lorena di Toscana), il
sanguigno e volitivo Vittorio Emanuele II era quello che gli somigliava di
meno, tant’è che si favoleggiò fosse stato sostituito nella culla alla morte
del vero infante reale durante un incendio accidentale.
Figura fra le più caratteristiche del risorgimento italiano,
cui dedicò attività e passione, ricevette il titolo di Duca di Savoia (1831) e
fin dalla giovinezza fu ostile all’Austria. Partecipò valorosamente alle
battaglie di Goito (30 maggio 1848) e Custoza (23 luglio) dove si conquistò la
medaglia d’oro. Combattè coraggiosamente, ancora, al comando di una divisione,
a Novara, dove il Piemonte perdette le speranze di vincere l’Austria (1849).
Successe al trono paterno la tristissima sera del 23 marzo
1849, all’età di 29 anni, dopo l’abdicazione del padre Carlo Alberto, in
seguito alla sconfitta militare. Era un momento molto difficile per il giovane
re, ma subito manifesta, di fronte agli eventi non favorevoli, volontà tenace e
una visione sempre equilibrata della realtà. Rude, più avvezzo alla franchezza
militaresca che alle finezze di corte, uomo dalla personalità esuberante, volle
per primo tenere piena fede allo Statuto ed il 27 marzo emana un primo proclama
che annuncia la salda volontà di consolidare le istituzioni costituzionali.
Quando iniziò il suo “mestiere di re”, come lui stesso
diceva, si inimicò subito il Parlamento, la borghesia e il popolo per avere
accettato a Vignale le condizioni di Radetzky – eccetto la soppressione dello
Statuto – tanto che da tutto il regno si manifestarono malumori e inquietudini.
La successiva pace firmata con l’Austria il 5 gennaio 1850 gli ridiede invece
credibilità esterna e prestigio interno.
Aiutato dalla felice scelta di uomini di governo, da Massimo
d’Azeglio a Camillo Benso Conte di Cavour, deve assumere talvolta, in contrasto
col Parlamento, la parte del sovrano costituzionale ed assecondare il
programma riformatore del governo e
seguire, nell’interesse del suo regno, l’indirizzo politico tendente
all’abolizione dei vecchi istituti giuridici di stampo feudale, alla
laicizzazione dello Stato che colpiva anche i tradizionali privilegi
ecclesiastici.
La politica del sovrano fra il 1850 e il 1855 fu tesa a
regolare i rapporti con la Chiesa. Già l’allontanamento dei gesuiti dai
territori dello Stato avvenuto nel 1848 aveva creato una condizione di
conflittualità col clero; ora si ponevano in discussione le decime e i
privilegi ecclesiastici, la presenza di numerosi ordini contemplativi e
mendicanti. Con la legge dell’8 aprile 1850 fu abrogato il foro ecclesiastico,
disponendo che anche i preti fossero assoggettati ai tribunali statali, mentre
con la legge 22 maggio 1855 vennero soppresse le famiglie monastiche i cui beni
avrebbero dovuto sopperire alle necessità del culto.
Ai margini di questi fatti vale la pena raccontare il
seguente aneddoto. Alberto Lamarmora, durante uno dei suoi viaggi nell’isola
arriva ad Alà dei Sardi, paesello della provincia di Sassari e ha una
discussione con il sindaco che non voleva riconoscere l’ordine del vicerè di
agevolare con cavalli il viaggiatore, e davanti all’insistenza di Lamarmora il
sindaco, offeso, gli dichiara che “presenterà
le sue lamentele a Madrid ”! Egli si figurava di essere ancora sotto la
dipendenza spagnola che aveva cessato di dominare la Sardegna nel 1720, cioè da
oltre cento anni.
Nel firmamento della politica sardo – piemontese saliva
l’astro di Cavour, liberale di formazione europea, conoscitore del pensiero
politico francese e ammiratore del parlamentarismo inglese. L’ambizioso e
cinico Camillo Benso Conte di Cavour, iniziò la sua attività di governo nel
1850 a quarant’anni. Uomo sostanzialmente di destra, nel 1852 aveva stipulato
un “connubio” con la sinistra di Urbano Rattazzi in lotta per il raggiungimento
delle aspirazioni nazionali, che gli fece guadagnare la presidenza del
consiglio. Ma Cavour non piaceva né al re né al popolo. Comunque sapeva
amministrare bene la cosa pubblica.
Cavour in Sardegna portò avanti il processo di abolizione
dell’antico e malo uso di profittare dei terreni incolti (dello ademprivio)
completato definitivamente in periodo italiano nel 1865. Sotto la sua
presidenza fu istituita una banca sarda e fu tentata, inutilmente, la
colonizzazione di 200.000 ettari di terreno demaniale da parte della casa
bancaria francese Bonnard. Fu approvata dai deputati sardi la cessione al conte
di Beltrami di Bagnacavallo della foresta di monte Mannu – Austis da
disboscare; cominciò così la corsa alla distruzione del manto silvano della
Sardegna.
All’inizio del secolo la Sardegna conservava integro il suo
grande patrimonio boschivo e le sue foreste, che nei secoli nessuno aveva
toccato. Esse si trovavano nella Nurra, nel grandioso comprensorio di
Santulussurgiu, a Padria, Pozzomaggiore, Bonorva e nella valle di Bolotana. Il
monte di Abbasanta, il Nuorese era tutto una foresta sino ai confini di Dorgali
e Galtellì e, a sud, queste foreste erano contigue a quelle della Barbagia, che
ancora più a sud si univano a quelle dell’Ogliastra. Vi erano poi le foreste
del Sarcidano, quelle di Serpeddì e del monte dei Sette Fratelli e, a ovest di
Cagliari, le foreste coprivano una vasta area continua da Capoterra fino a
tutto l’Iglesiente. Vi erano infine le foreste del monte Arci e del Grighini.
Nella prima metà del secolo iniziò il saccheggio sistematico
di questo immenso patrimonio, con gravi conseguenze per l’equilibrio ambientale
e per l’economia dell’isola. Il primo ad avviare tale saccheggio sistematico fu
il vicerè Thaon del Revel che, nel 1818, consentì ad duca di San Giovanni, un
Vivaldi Pasqua che aveva ereditato il feudo di Siete Fuentes dagli Zatrillas,
di vendere 7.500 querce a due lire l’una ai francesi, che le caricarono a Santa
Caterina di Pitinnuri per Tolone. Alcuni anni dopo lo stesso duca e il marchese
della Planargia fecero altri contratti con speculatori che si erano accordati
con i cantieri genovesi e iniziò la sistematica distruzione delle foreste di
Montiferru. Le concessioni continuarono in tutti i territori feudali, il prezzo
delle piante salì e la stessa amministrazione reale trovò il modo di
guadagnarci, poiché su ogni pianta venduta venne corrisposta una tassa. Invano
in alcune zone, come il Goceano, le popolazioni tentarono di opporsi a questo
disastro. Neanche dopo l’abolizione dei feudi, dopo che le foreste furono
dichiarate demaniali e dopo che nel 1844 fu istituito il corpo delle guardie
forestali, la spoliazione si arrestò. Solo poco illuminati personaggi, come il
conte Alberto Ferrero La Marmora, tentarono inutilmente di bloccarla. Si calcola
che, tra il 1818 e il 1883, siano stati distrutti 194.000 ettari di bosco, pari
al 10% della superficie totale.
Il grande ministro non aveva in molta considerazione la
Sardegna ed era vecchia la storia che attribuiva a Cavour la volontà di
sopprimere l’università di Sassari. Anche i sardi non avevano molta simpatia
per il ministro e lo dimostrarono nelle elezioni dello stesso 1860. E mentre si
compiva il processo di unificazione nazionale, a partire dal giugno 1860 si
disse che lo stesso Cavour volesse cedere l’isola alla Francia in base ad un
trattato segreto, cosa che esasperò gli animi e mortificò i sardi. La voce
venne ripresa e dilatata da alcuni giornali tanto che la questione assunse un
rilievo internazionale, spingendo l’Inghilterra a prendere una posizione contro
l’eventuale cessione che, qualora si fosse concretizzata, avrebbe dato alla
Francia l’egemonia del Mediterraneo. Il governo, ancora l’anno successivo, il
10 luglio 1861, fu costretto a smentire pubblicamente le voci della cessione
mentre l’italianità della Sardegna fu difesa da Mazzini e da Garibaldi.
Mentre l’obiettivo dell’unificazione nazionale era in fase di
realizzazione la Sardegna visse la prima fase conseguente la rinuncia
dell’antica autonomia dopo la “fusione perfetta”. Furono, a partire dal 1848,
anni tormentati nei quali l’isola visse un profondo disagio per il fatto che la
classe politica sarda aveva coscienza di avere rinunciato all’autonomia per
contribuire, a parità di diritti e doveri con altre regioni italiane, al processo
di unificazione nazionale. Si trovava invece di fronte a una serie di problemi
di carattere politico, socio – economico e amministrativo che la “fusione
perfetta” non era stata in grado di risolvere e che, anzi, la prima esperienza
unitaria sembrava potere addirittura accentuare.
Il processo di unificazione nazionale dominò la vita politica
italiana di quegli anni e fece dimenticare la particolarità della situazione
dell’isola, a tal punto da condizionare profondamente in senso negativo le
scelte politiche che nei suoi confronti furono fatte e ad aggravarne la
situazione complessiva. C’è da aggiungere che – come già detto – con la
rinuncia alle antiche leggi la Sardegna si trovò inserita in uno Stato unitario
organizzato in modo accentrato e fu incapace di imporre nel nuovo contesto una
politica rispondente ai propri interessi, anche perché i suoi rappresentanti in
parlamento non furono in grado di elaborarne una.
Fino al 1861 nel parlamento subalpino si susseguirono sette
legislature, ai cui lavori presero parte complessivamente circa cento deputati
sardi, dei quali non pochi furono eletti per più di una legislatura. Il
parlamento approvò, fino al 1858, cinquantaquattro leggi che riguardavano la
Sardegna. Nel complesso l’azione dei ventiquattro deputati eletti nei collegi
nominali fu pesantemente condizionata dalle basi su cui poggiava il meccanismo
elettorale. Infatti gli eletti erano l’espressione di ristrette minoranze non
in grado di comprendere e condividere i reali problemi, spesso espressione di
lotte municipali proprie dei collegi che li avevano espressi. Frequentemente la
loro azione parlamentare veniva condizionata da queste lotte che non avevano
alcun legame con i problemi di carattere generale che avrebbero dovuto
rappresentare. Fu così, nella maggior parte dei casi, che i deputati sardi del
parlamento subalpino furono in genere più attenti a rappresentare interessi
locali piuttosto che i grandi problemi dell’isola.
Pochi deputati seppero sfuggire a questi limiti e quelli che
lo fecero si trovarono isolati in un parlamento che culturalmente non
comprendeva le specialità della condizione sarda e di fronte a un governo che
da subito – il 3 marzo 1849 – scelse la soluzione della nomina del commissario
straordinario. Una scelta, questa, che mostra tutta l’incomprensione nei
confronti della “questione sarda”, o peggio la volontà di mantenere la
posizione di subordinazione dell’isola in termini quasi coloniali.
Nei dodici anni di regno di Vittorio Emanuele II pochi
deputati sardi seppero sfuggire a questa regola e d’altra parte si trovarono
isolati. Si accentuò un diverso trattamento riservato alla Sardegna, certamente
derivante da una inguaribile diffidenza nei confronti dei sardi ma soprattutto
dovuta alla acquiescenza della maggior parte dei politici sardi a questa
politica.
Le capacità del Cavour si palesarono meglio in politica
estera, miranti a ottenere l’alleanza di un grande Stato per affrontare
l’Austria e creare l’unità d’Italia. L’occasione gli fu offerta dalla
spedizione in Crimea schierandosi, il 2 gennaio 1855, con la Francia e
l’Inghilterra contro la Russia, inserendo il piccolo regno di Sardegna nel
gioco della diplomazia internazionale. Fu inviato un corpo di 10.000 uomini al
comando del generale Alfonso La Marmora, contingente che si comportò
onorevolmente prendendo parte alla vittoria della Cernaia e guadagnandone in
morale e prestigio.
Il 25 febbraio 1856, al congresso di Parigi, il regno di
Sardegna partecipò a pieno titolo e Cavour ottenne un grosso successo
diplomatico ponendo in discussione anche il “problema italiano” che attirò
l’attenzione dell’imperatore di Francia Napoleone III e con il quale il
successivo 1858, a Pomblieres, concluse la famosa alleanza antiaustriaca. In
base a questo accordo la Francia, qualora l’Austria avesse aggredito il Regno
di Sardegna, sarebbe intervenuta in suo aiuto.
La tensione internazionale precipitò nel marzo 1859 e
l’Austria, dopo avere subito una serie di abili provocazioni, mosse i primi
passi in vista della guerra. Il 7 aprile le truppe austriache furono mobilitate
e il 23 l’impero intimò al Regno di Sardegna di disarmare ertro tre giorni. Fu
questo un grave errore politico dell’Austria ma era la guerra di aggressione
tanto cercata da Cavour. Il 29 aprile le truppe austriache entrarono in
territorio piemontese: era l’inizio della seconda guerra d’indipendenza. Le
operazioni militari condotte dagli eserciti sardo–piemontese e francese, si
svolsero tra il 29 aprile e il 6 luglio 1859 e, dopo una serie di vittorie a
Montebello, Palestro, Magenta, Solferino e San Martino, dove per gli aspri e
cruenti scontri caddero 22.000 austriaci e 17.000 alleati, si conclusero con
l’armistizio di Villafranca l’11 luglio 1859.
Francesco
Floris a questo punto dice che la difficile situazione interna dell’isola e la
sua progressiva emarginazione dal contesto politico generale, non impedirono
tuttavia ai sardi di prendere parte con entusiasmo, e con il consueto valore,
alle imprese militari che caratterizzarono il periodo. Quando fu decisa la
guerra di Crimea i soldati sardi della leva 1833 erano appena partiti da
Cagliari. Molti di loro furono inquadrati in tutti i reparti della spedizione
unitamente a numerosi ufficiali volontari e di carriera, e si coprirono di
gloria come Alziator, Lostia, Manca e altri. La partecipazione all’impresa
rimase nella memoria collettiva, ma di ben maggiore rilievo fu la
partecipazione dei sardi, inquadrati nei corpi regolari e in quelli volontari,
alla seconda guerra d’indipendenza. Essi furono presenti numerosi nelle battaglie
di Palestro, di San Martino e Magenta. Nel 1860 presero parte alla conquista
delle Marche e dell’Umbria, inquadrati nel corpo di spedizione che si faceva
incontro a Garibaldi. In questa delicata fase va ricordata in particolare la IV
divisione, dove operarono molti soldati sotto il comando di valorosi ufficiali
delle famiglie Pes, Cugia, Grixioni e Castelli.
E
Francesco Cesare Casula precisa che nelle due gloriose campagne di guerra, dal
1848 al 1861, morirono in tutto solo 156 isolani, fra ufficiali e soldati
volontari. Non conosciamo il numero complessivo degli aderenti; ma
evidentemente – aggiunge il Casula – la partecipazione a un Risorgimento
estraneo e lontano non fu molto sentito in Sardegna.
Joaquin
Arce dice a tale proposito che, pur essendo comprensibile il sentimento
patriottico che ha portato in talune occasioni a scoprire in Sardegna una
venatura di italianità ininterrotta, considera giusto segnalare la debolezza di
tale asserzione. E aggiunge di non credere si possa ammettere, per esempio, che
la Barbagia di Nuoro e la Gallura possano essere considerate “oasi di
italianità”. Lo dimostra quanta fatica costò ai Savoia destare nei sardi nuovi
sentimenti di devozione e lealtà, come al contrario accadde nel lungo periodo
in cui la Sardegna fece parte della Corona spagnola.
Diverso
invece fu il contributo di sangue dei sardi nella Prima Guerra Mondiale del
1915/18 che risultò essere percentualmente superiore a qualsiasi altra regione
dell’allora Regno d’Italia.
Con
l’armistizio di Villafranca, Vittorio Emanuele II guadagnò, in cambio di Nizza
e Savoia, la Lombardia austriaca e provocò l’accelerazione del processo di
unificazione politica della penisola. Seguì, l’anno successivo, la richiesta di
annessione al Regno di Sardegna – sancita coi plebisciti popolari del 21/22
ottobre 1860 – del Granducato di Toscana, dei Ducati di Modena e della Romagna
pontificia.
L’impresa
dei Mille di Giuseppe Garibaldi, iniziata il 6 maggio 1860 e conclusa a Teano
il 26 ottobre dello stesso anno, diede a Vittorio Emanuele II e quindi al Regno
di Sardegna anche il Regno delle Due Sicilie e, indirettamente, l’adesione dei
territori papali delle Marche e dell’Umbria. Si compì così la prima unità
d’Italia: mancavano Roma e Venezia.
Nel
periodo tra il 1859 e il 1861 Vittorio Emanuele II impartisce minuziose
disposizioni per porre fine al disordine monetario creatosi con la presenza di
diversi tipi di monete degli ex regnanti e quindi con una fitta serie di
decreti provoca la cessazione del corso legale e demonetizzazione delle vecchie
monete, l’ammissione al corso legale di una unica nuova “ lira ”, il riordino dell’amministrazione delle zecche e quindi la
unificazione del sistema monetario.
La
vita del “Regno di Sardegna” volgeva alla fine. Il 18 febbraio 1861 Vittorio Emanuele
II con un solenne discorso inaugurò a Torino il nuovo Parlamento formato dai
rappresentanti di tutti gli Stati e territori italiani ammessi al Regno di
Sardegna, al fine di esaminare il progetto governativo di unità nazionale. Il
sovrano sorvegliò la discussione, rifiutò il titolo di “re degli italiani” con
l’ordinale iniziale (Vittorio Emanuele I) e, dopo ampio dibattito, finalmente,
il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II firmò col Cavour la legge 4671 che
proclamava il “Regno d’Italia”.
Non
vi fu né in tale occasione, né in altra susseguente alcuna costituzione ex
novo, essa rimase esattamente la stessa concessa al Regno di Sardegna dal re
Carlo Alberto nel 1848. Il parlamento del 1861 fu nella terminologia ufficiale
non il primo, ma l’ottavo. Il re continuò anch’egli a intitolarsi Vittorio
Emanuele “Secondo” e celebrò il suo giubileo nel 1874. L’appellativo di “Regno
d’Italia” è solo il nuovo nome assunto dallo Stato Sardo per cui l’attuale
Stato Italiano non è altro che l’antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi
confini.
Negli
ultimi anni del periodo cavouriano il colera colpì pesantemente l’isola,
provocando nel sassarese circa dodicimila morti e aggiungendo desolazione a
desolazione. Il 6 giugno 1861 moriva, a soli 51 anni, anche Camillo Benso Conte
di Cavour.
Negli
anni successivi Vittorio Emanuele II contribuì a completare l’unificazione con
la terza guerra d’indipendenza e con l’occupazione di Roma, il 20 settembre
1870. In occasione della prima convocazione del Parlamento dell’urbe egli affermò:
“L’opera a cui consacrammo la nostra vita
è compiuta ”.
Vittorio
Emanuele II morì a Roma, nel palazzo del Quirinale, il 9 gennaio 1878.
L’enciclopedia
Motta conclude così la descrizione dell’uomo fra i più significativi della
storia recente d’Italia:
“Vittorio Emanuele II conserva intatte le
simpatie che la storia gli ha concesso vivente, né appare ipocrita adulazione
ma attributo meritato l’appellativo di Re galantuomo datogli dal D’Azeglio”.
BIBLIOGRAFIA
|
ENCICLOPEDIE
|
|
|
Piccola Treccani
|
|
|
Enciclopedia Motta
|
|
|
Grande Dizionario Enciclopedico UTET
|
|
LIBRI
|
|
1.
|
AA.VV. - Alghero
e il suo volto – Carlo Delfino Ed. Sassari
|
|
2.
|
Acta
Curiarum Regni Sardiniae – Consiglio Regionale della Sardegna Ed.
1986/1998
|
|
3.
|
Francesco ALZIATOR – L’elefante sulla Torre Itinerario cagliaritano – 3 T Ed. Cagliari
1982
|
|
4.
|
Bruno ANATRA – La Sardegna dall’unificazione Aragonese ai Savoia – Utet Libreria
1987
|
|
5.
|
Joaquin ARCA – La Spagna in Sardegna –T.E.A. Ed. Cagliari 1982
|
|
6.
|
Alberto BOSCOLO – La politica italiana di Martino il Vecchio re d’Aragona – Padova
1962
|
|
7.
|
Alberto BOSCOLO – La politica mediterranea dei sovrani d’Aragona – Medioevo saggi e
rassegne n. 3 – Sarda Fossataro Ed. Cagliari 1977
|
|
8.
|
Alberto BOSCOLO – La Sardegna bizantina – Chiarella Ed.
|
|
9.
|
Roberto BRUNELLI – Storia di Gerusalemme – Mondadori Ed. 1990
|
|
10.
|
Raimondo CARTA RASPI – Breve storia di Sardegna – Il Nuraghe Ed. Cagliari 1950
|
|
|
|
|
11.
|
Francesco Cesare CASULA - La Cancelleria sovrana dell’Arborea (1297-1410) – Medioevo saggi
e rassegne n. 3 – Sarda Fossataro Ed. Cagliari 1977
|
|
12.
|
Francesco Cesare CASULA – Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese – Della Torre
Ed. Cagliari 1982
|
|
13.
|
Francesco Cesare CASULA – Sardegna catalano-aragonese – 2D Ed. Mediterranea Sassari 1984
|
|
14.
|
Francesco Cesare CASULA – Il Regno di Sardegna – Editalia 1995
|
|
15.
|
Francesco Cesare CASULA – Cagliari capitale di un regno – Editalia 1995
|
|
16.
|
Francesco FLORIS – Storia della Sardegna – Newton Compton Ed. Roma 1999
|
|
17.
|
Francesco FLORIS – I sovrani d’Italia – Newton Compton Ed. Roma 2000
|
|
18.
|
Barbara FOIS – Lo stemma dei quattro mori – Breve storia dell’emblema dei sardi
– Carlo Delfino Ed. Sassari 1990
|
|
19.
|
Francesco LODDO CANEPA – La Sardegna dal 1478 al 1720
|
|
20.
|
Barone Giuseppe MANNO – Storia di Sardegna – Ristampa anastatica di Gianni Trois Ed.
Cagliari 1973
|
|
21.
|
Filippo MAZZONIS – La monarchia e il risorgimento – Il Mulino Ed. 2003
|
|
22.
|
Gianni OLIVA – I Savoia – Arnoldo Mondadori Ed. 1998
|
|
23.
|
Omero PINNA e Luca ALAGNA – Le monete dei Savoia – Sardus Pater Ed. Cagliari 1998
|
|
24.
|
Enrico PIRAS – Le monete della Sardegna – Fondazione del Banco di Sardegna
Sassari 1996
|
|
25.
|
Luigi SANDRI – La città santa e lacerata – Monti Ed.
|
|
RIVISTE
|
|
|
MEDIOEVO – Anno 1 n. 4 maggio 1997
|
|
|
Anno 1 n. 9 ottobre 1997
Ed. De Agostini – Rizzoli Periodici Milano
|
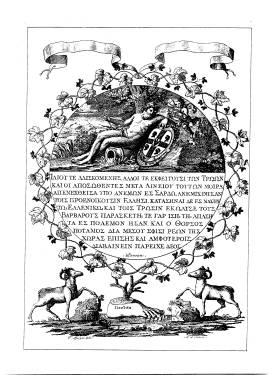

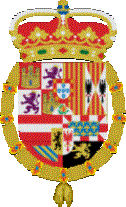





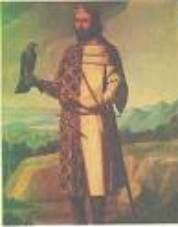



 Giovanni
II il Senza Fede successe al fratello Alfonso V il Magnanimo nel 1458. Il suo
regno fu disastroso per la confederazione iberica a causa del dispotismo senza
scrupoli del monarca il quale combattè contro figli, parenti e sudditi facendo
precipitare il paese in una delle più brutte guerre civili della storia.
Giovanni
II il Senza Fede successe al fratello Alfonso V il Magnanimo nel 1458. Il suo
regno fu disastroso per la confederazione iberica a causa del dispotismo senza
scrupoli del monarca il quale combattè contro figli, parenti e sudditi facendo
precipitare il paese in una delle più brutte guerre civili della storia.



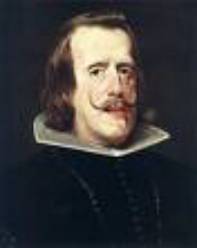



 Figlio
di Carlo Emanuele II succede al padre nel 1675 all’età di nove anni, nella
guida del Ducato d’Aosta e del Principato di Piemonte e sotto la reggenza della
madre Giovanna Battista di Nemurs che si protrarrà sino al 1684.
Figlio
di Carlo Emanuele II succede al padre nel 1675 all’età di nove anni, nella
guida del Ducato d’Aosta e del Principato di Piemonte e sotto la reggenza della
madre Giovanna Battista di Nemurs che si protrarrà sino al 1684. Carlo
Emanuele III , piccolo di statura e gracile, successe al trono nel 1730
all’abdicazione del padre Vittorio Amedeo II nel 1730. Egli era appena salito
sul trono che fu coinvolto nella guerra di successione polacca e combattè al
fianco di Spagna e Francia contro Austria, Russia e Prussia. Grazie all’abilità
dei suoi comandanti occupò nel 1734 la Lombardia imperiale, mentre l’anno dopo
gli Alleati, col concorso di alcune compagnie sarde, cacciarono gli austriaci
anche da Palermo. Purtroppo, la pace di Vienna del 1738 ritolse al regno di
Sardegna la Lombardia, lasciandogli Novara e Tortona.
Carlo
Emanuele III , piccolo di statura e gracile, successe al trono nel 1730
all’abdicazione del padre Vittorio Amedeo II nel 1730. Egli era appena salito
sul trono che fu coinvolto nella guerra di successione polacca e combattè al
fianco di Spagna e Francia contro Austria, Russia e Prussia. Grazie all’abilità
dei suoi comandanti occupò nel 1734 la Lombardia imperiale, mentre l’anno dopo
gli Alleati, col concorso di alcune compagnie sarde, cacciarono gli austriaci
anche da Palermo. Purtroppo, la pace di Vienna del 1738 ritolse al regno di
Sardegna la Lombardia, lasciandogli Novara e Tortona.